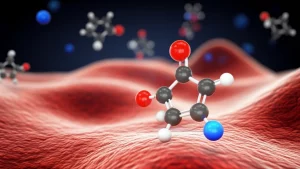Leishmaniosi Viscerale: Un Nemico Silenzioso che Stiamo (Forse) Sconfiggendo?
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che forse non sentite nominare tutti i giorni, ma che rappresenta un problema di salute pubblica non da poco in diverse parti del mondo: la Leishmaniosi Viscerale (LV). Magari la conoscete con il suo nome più sinistro, kala-azar. Ho messo le mani su uno studio freschissimo, il Global Burden of Disease (GBD) study 2021, che ha analizzato l’andamento di questa malattia dal 1990 al 2021, e voglio condividere con voi quello che ho scoperto. Preparatevi, perché ci sono luci e ombre.
Cos’è esattamente la Leishmaniosi Viscerale?
Prima di tuffarci nei numeri, capiamo di cosa stiamo parlando. La leishmaniosi è una malattia parassitaria causata da protozoi del genere Leishmania. Come ci arriva? Attraverso la puntura di piccoli insetti volanti infetti, i flebotomi, che noi chiamiamo comunemente pappataci. Esistono diverse forme di leishmaniosi, ma quella viscerale è la più grave. Perché? Perché colpisce organi vitali come la milza, il fegato e il midollo osseo. I sintomi non sono piacevoli: febbre ricorrente, perdita di peso, ingrossamento di fegato e milza (epatosplenomegalia) e anemia. Pensate che, senza un trattamento tempestivo, la mortalità supera il 95%! Capite bene perché l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la consideri una delle principali malattie tropicali neglette.
Il quadro globale: cosa dicono i dati dal 1990 al 2021?
Allora, veniamo allo studio GBD 2021. La buona notizia? A livello globale, sembra che stiamo facendo qualche passo avanti. Dal 1990 al 2021, i tassi standardizzati per età di incidenza (nuovi casi), prevalenza (casi totali), mortalità e DALYs (anni di vita persi o vissuti con disabilità a causa della malattia) sono diminuiti. Sì, avete letto bene:
- Tasso di incidenza (ASIR): in calo (AAPC = -0.25%)
- Tasso di prevalenza (ASPR): in calo (AAPC = -0.06%)
- Tasso di mortalità (ASMR): in calo (AAPC = -0.03%)
- Tasso di DALY (anni persi/vissuti con disabilità): in calo significativo (AAPC = -2.38%)
Questo trend discendente è incoraggiante e probabilmente riflette i progressi nella diagnosi precoce, nei trattamenti (come l’amfotericina B), nel controllo dei vettori (i pappataci) e in una maggiore consapevolezza generale. Sembra che gli sforzi stiano dando i loro frutti, almeno su scala globale.
Dove colpisce di più? La geografia della Leishmaniosi Viscerale
Nonostante il calo globale, la LV non è distribuita uniformemente. Lo studio conferma che il peso maggiore della malattia si concentra in specifiche aree geografiche, soprattutto quelle con un basso Indice Socio-Demografico (SDI). Parliamo di regioni come l’America Latina tropicale, il Medio Oriente, l’Africa (in particolare Africa Orientale e Subsahariana) e l’Asia Meridionale. Nel 2021, le regioni a basso SDI avevano i tassi più alti per tutti gli indicatori (incidenza, prevalenza, mortalità, DALYs), mentre quelle ad alto SDI avevano i più bassi. C’è una chiara correlazione negativa: più basso è lo sviluppo socio-economico, più alto è il rischio di LV. Questo ci dice molto su dove concentrare gli sforzi. L’America Latina Tropicale, ad esempio, nel 2021 registrava i tassi più alti in assoluto.

Chi rischia di più? Età e genere
Lo studio GBD 2021 rivela anche pattern interessanti riguardo all’età e al genere. Una cosa che salta all’occhio è che, in tutte le fasce d’età, i maschi mostrano tassi di incidenza (ASIR) e prevalenza (ASPR) costantemente più alti rispetto alle femmine. Perché? Le ragioni potrebbero essere diverse:
- Esposizione occupazionale e ambientale: Gli uomini, in molte aree endemiche, sono più spesso coinvolti in attività all’aperto (agricoltura, costruzione) che aumentano il contatto con i pappataci.
- Comportamenti e stile di vita: Magari partecipano più frequentemente ad attività sociali o notturne, quando i pappataci sono più attivi.
- Accesso alle cure: In alcune culture, gli uomini potrebbero cercare assistenza medica più prontamente, portando a tassi di diagnosi più alti, mentre le donne potrebbero incontrare più barriere.
Un altro dato preoccupante riguarda l’età: il tasso di mortalità standardizzato per età (ASMR) è risultato più alto nei bambini sotto i 5 anni. Sebbene un sistema immunitario meno sviluppato possa contribuire, la ragione principale sembra essere la maggiore incidenza e prevalenza in questa fascia d’età. Insomma, i più piccoli si ammalano di più e, di conseguenza, rappresentano una quota maggiore dei decessi totali per LV.
Non solo buone notizie: tendenze in aumento e “punti caldi”
Attenzione però a non cantar vittoria troppo presto. Se a livello globale i tassi scendono, lo stesso non si può dire per tutte le regioni. Tra il 1990 e il 2021, i tassi di incidenza e mortalità sono addirittura aumentati in Asia Centrale e nell’Africa Subsahariana Occidentale. Anche a livello di singoli paesi, la situazione è variegata. Nel 2021, il Sud Sudan ha registrato i tassi più alti in assoluto per tutti gli indicatori. Altri paesi con un carico elevato includono la Repubblica Centrafricana, il Brasile, Gibuti, il Ciad e il Niger.
E poi c’è un caso curioso: Monaco. Non proprio il primo posto che ti verrebbe in mente parlando di malattie tropicali, eppure ha visto l’aumento relativo più marcato (AAPC più alto) nei tassi tra il 1990 e il 2021. Probabilmente, essendo un hub internazionale, ha visto un aumento dei casi importati che potrebbero aver innescato una trasmissione locale. Questo ci ricorda l’importanza della sorveglianza anche in aree non tradizionalmente endemiche. È fondamentale, però, distinguere tra aumento relativo (AAPC) e carico assoluto: un grande aumento percentuale in un paese con pochissimi casi iniziali non ha lo stesso peso di un aumento minore in un paese con un’alta endemia.
Perché il calo (dove c’è stato) e cosa lo frena?
Abbiamo accennato ai motivi del calo globale: migliori diagnosi, terapie più efficaci, controllo dei vettori, maggiore consapevolezza. Ma ci sono anche fattori che remano contro. La co-infezione con l’HIV, ad esempio, complica il trattamento della LV e aumenta il rischio di ricadute. Inoltre, cambiamenti ambientali come l’urbanizzazione, il riscaldamento globale e le modifiche nei pattern delle precipitazioni possono espandere l’habitat dei pappataci, portando la malattia in nuove aree o aumentandone i casi in quelle già endemiche.

Cosa possiamo fare? L’approccio “One Health”
Come affrontare una sfida così complessa? Lo studio suggerisce, e io sono d’accordo, che serve un approccio integrato, quello che viene chiamato “One Health” (Una Sola Salute). Questo significa considerare la salute umana, quella animale (i cani, ad esempio, sono importanti serbatoi del parassita) e quella ambientale come strettamente interconnesse. Serve una collaborazione stretta tra sanità pubblica, medicina veterinaria e scienze ambientali per:
- Migliorare la sorveglianza e creare sistemi di allerta precoce.
- Ridurre gli habitat dei pappataci con interventi ambientali mirati.
- Sviluppare e distribuire equamente vaccini (per umani e animali).
- Aumentare la consapevolezza pubblica sulla trasmissione e sulla prevenzione.
- Rafforzare il supporto politico, le risorse, la ricerca e la collaborazione internazionale.
Un’ultima nota di cautela: i limiti dei dati
È giusto ricordare che anche uno studio imponente come il GBD ha i suoi limiti. La qualità delle stime dipende dalla disponibilità e dall’accuratezza dei dati di partenza, che possono variare molto da paese a paese. Soprattutto nei paesi a basso e medio reddito, la sotto-segnalazione dei casi è un problema reale. I modelli statistici usati sono sofisticati, ma si basano pur sempre su dati che possono avere delle lacune.
In conclusione: la lotta continua
Tirando le somme, lo studio GBD 2021 ci dice che, globalmente, stiamo facendo progressi contro la Leishmaniosi Viscerale, con tassi in calo negli ultimi 30 anni. Tuttavia, la malattia rimane un problema serio e spesso sottovalutato in molte regioni del mondo, colpendo in modo sproporzionato i maschi e i bambini molto piccoli. Le tendenze in aumento in alcune aree e l’impatto di fattori come HIV e cambiamenti climatici ci ricordano che non possiamo abbassare la guardia. C’è un bisogno urgente di misure di controllo più efficaci, maggiore consapevolezza e, soprattutto, una forte collaborazione internazionale. La battaglia contro questo nemico silenzioso è tutt’altro che vinta.
Fonte: Springer