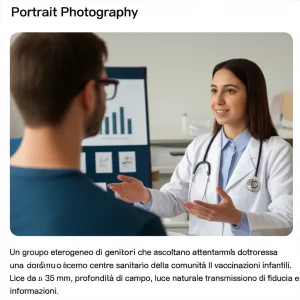LCA: Il Mito delle Decisioni Informate nell’Edilizia (e Perché Dovremmo Guardare Oltre)
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi ronza in testa da un po’: la Life Cycle Assessment, o LCA. Per decenni, l’abbiamo vista come la bacchetta magica per rendere i nostri prodotti più “verdi”. L’idea è semplice, quasi lineare: fai uno studio LCA bello preciso, ottieni dati sull’impatto ambientale, prendi decisioni “informate” e voilà, il prodotto diventa più sostenibile. Bello, no? Peccato che, come spesso accade, la realtà sia un tantino più complicata e, oserei dire, affascinante.
Mi sono imbattuto in uno studio etnografico pazzesco che ha seguito per ben 3 anni un progetto di sviluppo di un prodotto per l’edilizia, mettendo sotto la lente d’ingrandimento proprio l’uso dell’LCA. E sapete cosa è emerso? Che quel bel modello lineare “studio LCA -> decisione informata -> meno impatto” spesso scricchiola. Anzi, a volte non funziona proprio come ce lo aspettiamo.
L’Illusione della Linearità: Quando l’LCA Non Segue il Copione
Pensiamoci un attimo. L’LCA nasce con l’ambizione di guidare le scelte, di darci quella bussola scientifica per navigare le complesse acque della sostenibilità. Ci si aspetta che uno studio LCA ben fatto porti direttamente a una riduzione tangibile degli impatti ambientali. Eppure, quante volte abbiamo visto studi LCA impeccabili rimanere lì, su una scrivania o in un file, senza tradursi in azioni concrete? Tante, troppe volte.
Lo studio che ho letto mette in luce proprio questo: l’efficacia *sostanziale* dell’LCA, cioè la sua capacità di cambiare davvero le cose nel mondo reale, non è così scontata. Non basta avere informazioni accurate; serve che queste informazioni influenzino le azioni lungo tutta la filiera del prodotto. E qui casca l’asino.
Il problema non è (solo) il greenwashing o l’uso simbolico dell’LCA per darsi una verniciata di verde. Il punto è che anche quando le intenzioni sono le migliori, trasformare i risultati di un’analisi in un cambiamento effettivo è un percorso a ostacoli. Ci siamo concentrati così tanto sull’accuratezza e l’efficienza dell’LCA come *metodo* che forse abbiamo perso di vista il suo scopo finale: ridurre davvero l’impatto ambientale.

Il Caso Studio: L’LCA in Azione (o Quasi) in un Progetto Edilizio
Immergiamoci nel caso pratico. Un’importante azienda di costruzioni svedese decide di sviluppare un nuovo prodotto edilizio residenziale standardizzato. L’obiettivo? Renderlo più sostenibile, anche in vista di future normative più stringenti. L’LCA viene messa al centro del progetto, quasi come un faro guida. Viene fissato un obiettivo ambizioso: ridurre le emissioni di CO2 equivalente del 30%. Sembra tutto perfetto, no? Un obiettivo chiaro, uno strumento scientifico per misurarlo… cosa potrebbe andare storto?
Beh, parecchie cose, o meglio, parecchie cose non sono andate come previsto dal “manuale” dell’LCA. Lo studio ha seguito il progetto per tre anni, analizzando interviste, osservazioni dirette e una montagna di documenti, inclusi ben cinque studi LCA diversi realizzati in varie fasi.
Le Sei “Deviazioni” dalla Norma: Come l’LCA Influenza Davvero
L’analisi ha rivelato che l’influenza dell’LCA sul progetto è stata tutt’altro che una linea retta. Invece di una semplice catena “studio -> decisione”, si è trattato di una sequenza complessa di eventi, studi diversi, attività collaterali e risultati a volte inaspettati. Sono emerse sei “deviazioni” principali dal modello lineare classico:
- Molteplicità: Non c’era un solo LCA “principe”, ma diversi studi (alcuni fatti internamente, altri esternamente, alcuni prima del progetto) che si sono intrecciati e sovrapposti, influenzando il progetto in modi diversi e non sempre diretti.
- Effetti Parziali: L’LCA era solo uno dei tanti fattori in gioco. Decisioni tecniche, costi, normative energetiche, certificazioni volontarie… tutto contribuiva a definire il prodotto finale. L’LCA non aveva l’esclusiva sulla “verità” ambientale.
- Effetti Spostati (Displaced Effects): Qui la cosa si fa interessante! Spesso, le intuizioni più utili non venivano dagli LCA commissionati *per* quel progetto, ma da studi precedenti o esterni. Un paper di ricerca esterno, ad esempio, ha avuto un impatto enorme nell’indirizzare le scelte progettuali iniziali, molto più degli LCA fatti “su misura” ma arrivati magari troppo tardi. Le idee viaggiano, anche tra progetti e organizzazioni diverse!
- Effetti Basati sull’Attività (Activity-Based Effects): Questo è cruciale. Non sono stati solo i *risultati* degli LCA a fare la differenza, ma il *processo* stesso di farli. Le discussioni per definire gli obiettivi e lo scopo (goal and scope), la raccolta dati, le interazioni tra l’analista LCA e gli ingegneri… queste attività hanno generato conoscenza, consapevolezza e cambiamenti nel design, a volte anche prima che lo studio fosse concluso!
- Attori e Attività Eterogenei: Il cambiamento non dipende solo dall’analista LCA e dal “decisore”. Ingegneri, project manager, gruppi di riferimento, norme professionali, persino le proprietà intrinseche dei materiali… tutti questi “attori” (umani e non) interagiscono e influenzano il risultato. L’LCA è parte di una rete complessa.
- Direzionalità a Doppio Senso: Il modello lineare vede una freccia che va dall’LCA alla decisione. La realtà è più un dialogo. L’LCA influenza il progetto, certo, ma anche le esigenze del progetto, le pratiche aziendali e le preferenze degli attori influenzano *come* viene fatto l’LCA, quali dati si usano, quali scenari si considerano “realistici”. È uno scambio reciproco.

Prendiamo l’esempio degli studi LCA fatti durante le fasi di progettazione (programma e dettaglio). In teoria, dovevano essere i più influenti. In pratica? I risultati arrivavano spesso *dopo* che le decisioni chiave sul design (come l’assottigliamento delle strutture portanti in calcestruzzo) erano già state prese, magari sulla base di studi precedenti, discussioni interne o input da esperti esterni. Gli LCA finivano per *confermare* a posteriori le scelte, piuttosto che guidarle attivamente. Una bella inversione di rotta rispetto al modello classico!
Superare il Mito: Verso Modelli di Utilizzo dell’LCA Più Realistici
Cosa ci insegna tutto questo? Che aggrapparci al modello lineare “informazione -> decisione” è riduttivo e, francamente, rischia di deluderci. Ci porta a concentrarci sull’efficienza e l’accuratezza nel *produrre* l’informazione, trascurando come quell’informazione (e il processo per ottenerla) possa effettivamente *generare* un cambiamento sostanziale.
Lo studio propone di pensare all’efficacia dell’LCA attraverso modelli alternativi, più aderenti alla realtà:
- Modello Complesso Basato sulla Conoscenza: Riconosce che la conoscenza LCA proviene da fonti multiple (non solo lo studio ad hoc), che ha effetti parziali e che può “viaggiare” (effetti spostati). Invita a un uso più strategico e pragmatico della conoscenza esistente, commissionando nuovi studi solo quando servono davvero a colmare lacune specifiche per ottenere effetti concreti. Si tratta di imparare e riutilizzare.
- Modello Lineare Basato sull’Attività: Sposta il focus dai risultati alle *attività* del fare LCA. Riconosce che definire obiettivi, raccogliere dati, interagire con i team sono fonti di cambiamento potenti, indipendentemente dal report finale. Suggerisce di valorizzare e progettare queste attività per massimizzarne l’impatto.
- Modello Complesso Basato sull’Attività: È la visione più ampia. Considera l’LCA come parte di una rete di attori, pratiche e influenze eterogenee (tecniche, economiche, normative, sociali). Riconosce l’interazione a doppio senso tra LCA e progetto. Invita a guardare oltre lo strumento LCA e a capire come le diverse pratiche (LCA, eco-design, ingegneria, management) interagiscono per produrre (o non produrre) cambiamenti sostenibili.

Quindi, l’LCA è Inutile? Assolutamente No!
Attenzione, non sto dicendo che l’LCA sia inutile o che non serva a nulla. Tutt’altro! Nel caso studiato, l’LCA ha comunque contribuito a ridurre l’impatto del prodotto (anche se forse non del 30% sperato inizialmente e non sempre per le vie “ufficiali”), ha aumentato la consapevolezza sull’importanza delle quantità dei materiali, ha permesso di valutare alternative in modo neutro e ha persino fornito argomenti (ironicamente) per sostenere soluzioni diverse in futuro.
Il punto è che dobbiamo smetterla di venerare il mito della decisione perfettamente informata e razionale che scaturisce magicamente da un report LCA. Dobbiamo abbracciare la complessità, riconoscere che l’efficacia dell’LCA dipende da come si integra nei processi reali, dalle interazioni che genera, dalla conoscenza pregressa che mobilita e dalle attività che mette in moto.
Forse, invece di ossessionarci solo sulla precisione dei dati (che resta importante, sia chiaro!), dovremmo chiederci di più: come possiamo usare l’LCA – sia i suoi risultati che le sue attività – in modo più strategico e integrato per *facilitare* davvero le azioni che riducono l’impatto ambientale? Come possiamo far sì che le intuizioni LCA “viaggino” meglio tra progetti e team? Come possiamo valorizzare le interazioni che nascono *durante* il processo LCA?
È una sfida affascinante, che ci costringe a guardare l’LCA non solo come uno strumento tecnico, ma come una pratica sociale e organizzativa. E credo che esplorare queste domande sia fondamentale se vogliamo che l’LCA mantenga la sua promessa di aiutarci a costruire un futuro davvero più sostenibile.
Fonte: Springer