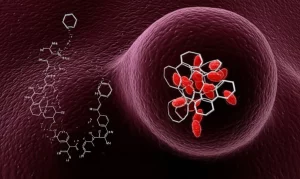Ivermectina e COVID-19: Viaggio al Centro di una Tempesta tra Scienza, Politica e “Fake News”
Amici scienziati e curiosi di scienza, preparatevi per un’immersione in uno degli argomenti più caldi e controversi degli ultimi anni: l’ivermectina e il suo presunto ruolo nella lotta contro il COVID-19. Vi prometto un’analisi che va oltre i titoli dei giornali, scavando nei meandri della ricerca farmacologica e bibliometrica, con un occhio critico ma sempre affascinato dalle dinamiche della scienza.
Fin dall’inizio della pandemia, nel marzo 2020, la comunità scientifica mondiale si è lanciata in una corsa contro il tempo per trovare farmaci efficaci contro il SARS-CoV-2. Tra i tanti candidati, l’ivermectina ha catturato l’attenzione. Nata come farmaco antielmintico, cioè per combattere le infezioni parassitarie negli animali e nell’uomo, si è ipotizzato potesse inibire la replicazione virale. E qui, lasciatemi dire, la cosa si fa interessante (e un po’ preoccupante).
Ma cos’è esattamente l’Ivermectina?
L’ivermectina fa parte della famiglia delle avermectine, prodotti della fermentazione del batterio Streptomyces avermectinus. Pensate che la scoperta di queste sostanze valse il Premio Nobel per la Medicina a Satoshi Ōmura nel 2015! Questo farmaco è un vero e proprio “killer” di parassiti, agendo sui canali del cloro e sui recettori GABA nelle cellule nervose di nematodi e artropodi, portandoli alla paralisi e alla morte. In veterinaria è un must per bovini, cavalli, pecore e suini. In medicina umana, si usa per trattare scabbia, pediculosi, miasi, loiasi, oncocercosi, rosacea e strongiloidiasi.
Ma non è tutto: l’ivermectina ha mostrato, in studi in vitro, anche proprietà anti-cancerogene, anti-infiammatorie e antivirali. Ad esempio, è stata vista agire come inibitore dell’elicasi del DNA in virus come il poliomavirus BK, il virus della pseudorabbia, il circovirus suino 1 e l’herpesvirus bovino 1. Addirittura, inibisce la replicazione dell’HIV bloccando il complesso importina-α/β-1 e l’elicasi dell’RNA in virus come dengue, febbre gialla, West Nile e l’encefalite equina venezuelana.
Il “Repurposing” dei Farmaci: Una Strategia Intelligente
Quando si parla di usare un farmaco approvato per una malattia per trattarne un’altra, entriamo nel campo del “repurposing“. Questa strategia è fantastica perché offre vantaggi enormi:
- Tempo ridotto: Si parte da una base di ricerca esistente, accorciando i tempi tra l’idea e l’applicazione.
- Costi inferiori: Le proprietà farmacologiche di base sono già note.
- Minori rischi di effetti avversi: La sicurezza del farmaco è già stata ampiamente testata.
Insomma, il repurposing è una carta vincente, specialmente in situazioni di emergenza come una pandemia.
L’Ipotesi Ivermectina contro SARS-CoV-2
Durante la pandemia COVID-19, è nata l’ipotesi che l’ivermectina potesse contrastare il SARS-CoV-2. Il razionale? Il SARS-CoV-2, essendo un virus a ssRNA a filamento positivo, usa il complesso importina α/β1 per il trasporto nella cellula, lo stesso bersaglio dell’ivermectina in altri virus. Uno studio in vitro di Caly et al. (2020) fece molto scalpore: somministrando ivermectina a cellule Vero/hSLAM infettate con COVID-19, osservarono una riduzione di 5000 volte della carica virale dopo 48 ore, con una concentrazione di 5 µM. Sembrava una svolta!
Tuttavia, qui iniziano i “ma”. Altri ricercatori, come Schmith et al., hanno subito sottolineato che la concentrazione usata da Caly et al. era 35 volte superiore alla massima concentrazione plasmatica (Cmax) raggiungibile con le dosi approvate del farmaco. Un dosaggio eccessivo, insomma.

La Politica Scende in Campo (e la Scienza Trema)
Nonostante i dubbi, i dati di Caly et al. sono stati cavalcati da alcuni partiti politici per promuovere l’ivermectina come profilassi o terapia alternativa ai vaccini. In Austria, il Partito della Libertà (FPÖ), con Herbert Kickl, ne raccomandò l’uso nel dicembre 2021. In Germania, l’Alternative für Deutschland (AfD) fece richieste simili. E la questione è ancora viva, tanto da essere ripresa persino in trasmissioni satiriche come “Heute-Show” in Germania, o negli USA con la vittoria di Donald Trump e la nomina di R. Kennedy a Segretario della Salute, nonostante una lettera aperta di 77 premi Nobel contro la sua scelta. Questo dimostra quanto la politica sanitaria sia intrecciata con poteri globali, fiducia nelle istituzioni e ideologie.
Le principali autorità sanitarie, come FDA (5 marzo 2021), EMA (22 marzo 2021) e OMS (31 marzo 2021), hanno tutte sconsigliato l’uso dell’ivermectina per il COVID-19 al di fuori degli studi clinici randomizzati. Ma il dibattito, ahimè, è andato avanti.
Un’Analisi Farmacologica e Bibliometrica: Cosa Abbiamo Fatto?
Per vederci chiaro in questa intricata matassa tra propaganda politica e scienza, abbiamo condotto un’analisi farmacologica e bibliometrica delle pubblicazioni sull’ivermectina e il COVID-19 indicizzate su PubMed e Web of Science tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. Abbiamo setacciato 1039 pubblicazioni, escludendone alcune per vari motivi (lingua, preprints non pertinenti, testi non disponibili, correzioni, ritrattazioni, studi ambientali), arrivando a un pool finale di 894 pubblicazioni (487 da PubMed, 407 da Web of Science).
Per ogni pubblicazione abbiamo analizzato: paese di pubblicazione, numero e tipo di farmaci menzionati, tipo di documento, inclusione di preprints nelle fonti, frequenza di citazione, opinione degli autori sull’efficacia dell’ivermectina e tempo tra sottomissione e pubblicazione.
Cosa Abbiamo Scoperto? Un Mare di Dati
I risultati sono affascinanti e, per certi versi, allarmanti. Ci concentreremo sui dati di PubMed, essendo i risultati delle due banche dati abbastanza omogenei.
- Geografia delle Pubblicazioni: India, USA e Brasile sono i paesi con il maggior numero di pubblicazioni. Non a caso, sono stati tra i più colpiti dalla pandemia, il che suggerisce un’intensa attività di ricerca.
- Farmaci Sotto la Lente: Nel 2020 e 2021, i farmaci antivirali erano i più menzionati. Nel 2022, l’attenzione si è spostata su farmaci per l’infiammazione/malattie autoimmuni, e c’è stato un aumento dell’interesse per ingredienti erboristici. L’ivermectina, l’idrossiclorochina/clorochina e il remdesivir sono rimasti costantemente tra i più discussi.
- Tipi di Documenti: Le “reviews” (rassegne) sono state il tipo di documento più frequente nei tre anni. Questo è un po’ sbilanciato, perché all’inizio della pandemia molte rassegne si basavano sugli stessi pochi studi originali, con un potenziale calo di qualità.
- Il Problema dei Preprints: L’India spicca per l’alta percentuale di pubblicazioni di “categoria 3” (quelle con minor valore scientifico secondo la nostra classificazione, come lettere all’editore o editoriali non richiesti) e, cosa ancora più critica, due terzi di queste pubblicazioni in India citavano “preprints” (articoli non ancora sottoposti a peer review) nelle loro bibliografie. Durante le crisi, i preprints possono accelerare la diffusione dei risultati, ma aumentano il rischio di errori e disinformazione. Sebbene la percentuale di preprints citati sia diminuita nel tempo in India e USA (suggerendo un maggior ricorso alla peer review), il loro uso iniziale massiccio è un campanello d’allarme.

- Citazioni e Casi COVID-19: La frequenza delle citazioni delle pubblicazioni sull’ivermectina ha seguito, con un leggero ritardo, l’andamento dei casi di COVID-19. Questo, nonostante gli avvertimenti delle istituzioni sanitarie, mostra quanto la propaganda politica possa influenzare il dibattito scientifico e la percezione pubblica.
- Velocità di Pubblicazione vs Qualità: Inizialmente, i tempi tra sottomissione e pubblicazione si sono accorciati drasticamente (in media del 49% per gli articoli sul COVID-19!). Questo è cruciale in un’emergenza, ma aumenta il rischio di debolezze metodologiche. Col tempo, specialmente per le pubblicazioni di minor qualità (categoria 3), i tempi di elaborazione sono aumentati, forse indicando un maggiore controllo. È interessante notare che le pubblicazioni di categoria 1 (studi clinici randomizzati, meta-analisi) avevano tempi di pubblicazione più brevi rispetto alla categoria 3. L’analisi ANOVA ha confermato differenze significative nei tempi di pubblicazione tra gli anni 2020-2022 per le categorie 1, 2 e 3, ma non per la categoria “studio” generica.
- Opinioni sull’Efficacia: Il numero di pubblicazioni che esprimevano un parere negativo sull’efficacia dell’ivermectina è aumentato di sette volte tra il 2020 e il 2022, mentre quelle con opinione affermativa sono diminuite. Un segnale incoraggiante!
Gli Argomenti (Spesso Fallaci) a Favore dell’Ivermectina
Abbiamo identificato 14 argomenti principali usati per giustificare la prescrizione dell’ivermectina. I più comuni? La sua approvazione da lungo tempo e l’alto profilo di sicurezza (per le indicazioni originali, sia chiaro!), la disponibilità globale e il basso costo. Altri argomenti includevano l’ampio spettro antivirale in vitro, l’uso profilattico in alcuni paesi, il supporto al sistema immunitario e l’uso precoce per controllare la replicazione virale.
Usando un sistema a semaforo, abbiamo classificato la validità di questi argomenti. Molti, purtroppo, finiscono nel rosso:
- Approvazione e sicurezza per altre indicazioni (non trasferibile automaticamente al COVID-19).
- Disponibilità e costo (non sono prove di efficacia).
- Spettro antivirale in vitro (spesso a dosi non raggiungibili in vivo senza tossicità).
- Uso profilattico/minori casi in certi paesi (correlazione non implica causalità, molti fattori confondenti).
- Prevenzione della tempesta citochinica (meccanismo non provato per SARS-CoV-2 alle dosi sicure).
- Efficace contro SARS-CoV-1, quindi anche SARS-CoV-2 (un’ipotesi, non un fatto).
Questi argomenti, estrapolati dal contesto o applicati in modo errato, non giustificano l’uso dell’ivermectina per il COVID-19.
Il Caso Caly et al. Sotto la Lente (Ancora una Volta)
Molte pubblicazioni pro-ivermectina si aggrappano allo studio di Caly et al. (2020). Ricordate? Riduzione virale di 5000 volte in vitro. Peccato che per raggiungere la concentrazione di 5 µM nel plasma umano servirebbe una dose di 14.44 mg/kg, mentre la FDA ha approvato solo 0.2 mg/kg per la strongiloidiasi. A dosi così elevate, la tossicità sarebbe notevole (la dose letale LD50 negli animali è 50 mg/kg). Lo studio di Caly et al. è stato sottomesso il 18/03/2020 e pubblicato il 03/04/2020: solo 16 giorni! Viene da chiedersi che tipo di peer review approfondita sia stata possibile. Non sorprende che nel 2020, l’89% delle pubblicazioni favorevoli all’ivermectina concordasse con i risultati di Caly et al. (percentuale scesa al 65% nel 2022, ma sempre alta).

Studi di Molecular Docking: Un Altro Capitolo Critico
Abbiamo analizzato anche gli studi di “molecular docking” (simulazioni al computer di come una molecola si lega a una proteina). Qui, il caos regna sovrano: bersagli inconsistenti, metodologie divergenti, mancanza di analisi precise dei siti di legame. Spesso, questi studi non sono supportati da ulteriori ricerche sperimentali e mancano di rigore nella valutazione della dinamica proteica o della qualità della struttura 3D della proteina bersaglio.
Le Pubblicazioni Più Citate: Qualità Sotto Esame
Abbiamo esaminato le 7 pubblicazioni su PubMed (e 4 su Web of Science) con più di 95 citazioni. L’obiettivo? Valutare la loro qualità metodologica. I risultati? Un disastro, in molti casi.
Lo studio di Caly et al., con 634 citazioni, è il più emblematico. Oltre alla già discussa non trasferibilità dei risultati, mancano dati e metodologia statistica per replicare l’esperimento, e i possibili bias non sono affrontati.
In generale, queste pubblicazioni “super-citate” mostrano:
- Alto rischio di bias: che inficia la validità dei risultati, spesso sovrastimando gli effetti positivi.
- Limitata accessibilità ai dati grezzi e trasparenza metodologica: rendendo difficile la revisione critica e la riproducibilità.
- Conclusioni sbilanciate: che tendono a enfatizzare gli effetti positivi senza discutere a sufficienza i limiti metodologici.
- Fonti spesso basate su preprints e altri lavori non peer-reviewed.
Questo dimostra come debolezze metodologiche in studi di base possano minare l’intera catena di ricerca, distorcendo la percezione scientifica e clinica.
Riflessioni Finali: Un Monito per il Futuro
La pandemia ha messo a nudo la vulnerabilità delle procedure scientifiche in condizioni estreme. L’ivermectina è diventata un caso emblematico di come un dibattito possa politicizzarsi, relegando l’evidenza scientifica in secondo piano. Fatti provati, risultati preliminari e teorie del complotto coesistono, usati per sostenere narrazioni preconcette. Questo non è solo scientificamente discutibile, ma può avere conseguenze socio-politiche devastanti, erodendo la fiducia nella scienza e nella politica.
La nostra analisi, pur limitata al periodo 2020-2022 e alle pubblicazioni in lingua inglese, sottolinea l’urgenza di un approccio critico continuo alle fonti scientifiche. È fondamentale che, specialmente in tempi di crisi, si presti la massima attenzione alla qualità della ricerca pubblicata. L’ascesa delle fake news e l’influenza del populismo richiedono una capacità di distinguere informazioni scientifiche fondate dalla disinformazione. Questo pensiero critico va insegnato fin da giovani.
Se continuiamo a basarci su evidenze deboli, le banche dati mediche verranno “inquinate”. Questo è particolarmente rilevante con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale: se i modelli linguistici vengono addestrati su database contaminati da studi di bassa qualità, rischiamo di propagare disinformazione su larga scala. A lungo termine, le distorsioni e la disinformazione potrebbero non solo mettere a rischio l’assistenza medica, ma anche compromettere la capacità della scienza di progredire.
È quindi cruciale sostenere iniziative che permettano un’analisi rigorosa della qualità delle pubblicazioni scientifiche e aiutino a smascherare bias e “fake papers”. La scienza è un processo, a volte tortuoso, ma la sua integrità è il faro che ci guida. Non lasciamo che si spenga.
Fonte: Springer