Materiali Critici e Transizione Energetica: E se gli Investimenti Esteri Cambiassero Davvero le Regole del Gioco?
Amici, parliamoci chiaro: la transizione energetica è sulla bocca di tutti, e meno male! Ma c’è un “ma” grande come una casa, o meglio, come una miniera a cielo aperto. Immaginate Paesi ricchissimi di quei materiali fondamentali per le batterie, i pannelli solari, le turbine eoliche… e poi scoprite che proprio loro faticano a vedere la luce di questa rivoluzione verde. Sembra un paradosso, vero? Eppure, è una realtà che ho avuto modo di approfondire e che, vi assicuro, merita tutta la nostra attenzione.
Il Nocciolo della Questione: FDI e Materiali Critici
La faccenda ruota attorno agli investimenti esteri diretti (FDI) e a come vengono impiegati. Questi investimenti sono spesso visti come una manna dal cielo per l’estrazione di materiali critici e la generazione di entrate. Ma c’è un aspetto che, secondo me, è stato un po’ trascurato: il loro potenziale ruolo nel ridurre la vulnerabilità energetica dei Paesi che questi materiali li possiedono in abbondanza. Parliamo di bauxite, cobalto, nichel, manganese, platino… insomma, i mattoni della nostra futura energia pulita.
Uno studio recente ha messo il dito nella piaga, analizzando il periodo tra il 2016 e il 2021. E cosa è emerso? Che gli FDI hanno controllato porzioni enormi di questi materiali critici proprio nei Paesi più vulnerabili. Pensate un po’:
- 56% della bauxite
- 59% del cobalto e del nichel
- 52% del manganese
- 57% del platino
Questi numeri fanno riflettere, perché ci dicono che mentre alcuni Paesi (i cosiddetti “clean energy winners”, spesso economie ad alto reddito) accelerano nella transizione grazie a queste risorse, i Paesi produttori (“clean energy losers”), pur sedendo su un tesoro, restano indietro, con capacità limitate di energia pulita.
Un Cambio di Prospettiva: L’FDI come Leva per lo Sviluppo Locale
E qui arriva la parte che mi entusiasma di più. Lo studio suggerisce una svolta strategica: e se una parte di questi investimenti, invece di servire solo a estrarre e portare via, venisse usata per sviluppare energia pulita lì, sul posto? Immaginate di reindirizzare anche solo il 40% della produzione controllata dagli FDI verso l’implementazione di energia pulita. L’impatto potrebbe essere enorme! Paesi come la Repubblica Democratica del Congo (RDC), l’Indonesia, il Sudafrica e la Guinea potrebbero ridurre drasticamente la loro vulnerabilità energetica.
Vi faccio qualche esempio per capirci meglio. La RDC, che produce circa il 70% del cobalto mondiale, potrebbe vedere la sua capacità di energia pulita passare da 0,108 gigawatt (GW) a ben 1922,4 GW! L’Indonesia, con il suo nichel, potrebbe passare da 1,87 GW a 88 GW. Non sono numeri da poco, vero?
Questo approccio non solo aiuterebbe questi Paesi a fare un balzo in avanti nella loro transizione energetica, ma promuoverebbe anche una maggiore equità nella transizione energetica globale. Si tratterebbe di allineare gli obiettivi di profitto con quelli di sostenibilità, creando un circolo virtuoso.
La Disparità Attuale: Un Flusso a Senso Unico?
Attualmente, la situazione è piuttosto sbilanciata. I Paesi ricchi di materiali critici spesso vedono gli FDI come la principale fonte di entrate (nella RDC rappresentano l’80% delle entrate, in Zambia il 75%), piuttosto che come un mezzo per sviluppare la propria infrastruttura di energia pulita. Questo perché, diciamocelo, la vulnerabilità economica spinge a monetizzare subito.
Inoltre, la capacità di lavorazione e raffinazione di questi materiali è concentrata in poche economie, come la Cina, che processa il 100% della grafite naturale e del disprosio globali, il 90% del manganese, il 70% del cobalto e il 58% del litio. Questo crea una dipendenza e accentua le disuguaglianze.
Pensate che dal 2016, il controllo degli FDI sul settore minerario, soprattutto per i materiali critici nei Paesi “perdenti” dal punto di vista dell’energia pulita, è aumentato. Questo perché le grandi aziende con le risorse e le competenze necessarie si trovano per lo più nei Paesi “vincenti” (il 61% del litio e il 56% del cobalto sono controllati da sole cinque aziende!).
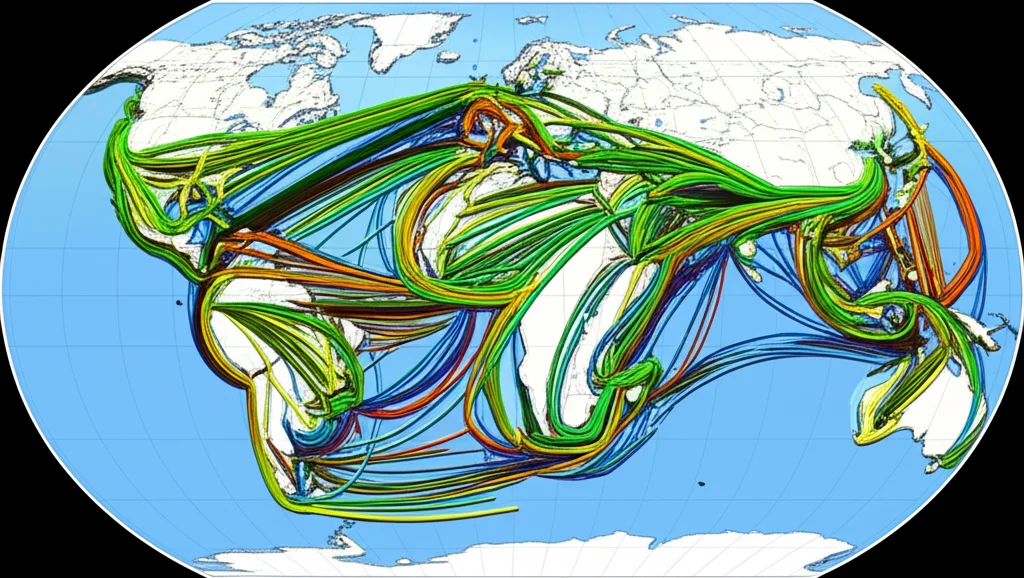
Questa dinamica ha intensificato la disparità nella transizione energetica. Mentre i Paesi “vincenti” aumentano la loro capacità produttiva di tecnologie pulite, batterie per veicoli elettrici e installazioni di energia rinnovabile, i Paesi ricchi di materie prime restano al palo.
L’Indice di Vulnerabilità all’Energia Pulita (CVI)
Per misurare questa vulnerabilità, lo studio introduce il Clean Energy Vulnerability Index (CVI). Questo indice tiene conto di fattori come il rischio geopolitico, le disparità nella produzione e lavorazione dei materiali, la capacità manifatturiera per l’energia pulita e, appunto, la produzione di materiali critici guidata dagli FDI.
I risultati sono chiari: i Paesi che dipendono pesantemente dalle importazioni di materiali critici sono più vulnerabili di quelli con una produzione interna significativa. Ma, cosa ancora più importante, anche i principali produttori di materiali mostrano una notevole vulnerabilità. Tra questi troviamo:
- Produttori di cobalto: RDC, Zambia, Papua Nuova Guinea
- Produttori di nichel: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Nuova Caledonia, Filippine, Sudafrica, Zambia
- Produttori di manganese: Sudafrica, Marocco, Brasile, India, Gabon
- Produttori di platino: Sudafrica, Zimbabwe
- Produttori di bauxite: Guinea, Kazakistan, Giamaica
È un paradosso che questi Paesi, pur fornendo le risorse essenziali per la transizione globale, ne traggano benefici limitati in termini di sviluppo della propria energia pulita.
Una Proposta Concreta: Scambiare Materiali con Capacità Energetica
La proposta rivoluzionaria è quella di passare da un FDI basato sull’estrazione a un FDI orientato allo sviluppo di energia pulita. In pratica, si tratterebbe di un quadro in cui i materiali estratti tramite FDI vengono “scambiati” con una capacità equivalente di energia pulita da installare nel Paese produttore. Questo allineerebbe la produzione di materiali, la loro lavorazione e le basi manifatturiere con gli obiettivi di energia pulita.
Immaginate l’impatto: il 40% delle importazioni di cobalto verso Regno Unito, Svizzera, Sudafrica e Cina dalla RDC potrebbe tradursi rispettivamente nel 3,91%, 15,56%, 2,64% e 11,74% della capacità potenziale di energia pulita della RDC. Per lo Zambia, il 40% delle importazioni cinesi e britanniche di cobalto corrisponderebbe al 22,23% e al 7,08% della sua capacità energetica pulita stimata.
Questo nuovo approccio potrebbe davvero trasformare gli investimenti esteri da semplice strumento di estrazione a leva per potenziare la capacità di energia pulita nei Paesi ricchi di materiali ma vulnerabili dal punto di vista energetico. Si rafforzerebbe l’indipendenza energetica, si promuoverebbe un accesso più equo all’energia pulita e si stabilizzerebbero le catene di approvvigionamento globali costruendo infrastrutture energetiche direttamente nei Paesi produttori.
Quali Passi per il Futuro?
Certo, non è un percorso semplice. Servono politiche mirate. Eccone alcune che mi sembrano particolarmente sensate:
- Incoraggiare FDI in progetti minerari che diano priorità allo sviluppo locale di energia pulita e alla crescita economica, piuttosto che alla mera esportazione di materiali.
- I governi dei Paesi ricchi di materiali potrebbero implementare politiche per trattenere una percentuale dei materiali critici per progetti energetici domestici.
- Stabilire nuovi accordi commerciali sui materiali critici che bilancino le esportazioni con gli obiettivi di sviluppo di energia pulita, magari imponendo che una quota dei materiali scambiati sia investita in progetti di energia pulita nel Paese esportatore.
- Le organizzazioni internazionali potrebbero sostenere politiche che incoraggino il trasferimento di tecnologia e lo sviluppo di infrastrutture per l’energia pulita nei Paesi esportatori.
Queste misure potrebbero ridisegnare le catene di approvvigionamento globali, assicurando che i Paesi ricchi di materiali beneficino direttamente delle loro risorse attraverso la realizzazione di tecnologie energetiche pulite e sostenibili. Sarebbe un passo enorme verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare l’SDG-7 (energia accessibile e pulita) e l’SDG-13 (azione per il clima).

Insomma, l’idea di trasformare gli FDI da semplice strumento estrattivo a motore di sviluppo energetico locale non è solo affascinante, è una vera e propria necessità se vogliamo una transizione ecologica che sia davvero equa e globale. C’è ancora molta strada da fare, e studi come questo ci indicano la direzione, ma la possibilità di un futuro energetico più giusto per tutti è qualcosa per cui vale la pena lottare e, soprattutto, riflettere.
Fonte: Springer







