Imparare Troppe Cose Insieme? Il Cervello Fa i Capricci (Ma Non Dimentica!)
Avete mai provato a imparare a suonare la chitarra e contemporaneamente a studiare per un esame di fisica quantistica? O magari a fare giocoleria mentre imparate una nuova lingua? Beh, se vi siete sentiti un po’ ingarbugliati, sappiate che non siete soli. Il nostro cervello è una macchina pazzesca, capace di apprendere una miriade di abilità, ma come gestisce l’apprendimento di più cose, specialmente se in sequenza? È una domanda che ci siamo posti anche noi, e abbiamo deciso di vederci chiaro.
Le Quattro Ipotesi sul Banco di Prova
Quando si tratta di imparare più compiti uno dopo l’altro, ci sono diverse teorie su come questi possano interagire. Noi ne abbiamo considerate quattro principali:
- Indipendenza: Imparare il compito A non ha nessun effetto sull’imparare il compito B, e viceversa. Ognuno per la sua strada, insomma.
- Facilitazione: Imparare A ti dà una spintarella per imparare B. Una sorta di “imparare a imparare”, dove l’esperienza precedente ti rende più sveglio o veloce col compito successivo.
- Interferenza Retrograda: Qui le cose si complicano. Imparare il nuovo compito B ti fa pasticciare o addirittura dimenticare il compito A che avevi già imparato. Un po’ come quando installi un nuovo software e quello vecchio smette di funzionare bene. In intelligenza artificiale la chiamano “oblio catastrofico”.
- Interferenza Anterograda: L’opposto della precedente. Aver imparato A rende più difficile imparare B. È come se il primo apprendimento lasciasse un’ombra che ostacola quello nuovo, magari rendendoti più lento all’inizio o meno efficiente nell’imparare.
Per capire quale di queste ipotesi fosse la più gettonata dal nostro cervello, abbiamo messo in piedi un esperimento bello tosto.
L’Esperimento: Sette Compiti in Sequenza
Abbiamo reclutato 49 volontari e li abbiamo divisi in sette gruppi. A tutti abbiamo fatto imparare sette compiti percettivi diversi, uno dopo l’altro. Parliamo di cose come discriminare il contrasto di un’immagine, la direzione del movimento, riconoscere l’orientamento di un volto, identificare forme, distinguere frequenze sonore e persino un compito di memoria di lavoro chiamato N-back. La figata? Ogni gruppo imparava questi sette compiti in una sequenza diversa. Così, ogni compito veniva imparato in tutte le possibili posizioni della sequenza (dal primo al settimo posto).
L’idea era vedere se la posizione nella sequenza influenzasse quanto bene e quanto velocemente i partecipanti imparassero ciascun compito. E, per non farci mancare nulla, una parte di loro è tornata dopo mesi per un re-test, per vedere se l’apprendimento di nuovi compiti avesse intaccato quelli imparati prima (ciao ciao, interferenza retrograda?).
In un secondo esperimento, più semplice, abbiamo coinvolto altri 14 partecipanti con solo due dei compiti, invertendo l’ordine tra due gruppi, sempre con un re-test del primo compito.
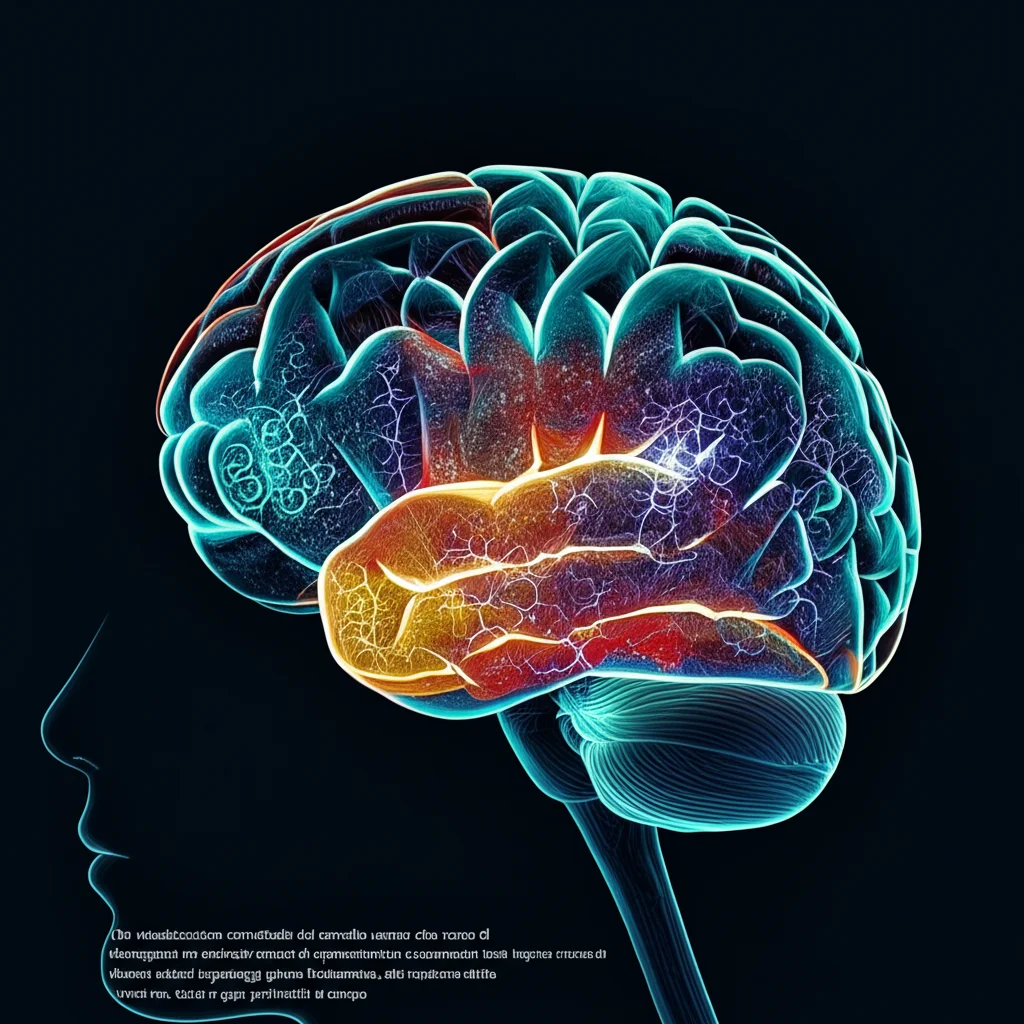
I Risultati: L’Ombra del Passato (Anterograda)
E qui viene il bello! Analizzando le curve di apprendimento sessione per sessione, è emerso un pattern interessante. Per ben sei dei sette compiti (Contrasto, Vernier, Volto, Movimento, Uditivo e N-back), chi imparava un compito più tardi nella sequenza mostrava prestazioni iniziali peggiori o un tasso di apprendimento più lento rispetto a chi lo imparava all’inizio. L’unico compito che sembrava fregarsene altamente della posizione era quello di ricerca della forma (Shape task).
Questa, signore e signori, è interferenza anterograda bella e buona! Sembra proprio che l’aver allenato il cervello su certi binari renda un po’ più faticoso imboccarne di nuovi subito dopo, almeno per certi tipi di abilità.
E la Memoria a Lungo Termine? Niente Panico!
Una delle nostre più grandi curiosità era: imparare cose nuove ci fa dimenticare quelle vecchie? Il re-test effettuato mesi dopo ci ha dato una risposta piuttosto chiara: no. O almeno, l’impatto della posizione nella sequenza sull’oblio era minimo o nullo. Certo, un po’ di ruggine fisiologica c’era per tutti, ma non abbiamo trovato prove significative di interferenza retrograda. Chi aveva imparato un compito per primo non lo dimenticava di più rispetto a chi lo aveva imparato per ultimo, solo perché nel frattempo aveva appreso altri sei compiti. Il cervello, una volta consolidato un apprendimento, sembra tenerlo stretto, anche se si dedica ad altro.
Modelli e Meccanismi: Cosa C’è Sotto?
Per andare più a fondo, non ci siamo limitati a guardare le medie. Abbiamo sviluppato modelli matematici complessi, analizzando l’apprendimento blocco per blocco (ogni sessione era divisa in più blocchi). Questi modelli hanno confermato il quadro generale: l’interferenza anterograda era la protagonista, manifestandosi o con una performance iniziale più bassa o con un tasso di apprendimento generale più lento per i compiti appresi tardi nella sequenza.
Perché succede questo? Una teoria affascinante è quella della “meta-plasticità”. In pratica, il cervello cerca continuamente di bilanciare la sua capacità di imparare cose nuove (plasticità) con la necessità di non buttare via quello che sa già (stabilità). Quando impariamo un compito, le connessioni neurali coinvolte si rafforzano. Se poi arriva un nuovo compito che magari usa in parte le stesse “strade” ma in modo diverso, il cervello potrebbe “proteggere” l’apprendimento precedente, rendendo più difficile la riconfigurazione per il nuovo.
Abbiamo anche proposto un modello di rete neurale per spiegare perché alcuni compiti (come quello della forma) sembrano immuni. Potrebbe dipendere dal fatto che certi compiti, magari più complessi o che coinvolgono aree cerebrali di più alto livello, riescono a trovare “percorsi alternativi” o a regolare le connessioni in modo più flessibile, evitando così l’ingorgo creato dagli apprendimenti precedenti. Invece, compiti più basilari, che si affidano a circuiti neurali più “rigidi” e specifici, potrebbero soffrire di più questa competizione.

La teoria dell’Integrated Reweighting suggerisce che l’apprendimento consista nell’ottimizzare i pesi delle connessioni tra la rappresentazione stabile di uno stimolo e le decisioni relative al compito. Il nostro studio estende questa idea all’apprendimento sequenziale di più compiti, suggerendo che potrebbero esserci strati nascosti condivisi e indipendenti, oltre alla conservazione della struttura dei pesi dei compiti già appresi. Questo è fondamentale per capire le interazioni tra compiti, specialmente gli effetti asimmetrici.
Cosa Ci Portiamo a Casa?
Questi risultati non sono solo curiosità da laboratorio. Hanno implicazioni importanti.
- Per l’allenamento e l’educazione: Se dobbiamo imparare più abilità, forse l’ordine conta. Potrebbe essere più efficiente mettere i compiti percettivi di basso livello all’inizio di una sequenza di training, specialmente in ambiti clinici o per formare esperti che devono acquisire molteplici competenze.
- Per l’intelligenza artificiale: Le IA sono bravissime in compiti singoli, ma spesso soffrono di “oblio catastrofico” quando imparano più cose in sequenza. Capire come il cervello umano eviti questo problema (o almeno lo mitighi con l’interferenza anterograda piuttosto che retrograda) può ispirare algoritmi più robusti e flessibili, capaci di apprendimento continuo senza perdere le competenze acquisite. La nostra scoperta sulla meta-plasticità – ridurre la plasticità nelle regioni neurali già impegnate per proteggere l’apprendimento consolidato – potrebbe essere una strategia efficiente.
Insomma, il nostro cervello è una macchina incredibile che gestisce l’apprendimento multiplo con strategie sofisticate. L’interferenza anterograda sembra essere uno dei “costi” da pagare per mantenere stabili gli apprendimenti precedenti. Non è tanto un “dimenticare”, quanto un “fare più fatica con il nuovo a causa del vecchio”. Studiare queste dinamiche ci aiuta non solo a capire meglio noi stessi, ma anche a progettare metodi di apprendimento più efficaci e, perché no, intelligenze artificiali più simili alla nostra straordinaria mente.

Fonte: Springer







