L’Inglese è un Investimento: Identità, Ideologie e Capitale Nascosti Dietro l’Apprendimento
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un tema che mi sta particolarmente a cuore e che, ne sono certo, incuriosirà molti di voi: cosa c’è davvero dietro l’apprendimento dell’inglese come lingua straniera (EFL)? Spesso sentiamo dire: “Ah, se solo avessi più motivazione…”. Ma siamo sicuri che sia *solo* una questione di motivazione?
Perché Alcuni Sfrecciano e Altri Annaspano con l’Inglese?
Avete mai notato come alcune persone sembrino assorbire l’inglese come spugne, mentre altre, pur mettendoci impegno, faticano terribilmente? Per anni, la ricerca nel campo dell’acquisizione di una seconda lingua (SLA) si è concentrata tantissimo sul costrutto psicologico della “motivazione”. Un approccio, diciamocelo, un po’ positivista e quantitativo, che tende a misurare gli stati psicologici interni dello studente. Ma questo modo di vedere le cose, per quanto utile, lascia un po’ in ombra il ruolo fondamentale che giocano la società, le disuguaglianze strutturali e la distribuzione, spesso iniqua, delle risorse.
Insomma, è come guardare un iceberg vedendo solo la punta e ignorando tutta la massa sommersa. Per colmare questa lacuna, un approccio post-strutturalista ci viene in aiuto, introducendo un concetto affascinante: l'”investimento“. Pensatelo come la controparte sociologica della “motivazione” psicologica.
La “Motivazione” da Sola Non Basta: Un Nuovo Sguardo sull’Apprendimento
Il modello dell'”investimento”, sviluppato inizialmente da Peirce (poi Norton) nel 1995 e successivamente ampliato da Darvin e Norton nel 2015, ci offre una lente potentissima. Questo modello non vede più lo studente come un’entità isolata, con fattori interni statici (motivato/non motivato, estroverso/introverso), ma come un soggetto inserito in un contesto sociale, con un’identità complessa, dinamica e spesso contraddittoria, che si modella e rimodella nel tempo e nello spazio, soprattutto in relazione al potere.
Le teorie tradizionali tendevano a creare una netta distinzione tra l’apprendente e il mondo sociale, considerando variabili come motivazione o ansia come slegate dal contesto. Altre teorie, pur considerando il contesto sociale, trascuravano le relazioni di potere. Ad esempio, il modello dell’acculturazione suggeriva che la vicinanza sociale al gruppo della lingua target favorisse l’apprendimento. Ma cosa succede se un’identità sociale “indesiderabile” limita le opportunità di interazione, nonostante una forte motivazione?
L'”investimento”, invece, riconosce che quando uno studente si impegna nell’apprendimento di una lingua, sta anche investendo nella propria identità sociale, un’identità che è in continua evoluzione. Questo concetto ci permette di esplorare qualitativamente la relazione, storicamente costruita, tra l’apprendente e il gruppo della lingua target.
“Investimento”: Un Trittico Fondamentale: Identità, Ideologia, Capitale
Il modello espanso di “investimento” si poggia su tre pilastri fondamentali: identità, ideologia e capitale.
- L’identità qui non è solo come ci vediamo, ma anche come la società ci posiziona (classe sociale, etnia, ecc.), portando a privilegi o marginalizzazione. Include anche l'”identità immaginata”, cioè chi desideriamo diventare.
- L’ideologia si riferisce a quei “modi di pensare” dominanti, spesso imposti da istituzioni potenti, che regolano l’inclusione e l’esclusione, e che influenzano, ad esempio, le politiche educative linguistiche.
- Il capitale, concetto preso in prestito da Bourdieu, ci aiuta a capire le disuguaglianze, il funzionamento del potere e la distribuzione delle risorse (economiche, sociali, culturali) che modellano le esperienze di apprendimento.
Questi tre elementi sono interconnessi e ci offrono una visione molto più ricca e sfumata delle dinamiche in gioco.
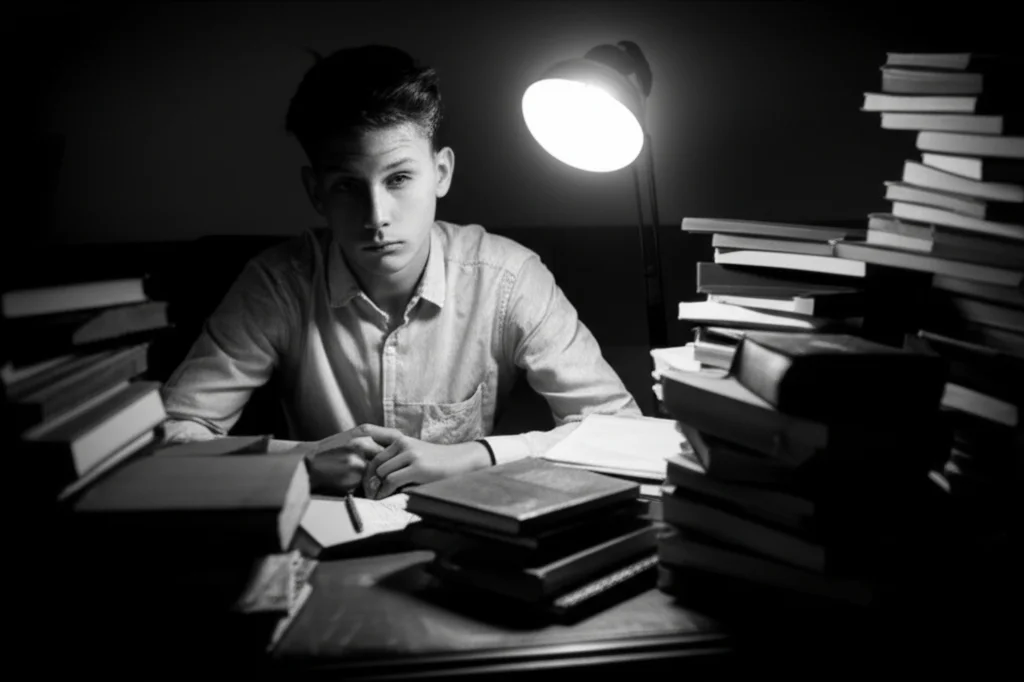
La Storia di Rakib: Un Caso Illuminante
Per capire meglio come funziona questo modello, vi racconto brevemente la storia di Rakib (nome di fantasia), uno studente di ingegneria meccanica in un’università privata in Bangladesh, un paese dove l’inglese è pervasivo e considerato strumento di mobilità sociale. Rakib proveniva da una famiglia rurale povera e la sua esperienza di apprendimento dell’inglese è stata un vero e proprio percorso a ostacoli, ma anche una dimostrazione di incredibile “investimento”.
Lo studio che ha analizzato la sua storia ha raccolto dati per due anni attraverso interviste narrative, un’autobiografia scritta e conversazioni informali. L’analisi di queste narrazioni, alla luce del modello di “investimento”, ha fatto emergere cose davvero interessanti.
Identità Immaginate e Appartenenza: Il Motore dell’Investimento
Pensate a Rakib. La sua identità immaginata ha giocato un ruolo cruciale. Voleva diventare uno “studente di ingegneria diplomatica”, uno “studente superiore” e, soprattutto, una persona in grado di “parlare fluentemente inglese”. Questi desideri lo hanno spinto a studiare vocabolario e grammatica per i test di ammissione, a comprare libri, a guardare film in inglese e a praticare la conversazione con gli amici. Ogni passo era un investimento verso la persona che sognava di essere.
Anche l’appartenenza a un gruppo ha influenzato il suo impegno. Quando si è trasferito in una scuola professionale dove la competizione era alta e l’abilità in inglese incideva sullo status sociale, per la prima volta ha cercato lezioni private. Quando è passato da un politecnico (Sun) a un altro (Moon), si è reso conto che il livello di inglese degli studenti del Moon era più alto. Questo lo ha spinto a impegnarsi di più per conquistare una posizione rispettabile nella nuova comunità, partecipando a gruppi di studio e sessioni di conversazione. L’idea di far parte della “comunità degli stagisti”, che si presumeva fosse brava in inglese, lo ha ulteriormente motivato prima di iniziare il tirocinio.
Ideologie Nascoste: Le Regole Non Scritte del Gioco
Le ideologie, come dicevamo, sono quei sistemi di idee che, spesso invisibilmente, governano le nostre vite. Nel caso di Rakib, diverse ideologie hanno plasmato il suo percorso:
- Politiche di educazione linguistica: In Bangladesh, l’inglese è materia obbligatoria dalla prima elementare alla dodicesima classe. Questa politica, pur con resistenze iniziali da parte di Rakib, lo ha “costretto” a confrontarsi con la lingua. A livello universitario, la politica dell’EMI (English Medium Instruction) della sua università privata ha richiesto un ampio spettro di competenze in inglese.
- Gatekeeping linguistico: L’inglese, associato a potere e prestigio, diventa uno strumento per controllare l’accesso alle risorse. I test di lingua hanno determinato l’accesso di Rakib a diversi percorsi formativi (ad esempio, gli fu negato l’accesso al liceo scientifico per il basso punteggio in inglese) e persino a un posto letto in ostello. Questo “linguicismo” (discriminazione basata sulla lingua) lo ha trasformato, suo malgrado, in uno studente “investito”.
- Metodologie di insegnamento: Il Bangladesh, nonostante l’introduzione ufficiale dell’Approccio Comunicativo (CLT), è ancora fortemente radicato nel Metodo Grammatica-Traduzione (GTM). Di conseguenza, l’investimento di Rakib si è concentrato molto sulla memorizzazione di regole grammaticali, lettere, paragrafi ed esercizi meccanici, piuttosto che sullo sviluppo equilibrato delle quattro abilità linguistiche.
Queste ideologie, spesso date per scontate, hanno incanalato e, a volte, limitato il suo investimento.

Il Capitale: Risorse Che Fanno la Differenza
E veniamo al capitale. Bourdieu ne identifica tre forme principali: economico, sociale e culturale. La storia di Rakib ci mostra come il possesso (o la mancanza) e la capacità di trasformare queste forme di capitale influenzino l’investimento.
- Capitale economico: La famiglia di Rakib era povera. Fin da piccolo ha dovuto lavorare, togliendo tempo allo studio. Non poteva permettersi lezioni private fino alla nona classe. La sua posizione geografica in un’area rurale remota limitava anche l’accesso a risorse educative di qualità (capitale culturale istituzionalizzato), costringendolo a frequentare scuole meno valide.
- Capitale culturale: L’accesso a “capitale culturale oggettivato” (libri, materiali) era limitato a risorse di bassa qualità, come quei manuali che promettono di insegnare l’inglese in trenta giorni. Non poteva frequentare corsi di conversazione, concentrati nelle aree urbane.
- Capitale sociale: Qui Rakib ha mostrato una grande abilità! Ha saputo costruire e utilizzare la sua rete di relazioni: compagni di stanza più competenti, amici con cui praticare, studenti più grandi da cui ottenere consigli per i test. Ha trasformato queste connessioni (capitale sociale) in opportunità di apprendimento (capitale culturale).
Interessante è anche la conversione del capitale. Ad esempio, i profitti della sua piccola attività commerciale (capitale economico) sono stati usati per pagare lezioni private (capitale culturale). Il possesso di un cellulare (frutto della sua attività di ricariche telefoniche) è diventato uno strumento per praticare l’inglese a basso costo con gli amici.
Rakib ha investito il suo capitale economico e sociale per accrescere il suo capitale culturale (competenza in inglese), riconoscendo che quest’ultimo era la chiave per accedere a istituzioni educative migliori, certificati di tirocinio e, infine, la laurea in ingegneria.
Cosa Ci Insegna Tutto Questo?
La storia di Rakib, analizzata attraverso la lente dell'”investimento”, ci dice molto. Primo, che l’impegno nell’apprendimento di una lingua è profondamente condizionato dal mondo sociale esterno, non solo da fattori psicologici interni. Certo, attitudine, strategie di apprendimento, memoria di lavoro, ansia, autoefficacia contano, ma l’interazione con le condizioni sociali create da identità, ideologia e capitale è fondamentale.
Secondo, questo studio dimostra la potenza del modello di “investimento” per analizzare contesti EFL, come quello del Bangladesh. Per gli educatori, questo significa riconoscere le disuguaglianze nell’accesso al potere sociale, economico e politico. Può spingere verso una “pedagogia linguistica critica”, che sfidi la distribuzione iniqua delle risorse e promuova la giustizia sociale. Per i ricercatori, è un invito a spostare il focus dalla quantificazione degli stati mentali interni all’esame del mondo sociale esterno degli studenti.

Conclusione: Oltre la Grammatica, C’è di Più
Certo, questo è solo un caso studio e non si possono generalizzare i risultati. Analizzare studenti provenienti da contesti privilegiati potrebbe dare esiti diversi. Tuttavia, ci apre gli occhi su una realtà complessa: imparare l’inglese non è solo una questione di studiare grammatica e vocaboli. È un vero e proprio investimento in cui si mettono in gioco la propria identità, ci si scontra con ideologie potenti e si cerca di navigare la distribuzione, spesso diseguale, del capitale.
La prossima volta che pensate all’apprendimento di una lingua, provate a guardare oltre la “motivazione”. Chiedetevi: in cosa sto investendo? Quali identità sto cercando di costruire? Quali ideologie stanno influenzando il mio percorso? E quali forme di capitale sto mobilitando? Potreste scoprire un universo di significati nascosti!
Fonte: Springer







