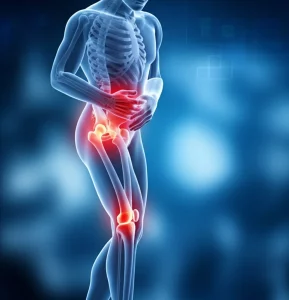Ictus: Il Tuo Sangue Svela il Rischio? Nutrizione e Infiammazione Contano Più di Quanto Pensi!
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che tocca la vita di tantissime persone: l’ictus. Sapete, l’ictus è una brutta bestia, un disturbo neurologico acuto che colpisce quando il flusso di sangue al cervello si blocca o si riduce drasticamente. Questo scatena una serie di eventi a cascata non proprio simpatici, come infiammazione, stress ossidativo e danni ai tessuti cerebrali. Le conseguenze? Possono essere devastanti: paralisi parziale, difficoltà a parlare, depressione, problemi di deglutizione e cognitivi. Pensate che ogni anno colpisce quasi 18 milioni di persone nel mondo ed è la seconda causa di morte e la terza di disabilità. Un problema enorme per la salute pubblica, non c’è che dire.
Capire il Rischio: Gli Strumenti Attuali Hanno dei Limiti?
Quando una persona ha un ictus, una delle cose più importanti è capire quale sarà il suo percorso, quali sono i rischi e le possibilità di recupero. Per farlo, i medici usano diversi strumenti. Avrete forse sentito parlare della Scala NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), molto usata per valutare la gravità neurologica. Però, diciamocelo, non è infallibile, specialmente nell’ictus ischemico. Poi c’è la Scala di Glasgow (GCS), che misura lo stato di coscienza, ma non funziona bene se il paziente è sedato o intubato. L’Indice di Barthel valuta l’autonomia nelle attività quotidiane, ma tralascia l’impatto cognitivo. E la SF-36, che misura la qualità della vita, ha dei limiti tecnici che ne riducono l’utilità pratica.
Insomma, questi strumenti si concentrano molto sulla funzione fisica e sulla coscienza, ma dipendono tanto da chi li usa e dalla collaborazione del paziente. Inoltre, non sono granché per monitorare la situazione in tempo reale nella fase acuta. Qui entra in gioco qualcosa di diverso: i biomarcatori legati all’infiammazione e alla nutrizione. Questi valori, ottenuti da semplici esami del sangue, possono darci un quadro più oggettivo della gravità del danno, della risposta infiammatoria, dello stato immunitario e persino della coagulazione. Ci permettono di capire meglio come sta evolvendo la malattia.
Infiammazione e Nutrizione: Un Legame Stretto con l’Ictus
L’infiammazione è un po’ la protagonista silenziosa nell’ictus. Livelli alti di marcatori infiammatori sono collegati a un rischio maggiore di avere un ictus e anche a una prognosi peggiore. L’ictus stesso scatena una risposta infiammatoria che può danneggiare i vasi sanguigni e il tessuto cerebrale. Ma non solo: l’infiammazione cronica può influenzare anche il nostro stato nutrizionale. Può portare a una riduzione dell’albumina nel sangue (una proteina importantissima) e a una perdita di peso. E sappiamo che bassi livelli di albumina o un indice di massa corporea (BMI) non ottimale sono associati a una maggiore gravità dell’ictus e a un recupero più difficile.
Vedete come tutto è collegato? Nutrizione, sistema immunitario, infiammazione e prognosi si influenzano a vicenda. Per questo è nata l’immunonutrizione, un campo affascinante che studia proprio queste interazioni. E da qui derivano degli indicatori specifici che cercano di catturare questa complessità.

Alla Ricerca del Miglior Indicatore: Lo Studio NHANES
Recentemente, mi sono imbattuto in uno studio molto interessante pubblicato su *Scientific Reports* (del gruppo Nature, quindi roba seria!). I ricercatori si sono chiesti: tra i vari indicatori immunonutrizionali, ce n’è uno che predice meglio degli altri il rischio di mortalità per qualsiasi causa nei pazienti che hanno avuto un ictus?
Per rispondere, hanno usato i dati del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), un’enorme indagine sulla salute e la nutrizione degli americani, raccolta tra il 2005 e il 2018. Hanno poi collegato questi dati con il National Death Index (NDI) per vedere chi, tra i partecipanti che avevano avuto un ictus, era deceduto entro la fine del 2019. Hanno analizzato un campione finale di 1076 pazienti adulti con storia di ictus.
Gli indicatori sotto la lente d’ingrandimento erano cinque:
- SII (Systemic Immune-inflammation Index): Un indice che combina piastrine, neutrofili e linfociti per misurare l’infiammazione sistemica.
- NRI (Nutritional Risk Index): Valuta il rischio nutrizionale basandosi su albumina e rapporto tra peso attuale e peso ideale.
- NPS (Naples Prognostic Score): Un punteggio più nuovo che mette insieme sia l’infiammazione (rapporto neutrofili/linfociti e linfociti/monociti) sia la nutrizione (albumina e colesterolo totale).
- ALB (Albumina sierica): La semplice concentrazione di albumina nel sangue.
- TC (Colesterolo Totale): Il livello di colesterolo totale.
L’obiettivo era chiaro: usare analisi statistiche avanzate (come la correlazione di Spearman e le foreste casuali di sopravvivenza – RSF) per capire le relazioni tra questi indicatori e identificare il “campione” nella previsione della mortalità.
Il Vincitore è… l’NPS!
Ebbene, i risultati parlano chiaro. Tra tutti gli indicatori esaminati, l’NPS (Naples Prognostic Score) è emerso come il più potente predittore della mortalità per tutte le cause nei pazienti con ictus. L’analisi RSF ha mostrato che l’NPS aveva un’importanza variabile (VIMP) nettamente superiore agli altri.
Ma cosa significa in pratica? I ricercatori hanno diviso i pazienti in due gruppi in base al punteggio NPS: un gruppo a basso rischio (NPS 0-2) e uno ad alto rischio (NPS 3-4). Hanno poi seguito questi pazienti nel tempo (in media per 67 mesi). Durante questo periodo, 372 pazienti sono deceduti.
Usando l’analisi di sopravvivenza di Kaplan-Meier, hanno visto che la curva di sopravvivenza del gruppo con NPS alto era significativamente peggiore di quella del gruppo con NPS basso (P < 0.001). In parole povere, chi aveva un NPS più alto aveva molte più probabilità di morire.
Per essere sicuri che questo risultato non fosse dovuto ad altri fattori (come età, sesso, altre malattie, fumo, ecc.), hanno usato modelli statistici chiamati “regressione di Cox”. Anche dopo aver tenuto conto di tutti questi possibili confondenti, il risultato è rimasto solido: il gruppo con NPS alto (3-4) aveva un rischio di mortalità quasi doppio (Hazard Ratio = 1.89) rispetto al gruppo con NPS basso (0-2). Un risultato statisticamente molto significativo (P < 0.001).
Perché l’NPS Funziona Così Bene? Scomponiamo il Punteggio
Il bello dell’NPS è che combina diversi pezzi del puzzle. Analizzando i singoli componenti, i ricercatori hanno confermato che:
- Un basso numero di linfociti (che di solito aiutano a proteggere) era associato a maggior rischio.
- Un alto numero di neutrofili (spesso legati all’infiammazione acuta e al danno) era associato a maggior rischio.
- Un alto numero di monociti (anch’essi coinvolti nell’infiammazione) era associato a maggior rischio.
- Bassi livelli di albumina (sotto i 40 g/L), che indicano sia malnutrizione che infiammazione sistemica, erano associati a un rischio quasi 1.5 volte maggiore di mortalità.
Curiosamente, il colesterolo totale (TC), l’altro componente nutrizionale dell’NPS, non è risultato significativamente associato alla mortalità in questo specifico gruppo di pazienti post-ictus. Questo è interessante perché, sebbene il colesterolo alto sia un fattore di rischio *per* l’ictus, il suo ruolo *dopo* l’evento sembra essere più complesso e controverso.

E l’Attività Fisica? Un Possibile Scudo
Lo studio ha anche esplorato se l’effetto dell’NPS cambiasse in base ad altri fattori, come l’età, il sesso, l’obesità (BMI), il fumo, l’alcol, l’ipertensione, il diabete e, molto interessante, il livello di attività fisica. In generale, l’NPS si è dimostrato un predittore robusto in tutti i sottogruppi.
Tuttavia, è emerso un dato degno di nota riguardo all’esercizio fisico. Nei pazienti con bassa attività fisica, avere un NPS alto era associato a un rischio di mortalità ancora maggiore (HR = 2.46) rispetto alla media. Invece, nel gruppo con attività fisica moderata o alta, la differenza di rischio tra NPS alto e basso non era statisticamente significativa.
Questo *non* significa che l’NPS non conti se fai sport, ma suggerisce che uno stile di vita attivo potrebbe, in parte, mitigare il rischio aggiuntivo legato a uno stato immunonutrizionale sfavorevole. Sappiamo che l’attività fisica fa benissimo dopo un ictus: migliora la pressione, la funzione dei vasi, la sensibilità all’insulina, il profilo lipidico e aiuta persino a regolare la coagulazione. Quindi, anche se l’NPS resta un fattore di rischio indipendente da tenere d’occhio, muoversi (quando le condizioni fisiche lo permettono, ovviamente!) è sempre una buona idea per migliorare la prognosi.
Cosa Portiamo a Casa?
Questo studio ci lascia un messaggio importante: lo stato immunonutrizionale, valutato tramite un indice semplice ed economico come l’NPS, è un potentissimo indicatore del rischio di mortalità a lungo termine nei pazienti che hanno superato la fase acuta di un ictus. L’NPS, che possiamo calcolare da comuni esami del sangue (emocromo, albumina, colesterolo), ci dà una fotografia combinata di infiammazione e stato nutrizionale.
Identificare i pazienti con un NPS alto potrebbe permettere ai medici di stratificare meglio il rischio e, potenzialmente, di intervenire in modo più mirato, magari con supporto nutrizionale specifico o strategie per modulare l’infiammazione.
Certo, come ogni studio, anche questo ha dei limiti. Ad esempio, basandosi sui dati NHANES, non è stato possibile confrontare direttamente l’NPS con scale cliniche come la NIHSS. Inoltre, non si è potuto tener conto di tutti i possibili fattori confondenti, come le terapie farmacologiche specifiche che i pazienti assumevano.
Nonostante ciò, i risultati sono solidi e aprono la strada a ulteriori ricerche. Sarebbe fantastico vedere studi multicentrici più ampi per confermare questi dati e magari confrontare l’NPS con altri nuovi biomarcatori.
In conclusione, la prossima volta che farete degli esami del sangue, ricordatevi che quei numeri non sono solo cifre astratte. Possono raccontare molto sulla vostra salute, specialmente se avete avuto un evento importante come un ictus. E l’NPS sembra essere una nuova “spia” preziosa nel cruscotto della nostra salute post-ictus. Staremo a vedere come verrà integrato nella pratica clinica!
Fonte: Springer