Idrogeno Offshore: Rivoluzione Verde o Impronta Nascosta nel Mare del Nord?
Amici scienziati e curiosi del web, ben ritrovati! Oggi voglio parlarvi di un argomento che sta facendo scintille nel mondo dell’energia pulita: l’idrogeno verde prodotto offshore. Sembra la panacea di tutti i mali, vero? Energia eolica che, invece di finire solo nelle nostre prese, viene usata per creare idrogeno pulitissimo direttamente in mezzo al mare. Un sogno che si avvera per decarbonizzare settori ostici come l’industria pesante e i trasporti. L’Unione Europea, per esempio, punta a produrre ben 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde entro il 2030. Mica male, eh?
Ma, come ogni medaglia ha il suo rovescio, anche questa tecnologia apparentemente immacolata nasconde qualche insidia. E qui entro in gioco io, o meglio, noi ricercatori, che ci siamo chiesti: cosa succede all’ecosistema marino quando iniziamo a produrre idrogeno su larga scala in mare aperto? Perché, vedete, per produrre idrogeno dall’acqua di mare (H2O) tramite elettrolisi, serve acqua dolcissima. E come la otteniamo in mezzo all’oceano? Con la desalinizzazione.
Il “Dietro le Quinte” della Produzione di Idrogeno Offshore
Immaginate queste enormi piattaforme offshore, simili a quelle petrolifere ma dedicate all’idrogeno. Ecco cosa succede lì sopra:
- Desalinizzazione: L’acqua di mare viene prelevata e privata del sale. Questo processo, spesso termico come la Distillazione Multi-Effetto (MED), produce acqua pura da un lato, ma dall’altro rilascia salamoia, cioè acqua molto più salata di quella circostante.
- Elettrolisi: L’acqua desalinizzata viene scissa in idrogeno (il nostro prodotto) e ossigeno, usando l’energia elettrica fornita dalle vicine turbine eoliche. Le tecnologie più promettenti sono l’elettrolisi alcalina (AEL) e quella a membrana a scambio protonico (PEMEL), su cui ci siamo concentrati.
- Raffreddamento: Tutti questi processi generano calore. Tanto calore. E per raffreddare gli impianti, si usa altra acqua di mare, che viene poi riversata, ovviamente più calda.
Quindi, il risultato è che queste piattaforme restituiscono al mare acqua più calda e più salata. E la domanda sorge spontanea: che impatto ha tutto ciò sull’ambiente marino, in particolare sulla stratificazione dell’acqua nel Mare del Nord, un’area già sotto pressione per lo sviluppo dell’energia offshore?
Cosa Abbiamo Scoperto: Un’Impronta Idrografica Locale
Per capirci qualcosa, abbiamo usato dei sofisticati modelli numerici al computer (il sistema SCHISM, per i più tecnici), creando delle simulazioni che vanno dalla scala regionale del Mare del Nord fino a dettagli di poche decine di metri attorno a un ipotetico impianto di produzione da 500 MW nella Baia Tedesca. E i risultati sono stati… illuminanti!
Il principale colpevole dell’impatto locale è il calore di scarto. Pensate che, nelle immediate vicinanze di un impianto da 500 MW, la temperatura dell’acqua può aumentare anche di 2°C! Non sembra tanto? Beh, per gli organismi marini abituati a determinate condizioni, può essere uno shock non da poco. Questa “pennellata” di calore e, in misura minore, di salinità, crea dei pennacchi di acqua a densità diversa che si disperdono con le correnti.
Le maree giocano un ruolo cruciale: quando sono forti, aiutano a diluire e disperdere rapidamente questi pennacchi. Ma nei momenti di stanca, l’acqua più calda e meno densa tende a salire in superficie, creando forti gradienti e persino fenomeni di risalita (upwelling) localizzati. Abbiamo visto che la risoluzione del modello è fondamentale: passando da una griglia di 10 metri a una di 100 o 500 metri, si perde gran parte dell’informazione sull’intensità reale di questi pennacchi. È come guardare un dettaglio con una lente sfocata!
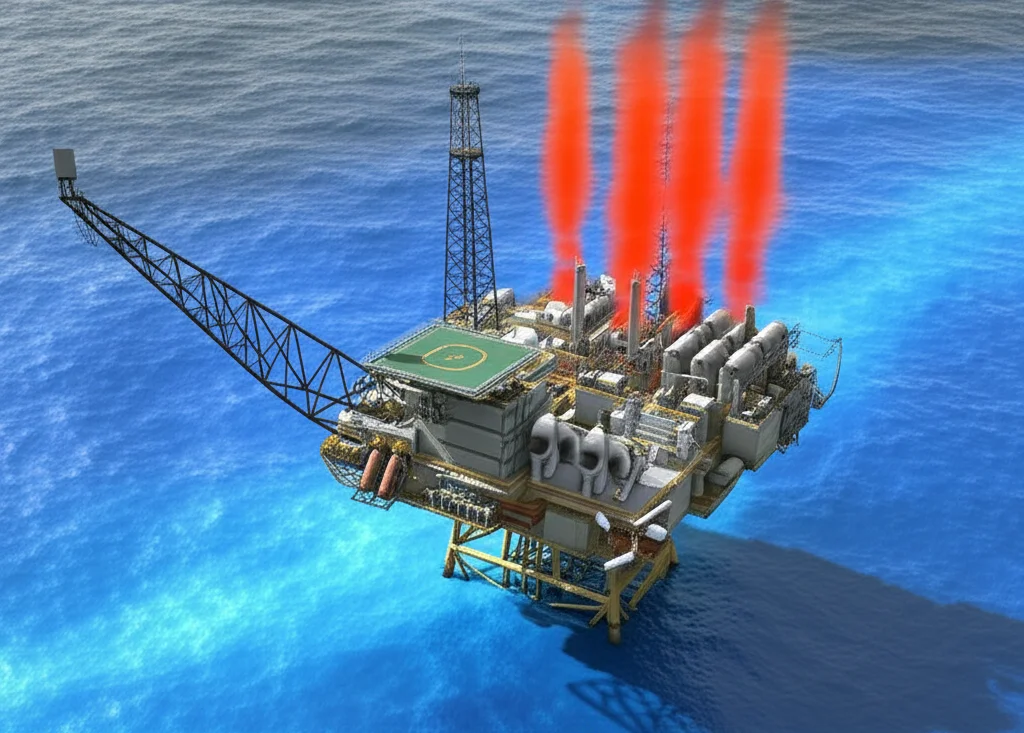
La stratificazione, ovvero la divisione della colonna d’acqua in strati con temperature e salinità diverse, è vitale per l’ecosistema. Influenza il trasporto verticale di nutrienti e quindi la produttività biologica. Alterarla non è mai una buona notizia. Abbiamo simulato diversi scenari di scarico:
- Scarico in superficie (5m): Aumenta la stratificazione vicino all’impianto, perché l’acqua calda galleggia.
- Scarico vicino al fondo (35m): Impatto ancora più forte sulla stratificazione, con una diminuzione dell’anomalia di energia potenziale (PEA) dell’8.6%, probabilmente a causa del forte contrasto termico con le acque fredde di fondo.
- Scarico distribuito verticalmente: Questa sembra la soluzione migliore per minimizzare l’impatto locale sulla stratificazione, con variazioni di PEA minime.
- Dividere lo scarico spazialmente: Riduce l’impatto del 50% in un singolo punto, ma ovviamente allarga l’area interessata.
E Rispetto ai Parchi Eolici? Una Questione di Scala
Ora, potreste chiedervi: ma questi impatti sono peggiori di quelli generati dai parchi eolici stessi? I parchi eolici, con le loro fondamenta (monopali) e l’effetto scia sul vento, modificano già la circolazione e la stratificazione. Le fondamenta, ad esempio, creano turbolenza che mescola l’acqua, tendendo a diminuire la temperatura superficiale e la stratificazione. La riduzione della velocità del vento sulla superficie del mare, invece, può portare a un leggero aumento della temperatura superficiale.
Le nostre simulazioni, focalizzate sull’area SEN-1 nella Baia Tedesca, mostrano che per un impianto di idrogeno da 1 GW, l’aumento di temperatura superficiale è molto localizzato (fino a 0.07°C vicino all’impianto, ma trascurabile fuori dall’area del parco eolico). Gli effetti del parco eolico in sé, invece, sono più estesi. Ad esempio, la turbolenza dei monopali può raffreddare la superficie fino a 0.1°C all’interno del parco.
Su scala regionale e considerando uno scenario futuro al 2050 con 10 GW di produzione di idrogeno e 70 GW di eolico offshore nella Baia Tedesca, l’impronta dell’idrogeno è significativa localmente. Vicino agli impianti, la temperatura superficiale media annua può aumentare fino a 0.2°C. Questi cambiamenti, seppur localizzati, superano la variabilità naturale e sono paragonabili ai segnali del cambiamento climatico! Tuttavia, quando guardiamo all’impatto complessivo sulla stratificazione, gli effetti dei parchi eolici (riduzione del vento e turbolenza) sono dominanti, circa dieci volte superiori a quelli della sola produzione di idrogeno.

Cosa Possiamo Fare? Strategie di Mitigazione
Quindi, l’idrogeno offshore lascia un’impronta, soprattutto a livello locale. Ma non disperiamo! Ci sono strategie per mitigarla:
- Tecnologia di desalinizzazione: Noi abbiamo considerato la MED, che ha un forte impatto termico. L’Osmosi Inversa (RO) è più efficiente energeticamente e ha una minore impronta termica, ma potrebbe avere un’impronta salina e chimica maggiore. Servono studi comparativi.
- Efficienza dell’elettrolisi: Attualmente è intorno al 60%. Aumentarla significherebbe meno calore di scarto.
- Metodi di scarico: Come abbiamo visto, distribuire lo scarico verticalmente o spazialmente (ad esempio, impianti di piccola taglia decentralizzati presso ogni turbina) potrebbe ridurre l’impatto puntuale, sfruttando anche la turbolenza generata dalle fondamenta delle turbine per una più rapida diluizione.
- Utilizzo del calore di scarto: Invece di buttarlo in mare, si potrebbe pensare a come riutilizzarlo, come già avviene parzialmente nella MED.
È fondamentale che l’industria fornisca dettagli tecnologici più precisi e che le autorità definiscano regolamenti chiari per guidare uno sviluppo sostenibile.
In Conclusione: Un Equilibrio Delicato
L’idrogeno offshore è una tessera importantissima del puzzle della transizione energetica. Tuttavia, il nostro studio evidenzia che la sua produzione non è a impatto zero. Il calore di scarto è il fattore principale che crea un’impronta idrografica locale, con aumenti di temperatura significativi (fino a 2°C) in un raggio di decine o centinaia di metri attorno a un impianto da 500 MW. Questi effetti possono alterare la stratificazione marina, con potenziali conseguenze per gli ecosistemi.
Su larga scala, l’impatto dell’idrogeno sembra modesto rispetto a quello dei parchi eolici stessi, che rimarranno il fattore antropogenico dominante nel Mare del Nord. Ma localmente, l’attenzione deve essere alta. Servono ulteriori ricerche, soprattutto con modelli ad altissima risoluzione (come le Large Eddy Simulations) per capire meglio la dispersione dei pennacchi e l’impatto biogeochimico di eventuali sostanze chimiche rilasciate.
La sfida è trovare il giusto equilibrio: sfruttare l’enorme potenziale dell’idrogeno verde minimizzando al contempo la nostra impronta su un ambiente marino già prezioso e vulnerabile. E come sempre, la scienza è la nostra bussola migliore per navigare queste acque complesse!
Fonte: Springer







