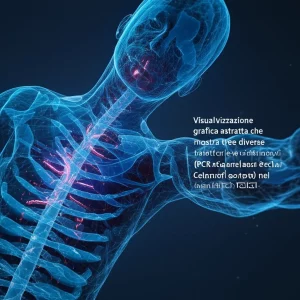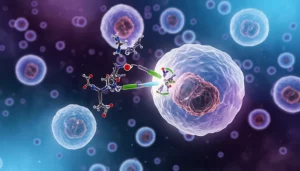Barocettori Umani: Abbiamo Trovato i Guardiani della Pressione nell’Arco Aortico?
Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del corpo umano! Oggi voglio raccontarvi una storia che mi sta particolarmente a cuore, un’avventura scientifica che ci ha portati a sbirciare in uno degli angoli più nascosti e cruciali del nostro organismo: l’arco aortico. Sì, proprio quel “tubo” principale che parte dal cuore e distribuisce sangue a tutto il corpo. Ma non è solo un tubo, amici miei, è un vero e proprio centro di controllo, e noi abbiamo cercato di capire chi sono i “guardiani” che regolano la nostra pressione sanguigna.
Ma cosa sono esattamente questi barocettori?
Immaginate dei minuscoli sensori, dei veri e propri guardiani, che monitorano costantemente la pressione del sangue. Questi sono i barocettori. Fanno parte di un sistema chiamato baroriflesso, un meccanismo di feedback negativo che, attraverso il sistema nervoso centrale, regola battito cardiaco e pressione. Se la pressione sale troppo, questi sensori inviano un segnale per rallentare il cuore e dilatare i vasi; se scende, fanno il contrario. Un balletto finemente orchestrato per mantenerci in equilibrio.
Finora, gran parte di ciò che sapevamo sui barocettori aortici proveniva da studi su animali. Ma l’uomo? Un grande punto interrogativo. Ecco perché ci siamo messi all’opera: identificare questi sfuggenti barocettori nell’arco aortico umano era la nostra missione.
La nostra caccia al tesoro scientifica: come abbiamo cercato
Per questa impresa, abbiamo analizzato campioni di arco aortico umano provenienti da autopsie (tre archi aortici sani, per la precisione) e campioni di aneurismi aortici addominali e tessuto aortico addominale di controllo dalla nostra biobanca vascolare. Un lavoro di squadra che ha coinvolto diverse competenze.
Ci siamo armati di strumenti e tecniche all’avanguardia:
- Analisi istologiche: abbiamo usato anticorpi specifici per “colorare” e visualizzare i nervi e le loro strutture. Un po’ come usare evidenziatori speciali per trovare le parole chiave in un testo.
- Microdissezione laser e macrodissezione: tecniche che ci hanno permesso di isolare selettivamente i nervi nell’avventizia (lo strato più esterno) dell’aorta. Immaginate dei micro-chirurghi che prelevano con precisione solo le parti che ci interessano.
- Proteomica e Trascrittomica (RNA sequencing): queste analisi “omiche” ci hanno dato una visione d’insieme delle proteine presenti e dei geni espressi, rispettivamente. È come avere la lista completa degli ingredienti e le istruzioni di montaggio di una struttura complessa.
L’obiettivo era chiaro: trovare proteine che potessero agire da sensori di pressione (meccanocettori) e capire da dove venissero.
Primi indizi: i nervi sotto la lente d’ingrandimento
L’analisi istologica ci ha subito mostrato qualcosa di interessante: una distribuzione eterogenea di nervi nell’avventizia lungo tutto l’arco aortico. Questi nervi erano particolarmente abbondanti nell’aorta ascendente, fino all’arteria succlavia sinistra. Non solo grandi fasci nervosi, ma anche singole fibre nervose. Abbiamo usato marcatori come la tirosina idrossilasi (TH), il neurofilamento (NF) e il trasportatore vescicolare del glutammato 2 (VGLUT2) per identificarli chiaramente. Alcuni di questi fasci nervosi erano davvero imponenti, con diametri fino a 760 µm!
Curiosamente, non abbiamo trovato un accumulo specifico di nervi nella curvatura interna dell’arco aortico, come a volte si ipotizza, ma una distribuzione più diffusa lungo l’intera circonferenza in quella zona specifica.

Quantificando la presenza di nervi positivi alla TH, abbiamo notato che i segmenti iniziali dell’arco aortico (quelli più vicini al cuore, fino all’arteria carotide comune sinistra) sembravano avere decisamente più nervi rispetto ai segmenti successivi, verso l’aorta discendente. Questo ha senso, perché il nervo depressore aortico, che contiene i barocettori aortici, si trova proprio tra l’arteria succlavia sinistra e la carotide comune sinistra.
La svolta: proteine rivelatrici e i nostri candidati barocettori!
Qui arriva il bello! Quando abbiamo analizzato con la proteomica l’intera avventizia (non solo i fasci nervosi isolati con la microdissezione laser, dove sorprendentemente non li avevamo trovati), abbiamo identificato tre candidati molto promettenti come barocettori umani. Rullo di tamburi… Si tratta di PIEZO1, TRPV2 e TRPM4. Questi nomi forse non vi dicono molto, ma sono canali ionici noti per essere sensibili a stimoli meccanici, come lo stiramento della parete vascolare dovuto alla pressione.
La cosa ancora più sorprendente? Abbiamo trovato questi stessi tre “moschettieri” non solo nell’arco aortico, ma anche nell’aorta addominale sana e in quella affetta da aneurisma. PIEZO1 mostrava un’abbondanza simile in tutti e tre i gruppi. TRPV2, invece, era significativamente aumentato negli aneurismi aortici addominali. Per TRPM4, l’abbondanza più bassa si osservava nell’aorta addominale sana.
Queste scoperte, ottenute sia da campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE) sia da campioni freschi congelati, ci hanno dato una forte indicazione che PIEZO1, TRPV2 e TRPM4 potessero essere i nostri barocettori.
Da dove vengono? Il mistero dell’RNA
Ora, una domanda cruciale: queste proteine sono prodotte dalle cellule presenti direttamente nella parete aortica o provengono da altrove? Per rispondere, abbiamo eseguito l’analisi trascrittomica (sequenziamento dell’RNA) sugli stessi campioni freschi usati per la proteomica. L’RNA è, in parole povere, il “messaggero” che porta le istruzioni dal DNA per costruire le proteine.
E qui, un’altra sorpresa: non abbiamo trovato espressione di mRNA per PIEZO1, TRPV2 e TRPM4 nell’avventizia dell’arco aortico! Questo cosa significa? Che molto probabilmente queste proteine non sono sintetizzate dalle cellule residenti nella parete dell’aorta (come fibroblasti o cellule muscolari lisce dell’avventizia). La nostra ipotesi è che queste proteine vengano prodotte nei corpi cellulari dei neuroni sensoriali del baroriflesso, che si trovano nel ganglio nodoso (una struttura nervosa associata al nervo vago), e poi trasportate come proteine già formate lungo le fibre nervose fino ai loro terminali nell’arco aortico.
È un po’ come se la “fabbrica” (il corpo cellulare del neurone) fosse nel cervello o vicino, e i “prodotti finiti” (le proteine barocettrici) venissero spediti fino alla “filiale” nell’aorta. Questo spiegherebbe perché troviamo le proteine ma non il loro RNA messaggero locale. L’RNA, infatti, può essere trasportato lungo le fibre nervose, ma per proteine con mRNA molto lunghi (come i nostri candidati, che vanno da 2.4 a 7.6 kbp), questo trasporto su lunghe distanze è meno efficiente, oppure il loro tasso di turnover è così basso che l’RNA non è rilevabile.

Abbiamo invece rilevato l’mRNA di altri canali ionici della famiglia TRP (Transient Receptor Potential), come TRPP2, che sono noti per essere espressi nelle cellule muscolari lisce e nelle cellule endoteliali e partecipare alla regolazione del tono vascolare. Ma i nostri tre candidati principali sembrano avere un’origine neuronale “distante”.
Una sorpresa inaspettata: i barocettori anche più in basso?
Come accennato, la presenza di PIEZO1, TRPV2 e TRPM4 anche nell’aorta addominale, sia sana che malata, ci ha fatto riflettere. Sembra che questi canali ionici abbiano un pattern di espressione generale lungo l’aorta umana. Ma allora, qual è la loro funzione specifica? La nostra idea è che la loro funzione dipenda dal “cablaggio”: se espressi in neuroni che fanno parte del circuito del baroriflesso (come quelli che innervano l’arco aortico e proiettano al tronco encefalico), allora agiscono come barocettori. Se espressi in altri neuroni o cellule, potrebbero avere ruoli diversi. L’arco aortico è innervato dal nervo depressore aortico, mentre l’aorta addominale principalmente dal plesso aortico addominale. Percorsi diversi, funzioni potenzialmente diverse, pur usando gli stessi “sensori”.
PIEZO1, TRPV2, TRPM4: perché proprio loro?
Questi tre canali non sono stati scelti a caso dalla natura (o meglio, non li abbiamo identificati casualmente!).
- PIEZO1: È un canale ionico meccanosensibile relativamente “giovane” nel panorama scientifico, ma già protagonista. È attivato da forze meccaniche, stiramento o stress da flusso. Studi su modelli animali hanno dimostrato che l’eliminazione di PIEZO1 e PIEZO2 (un suo “cugino” che noi non abbiamo rilevato nell’aorta umana in questo studio) può abolire completamente il baroriflesso. PIEZO1 è quindi un candidato super promettente!
- TRPV2 e TRPM4: Appartengono alla grande famiglia dei canali TRP, veri e propri sensori cellulari multifunzione. I TRPM (melastatina) e i TRPV (vanilloidi) sono stati identificati come barocettori in vari modelli animali. TRPM4, in particolare, è permeabile a cationi monovalenti, attivato da ioni calcio intracellulari e può tradurre stimoli meccanici in un cambiamento del tono vascolare. TRPV2 è stato rilevato in molti tessuti, inclusi i neuroni, ma il suo ruolo specifico nel baroriflesso vascolare umano è ancora da chiarire.
È interessante notare che, mentre negli animali sono stati descritti più di 30 diversi canali ionici come potenziali barocettori (ENaC, ASIC, TRP, PIEZO), nel nostro studio sull’arco aortico umano sono emersi “solo” questi tre. Questo sottolinea l’importanza di studiare direttamente l’uomo!
Non è tutto oro quel che luccica: sfide e prospettive future
Certo, come in ogni ricerca, ci sono delle limitazioni. Ottenere tessuto di arco aortico umano sano da pazienti senza comorbidità cardiovascolari è una vera sfida, il che ha limitato la dimensione del nostro campione a tre individui. Per aumentare la potenza statistica, abbiamo analizzato diversi segmenti da questi campioni. Nonostante ciò, i tre candidati barocettori sono stati rilevati in tutti i campioni e segmenti analizzati.
Un altro punto è che, nonostante i nostri sforzi con l’immunoistochimica per localizzare precisamente PIEZO1, TRPV2 e TRPM4, non siamo riusciti a identificarli in modo affidabile nelle sezioni di tessuto dell’arco aortico, anche se i controlli (tessuto cerebrale di topo) erano positivi. Pensiamo che questo sia dovuto al fatto che questi recettori si trovano probabilmente solo alle estremità delle fibre nervose non mielinizzate, che sono strutture molto piccole (circa 10 µm di diametro) e difficili da “catturare” in sezioni sottili di 5 µm, a meno di non avere una gran fortuna nel taglio!
Quindi, cosa ci riserva il futuro? Sicuramente, sono necessari ulteriori studi per confermare questi risultati e per capire appieno il ruolo di PIEZO1, TRPV2 e TRPM4 come barocettori nell’arco aortico umano. Vorremmo analizzare la loro espressione lungo l’intero albero arterioso umano per mappare la loro distribuzione. Comprendere meglio questi meccanismi potrebbe aprire la strada a nuove terapie per l’ipertensione e altre malattie cardiovascolari.
Per ora, siamo entusiasti di aver fatto un piccolo, ma speriamo significativo, passo avanti. Abbiamo identificato per la prima volta dei candidati barocettori nell’arco aortico umano, gettando nuova luce su come il nostro corpo gestisce magistralmente la pressione sanguigna. È un promemoria di quanto sia meravigliosamente complesso e ancora pieno di misteri il corpo umano. E noi, da bravi esploratori, non vediamo l’ora di continuare a indagare!
Fonte: Springer