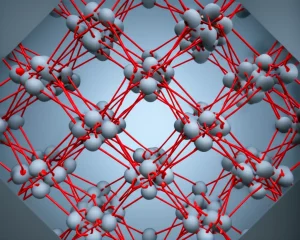IA Generativa e Scrittura: Rivoluzionare l’Apprendimento, Non Sostituirlo!
Ammettiamolo, l’intelligenza artificiale generativa è ovunque. Da quando ChatGPT ha fatto il suo ingresso trionfale alla fine del 2022, noi educatori ci siamo trovati a navigare in acque inesplorate, cercando di capire come questi nuovi strumenti avrebbero impattato l’insegnamento e, soprattutto, l’apprendimento della scrittura. È una medaglia a due facce: da un lato, un potenziale enorme per supportare gli studenti; dall’altro, il rischio che si trasformi in una scorciatoia, bypassando il processo di apprendimento stesso.
Come possiamo, quindi, cavalcare l’onda dell’IA generativa in un corso universitario ad alta intensità di scrittura senza “scaricare” l’apprendimento altrove? Bella domanda, vero? È proprio quello che ci siamo chiesti e su cui abbiamo lavorato sodo.
L’alba di una nuova era didattica: opportunità e sfide
L’IA generativa può essere un tutor personale instancabile: guida nella pianificazione, suggerisce spunti, offre esempi, fornisce feedback quasi umano. Immaginate che manna dal cielo per uno studente, specialmente se un po’ timoroso di fronte alla pagina bianca! Ma c’è il rovescio della medaglia: la tentazione, soprattutto per gli studenti più “smanettoni” e meno amanti della scrittura, di delegare interamente la stesura dei testi all’IA. Questo non solo compromette il loro sviluppo come scrittori, ma solleva anche serie questioni di integrità accademica. Ecco perché molti di noi stanno rivedendo attività, compiti e, soprattutto, metodi di valutazione.
Il nostro approccio: un tool AI “pedagogicamente informato”
In collaborazione con il docente responsabile di un corso di scrittura e comunicazione ingegneristica, abbiamo deciso di affrontare il toro per le corna. L’obiettivo? Fornire agli studenti una guida sull’uso etico ed efficace dell’IA generativa per la scrittura e, al contempo, aumentare la loro alfabetizzazione in materia di IA. Per farlo, abbiamo sviluppato iterativamente uno strumento di scrittura potenziato dall’IA, chiamato PapyrusAI. Questo tool non è un semplice “copia e incolla” da un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), ma offre un accesso guidato e strutturato, permettendoci anche di raccogliere dati preziosi sull’interazione studente-IA.
Il nostro lavoro si è basato su una ricerca implementativa basata sul design (DBIR) durante l’anno accademico 2023-2024, concentrandoci sull’istruzione dei docenti, l’apprendimento degli studenti e i problemi pratici dell’insegnamento. Volevamo capire quali fossero le pratiche emergenti migliori per usare l’IA generativa in modo produttivo nella scrittura accademica e come i docenti potessero integrare al meglio questi strumenti nei loro corsi.
Un framework in evoluzione: da 5 passi fondamentali a un approccio più olistico
Inizialmente, il nostro quadro di riferimento per l’istruzione identificava cinque necessità chiave per gli studenti: capire le basi dell’IA, saperne accedere, formulare prompt efficaci, corroborare le informazioni e incorporare l’output dell’IA nel proprio lavoro. Questi pilastri sono fondamentali:
- Capire: Conoscere funzioni, punti di forza, debolezze e bias dell’IA generativa. Sapere su quali dati è stata addestrata e cosa è stato escluso aiuta a notare assunzioni e pregiudizi impliciti.
- Accedere: Saper navigare gli strumenti di scrittura AI per compiti specifici (paper, email, presentazioni).
- Prompt: Imparare a “interrogare” l’IA per ottenere i contenuti più utili. Prompt di qualità riflettono un pensiero critico sul compito.
- Corroborare: Verificare l’accuratezza dei contenuti generati dall’IA (che può inventare fatti e fonti!) e interrogare l’output per individuare eventuali bias.
- Incorporare: Imparare a integrare i testi generati dall’IA nel proprio scritto in modo etico ed efficace, citandone l’uso.
Tuttavia, dopo un anno di ricerca sul campo, abbiamo capito che c’era bisogno di qualcosa in più. Abbiamo raffinato il nostro approccio, evidenziando la necessità per gli studenti di: pensare prima di usare l’IA, passare da un “prompt sufficientemente buono” a un prompt iterativo e agentivo, e riflettere sul loro utilizzo alla fine del processo.

Pensare prima, interrogare l’IA e riflettere: la chiave è l’agenzia dello studente
La prima cosa che abbiamo notato è l’importanza del “pensare prima”. Prima di rivolgersi all’LLM, lo studente dovrebbe attivare le proprie conoscenze, interessi, la comprensione del contesto del corso. Se si delega subito all’IA, si rischia di seguire passivamente la strada tracciata dalla macchina, perdendo la propria “voce” e il proprio pensiero critico. L’IA, infatti, è estremamente persuasiva e raramente mostra incertezza!
Poi c’è il prompting. Non basta un comando e via. Insegniamo una strategia di prompting iterativo: si inizia con un “prompt sufficientemente buono”, magari conversazionale, e poi si raffina. È fondamentale che gli studenti non accettino passivamente il primo output dell’IA, ma che “rispondano per le rime”, chiedendo chiarimenti, espansioni, revisioni. Devono sentirsi “i capi” dell’interazione. Questo richiede conoscenza del contenuto e pensiero critico. Un docente ha pianificato di modellare di più questo processo in classe, mostrando come “contrattaccare” sia importante.
Un altro aspetto cruciale è la corroborazione. Verificare l’accuratezza dell’output dell’IA è un’abilità essenziale, un’occasione per allenare il pensiero critico a basso rischio: l’IA non si offende se mettiamo in dubbio le sue affermazioni! Con il miglioramento dei modelli, però, diventa meno probabile imbattersi in falsità palesi, quindi i docenti potrebbero dover creare attività ad hoc per mostrare questa necessità.
Infine, la riflessione. I nostri docenti già la valorizzavano, e con l’IA diventa ancora più importante. Gli studenti riflettono sul ruolo dell’IA nel loro processo di scrittura, su come li ha aiutati o ostacolati, e su come potrebbero usarla diversamente in futuro. Questo li mantiene consapevolmente al comando. Curiosamente, per alcuni, la necessità di riflettere sull’uso dell’IA è diventata un disincentivo a usarla, un “lavoro extra”. Trovare il giusto equilibrio tra riflessione costruttiva e “lavoro inutile” è una sfida.
Le sfide non mancano: il “Matthew Effect” e la motivazione
Abbiamo osservato che gli scrittori meno abili faticano a usare efficacemente lo strumento AI. Come ha detto un docente, “gli scrittori scarsi restano scrittori scarsi con i prompt”. Sembra che manchi loro la consapevolezza di cosa debba essere migliorato nel loro testo, e quindi non riescono a sfruttare la potenza dell’IA. Questo ci preoccupa, perché l’IA non deve ampliare i divari di apprendimento (il cosiddetto “Effetto Matteo”, per cui chi è già bravo migliora di più). Stiamo pensando a come fornire un supporto aggiuntivo a questi studenti.
Un’altra sfida è la motivazione. Alcuni studenti, anche scrittori competenti, preferiscono non usare il nostro tool perché richiede tempo e sforzo per ottenere output utili, optando per strumenti più diretti come ChatGPT (che però non offre lo stesso scaffolding pedagogico). Dobbiamo capire se l’attrito del nostro tool è uno “sforzo produttivo” necessario per l’apprendimento o un ostacolo inutile.

Nonostante queste sfide, un aspetto positivo è che gli studenti stanno diventando più consapevoli ed espliciti riguardo ai propri processi di scrittura, discutendone in classe in modi produttivi. I prompt del nostro tool, che spesso spiegano cosa stanno facendo e perché, forniscono loro un linguaggio per articolare queste riflessioni.
Come integrare l’IA nel curriculum: consigli per i docenti
Sviluppare buoni corsi è difficile. Basandoci sulla nostra esperienza, ecco alcuni spunti su come infondere l’IA generativa nel curriculum:
- Partire dagli obiettivi di apprendimento: L’IA non deve soppiantare gli obiettivi del corso, ma migliorarli o integrarli. Chiedetevi: quali sono gli obiettivi di apprendimento per gli studenti, sia per l’area disciplinare sia, se applicabile, per l’alfabetizzazione AI?
- Determinare il ruolo appropriato dell’IA: Una volta chiari gli obiettivi, si può decidere come l’IA può supportarli. Ad esempio, se l’obiettivo è imparare a scrivere una scaletta, non faremo scrivere la scaletta all’IA, ma potremmo chiederle un feedback su quella scritta dallo studente. Considerate cosa è superfluo che faccia lo studente, cosa non può fare per mancanza di risorse (es. feedback multipli dal docente), cosa rientra nelle capacità dell’IA e cosa è etico che faccia.
- Rivedere i contenuti e le attività: Questo processo può portare a identificare contenuti non necessari. Poiché il tempo è limitato, potrebbe essere necessario rimuovere o ridurre alcune attività per fare spazio a quelle nuove abilitate dall’IA. I nostri docenti hanno notato che rivedere il corso attraverso la lente dell’IA li ha portati a esplicitare obiettivi di apprendimento prima “nascosti”. È stata una “sfida emotiva e intellettuale”, ma ha portato a nuove intuizioni.
- Introdurre gradualmente e in modo integrato: Se l’obiettivo è insegnare un uso efficace dell’IA per la scrittura, non dovrebbe essere un compito o una lezione isolata. Idealmente, l’uso dell’IA dovrebbe essere intessuto nel corso in modi appropriati. Come ha detto un docente: “È parte della conversazione, perché non mi piace l’IA come argomento discreto che inizia e finisce lì; la vita non funziona così, è tutto interconnesso”.
- Sfruttare i “frutti maturi”: Iniziate con gli usi dell’IA più facili da implementare e che sfruttano meglio i suoi punti di forza. Ad esempio, l’IA è ottima come partner per il brainstorming (idee per argomenti, contro-argomentazioni, prospettive diverse). Un uso particolarmente efficace è stato quando gli studenti l’hanno usata per facilitare il brainstorming per un paper di gruppo che integrava diverse discipline ingegneristiche.
L’IA può anche essere utile per insegnare aspetti della scrittura tradizionalmente ostici, come la consapevolezza del pubblico e l’adozione di prospettive diverse. Ad esempio, preparando un dibattito, gli studenti hanno usato il tool per generare posizioni e questo “ha esposto gli studenti a molte più prospettive diverse di quanto avrei potuto fare io senza, per una semplice questione di tempo”.
Verso un futuro di co-creazione uomo-macchina
Il nostro quadro di riferimento rivisto per un uso dell’IA centrato sull’uomo enfatizza che è la persona a mantenere l’agenzia e a fare il pensiero critico necessario per guidare il processo e l’output finale. Questo permette agli educatori di assicurare che gli studenti apprendano le competenze essenziali di scrittura e pensiero, diventando al contempo utenti competenti e consapevoli di questo nuovo strumento.
Principi generali come la necessità di un prompting iterativo e l’incoraggiamento all’agenzia dello studente sono più duraturi delle guide specifiche sui prompt, che diventano obsolete quasi quotidianamente. Vietare l’IA generativa, a nostro avviso, non è solo inefficace, ma anche iniquo. Non preparerebbe i nostri studenti al mondo professionale e ignorerebbe il fatto che l’alfabetizzazione AI è un requisito per l’impiego futuro e l’impegno civico. Questo è particolarmente vero per gli studenti appartenenti a minoranze, che già affrontano disparità nell’accesso tecnologico.
Il nostro strumento, PapyrusAI, aiuta gli studenti a migliorare la loro scrittura accademica permettendo loro di interagire con l’IA in un “giardino recintato” che fornisce accesso strutturato e guidato, con un focus particolare sulla pianificazione e revisione, fasi spesso sottoutilizzate dagli scrittori in via di sviluppo. Imparare a scrivere con l’IA fornisce un’esperienza che supporterà la loro scrittura futura.
Certo, siamo ancora agli inizi. Dobbiamo capire meglio perché alcuni studenti, specialmente quelli con maggiori difficoltà, non sfruttano questi strumenti. Ma una cosa è chiara: l’integrazione dell’IA generativa nell’insegnamento della scrittura sta rivoluzionando pratiche consolidate. È un viaggio, e noi docenti e studenti stiamo imparando insieme come navigare questo nuovo, entusiasmante paesaggio tecnologico, assicurandoci che l’apprendimento rimanga saldamente nelle mani (e nelle menti) degli esseri umani.

Fonte: Springer