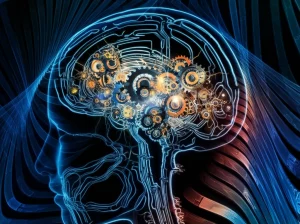IA, Arte e Coscienza: Un Viaggio Oltre il Pennello Digitale
Ricordo ancora il polverone mediatico sollevato nel 2022, quando ‘Théâtre D’opéra Spatial’ vinse un premio alla fiera statale del Colorado. Non un’opera qualsiasi, ma un’immagine generata da un’intelligenza artificiale, Midjourney per la precisione, creata da Jason Allen. Apriti cielo! Titoli cubitali annunciavano la “fine dell’arte”. Lo stesso Allen, citato dal New York Times, rincarò la dose: “L’arte è morta, amico. È finita. L’IA ha vinto. Gli umani hanno perso.”
Da un lato, c’era chi liquidava queste creazioni digitali come non-arte, semplici prodotti di un algoritmo. Dall’altro, voci più ottimiste parlavano di una trasformazione del processo creativo. Ecco, è proprio qui che voglio inserirmi. Più che chiederci se sia la fine dell’arte o se sia arte “legittima”, credo sia fondamentale esplorare quale valore possa avere l’arte generata dall’IA. Non è una domanda da poco, perché entrano in gioco questioni spinose come i bias algoritmici, l’estrazione di dati (spesso senza consenso) e l’impatto ambientale. Questi fattori, diciamocelo, influenzano eccome il nostro modo di rapportarci a queste opere e il valore che gli attribuiamo.
Ma la domanda che mi ronza in testa è: esistono condizioni per cui questi “peccati originali” dell’IA possano essere superati? Possiamo trovare un modo per interagire con queste opere in maniera significativa, riconoscendo un valore artistico nella scelta di usare questa tecnologia, nonostante le sue ombre morali? Seguitemi in questo viaggio, proviamo a capirci qualcosa.
L’Arte è Morta? Vecchie Paure, Nuove Tecnologie
L’affermazione di Allen, “L’arte è morta”, suona apocalittica, ma non è la prima volta che sentiamo questo tipo di allarme. La storia ci insegna che le nuove tecnologie spesso scatenano paure esistenziali nel mondo dell’arte. Pensiamo all’invenzione della fotografia: molti artisti la videro come il “nemico mortale” della pittura. Addirittura, l’introduzione di nuovi materiali e tecniche può generare panico. Quando iniziò la costruzione della Torre Eiffel nel 1887, un gruppo di artisti parigini scrisse una lettera infuocata al sindaco, implorandolo di fermare quell’ “inutile e mostruosa” costruzione che, a detta loro, segnava la fine dell’arte e del raffinato gusto estetico francese. Sappiamo tutti com’è andata a finire: quella che era vista come un pugno nell’occhio è diventata un’icona dell’architettura moderna, e gli artisti hanno imparato ad apprezzare le possibilità offerte da ghisa e gru.
Certo, qualcuno potrebbe obiettare: l’IA è diversa. Il fatto che modelli come Midjourney usino opere di artisti (spesso protette da copyright) senza il loro consenso per addestrarsi, non è forse uno sfruttamento senza precedenti? Tornerò su questo punto cruciale più avanti, parlando della dimensione morale. Per ora, teniamo a mente che le preoccupazioni per il futuro dell’arte sono un leitmotiv storico. Questo non sminuisce le legittime ansie per la perdita di posti di lavoro o per l’attribuzione del merito, ma suggerisce che l’arte, come sempre, troverà modi per evolversi e integrare le novità.
Ma È Vera Arte? Definizioni alla Prova dell’IA
Un’altra critica mossa ad Allen riguardava la legittimità stessa della sua opera: un’immagine generata da IA può essere considerata arte? La domanda “cos’è l’arte?” tiene impegnati i filosofi da secoli, e non sono mancate le crisi esistenziali di fronte a orinatoi (la Fontana di Duchamp) o performance di silenzio (il 4’33” di John Cage). Vediamo se l’arte AI può rientrare in qualche definizione filosofica tradizionale.
- Definizioni Essenzialiste: Cercano le proprietà definitorie nell’opera stessa. Tradizionalmente, si pensava alla rappresentazione della realtà (dall’Iliade al Discobolo di Mirone). Poi si è aggiunto l’espressivismo: l’arte esprime sempre un contenuto (dal Postpartum Document di Mary Kelly alle opere di Artemisia Gentileschi). Il formalismo si concentra su forma e simmetria (dal secondo concerto per piano di Rachmaninov alla Gioconda). L’opera di Allen, con la sua somiglianza a stili pittorici precedenti, potrebbe rientrare in queste definizioni. Potremmo persino argomentare che abbia un contenuto espressivo: magari comunica proprio la capacità dell’IA di creare immagini realistiche su input dell’artista, o problematizza la natura stessa dell’arte AI, come fece Duchamp con i ready-made.
- Definizioni Convenzionaliste: Guardano a fattori esterni all’opera. L’istituzionalismo (George Dickie) sostiene che è l’ “artworld” (critici, curatori, artisti) a conferire lo status di opera d’arte. Allen ha presentato il suo lavoro a una fiera d’arte, e una giuria (parte dell’artworld) gli ha conferito riconoscimento. La definizione storica (Jerrold Levinson) si concentra sull’intenzione dell’artista: creare qualcosa affinché sia considerato arte alla stessa stregua delle opere precedenti. Allen, pur usando un nuovo mezzo, intendeva proprio questo.
Il fatto che gallerie espongano arte AI, che artisti digitali ne vadano fieri e che parte del pubblico la apprezzi, suggerisce che queste opere possono trovare posto nelle definizioni esistenti.

Il Processo Creativo: L’IA è Solo un Pulsante?
Molte obiezioni, però, si concentrano sul processo. Per tanti, ciò che conta è la creatività, l’immaginazione, la sensibilità artistica impiegate, non solo il risultato finale. “Premere un pulsante per generare un’immagine non è un processo creativo”, ha dichiarato l’illustratore Rob Biddulph al Guardian. È un’obiezione forte: l’arte richiede un certo modo di essere prodotta, deve mostrare creatività, e usare l’IA, secondo questa visione, non lo è.
Ma è davvero così semplice? Il dibattito su come l’IA possa supportare o meno la creatività umana è accesissimo. Margaret Boden distingue tre tipi di creatività:
- Esplorativa: Esplorare le possibilità all’interno di uno spazio concettuale (come i cut-out di Matisse).
- Combinatoria: Combinare idee esistenti in modi nuovi e interessanti (come i collage di Beatriz Milhazes).
- Trasformazionale: Trascendere lo spazio concettuale, produrre qualcosa di radicalmente nuovo e sorprendente, ridefinendo le regole (come il cubismo di Picasso).
Mentre alcuni dubitano che l’IA possa essere usata per la creatività trasformazionale, c’è spazio per vederla come un aiuto potente nella creatività esplorativa e combinatoria. Potremmo pensare all’IA come a quella “macchina inconscia” di cui parlava Henri Poincaré, che esplora possibilità durante il processo creativo. L’artista delega l’esplorazione all’IA, ma mantiene il ruolo fondamentale di dirigere, rivedere, curare il risultato finale secondo la propria sensibilità e i propri valori.
C’è anche chi si spinge oltre, vedendo l’IA non solo come strumento, ma quasi come un collaboratore, capace di generare risultati inaspettati e non direttamente dettati dall’artista. Altri ancora, come Cross, la vedono come un partecipante al processo creativo, in modo analogo a come un artista performativo coinvolge il pubblico, curando i prompt e ingaggiando un dialogo esplorativo con la macchina.
Questi framework ci danno buoni motivi per credere che l’IA possa essere integrata significativamente nel processo creativo, soddisfacendo anche quelle definizioni di arte che pongono l’accento sul “come” un’opera viene creata.
Il Nodo Cruciale: L’Etica dell’Arte Generata dall’IA
Finora abbiamo smontato le obiezioni esistenziali e ontologiche. Ma ora arriviamo al cuore del problema, quello che mi preme di più esplorare: le questioni morali. Possono queste opere avere valore, e l’uso dell’IA può essere artisticamente valido nonostante le ombre etiche?
Per rispondere, dobbiamo prima mettere a fuoco queste ombre:
- Bias e Disuguaglianze Amplificate: L’arte, si sa, non è mai stata un campo di parità. Il canone artistico è dominato da secoli da una prospettiva maschile, bianca, occidentale ed eteronormativa. Le donne, le persone di colore, le minoranze, sono state storicamente sottorappresentate o del tutto assenti. Basta guardare le statistiche impietose dei grandi musei: solo l’1% delle opere alla National Gallery di Londra è di artiste donne; l’11% al MoMA di New York. Uno studio del 2023 su 18 gallerie USA ha rilevato che l’85% degli artisti erano bianchi e l’87% uomini. E l’IA, addestrata su questi dati sbilanciati, cosa fa? Non fa che perpetuare e amplificare questi bias. Se chiedi a un’IA di generare l’immagine di un “artista”, probabilmente ti mostrerà un uomo bianco. Se chiedi “donna” o “femminista”, i risultati possono essere stereotipati o persino degradanti, riflettendo secoli di rappresentazioni problematiche (pensiamo a sculture come Hatstand, Table, and Chair di Allen Jones). Questa mancanza di diversità nei dati di training limita non solo i contenuti generabili, ma anche la nostra capacità di connetterci emotivamente e intellettualmente con l’output, minandone il valore. Pensate alla differenza tra le classiche Madonne col Bambino dipinte da uomini e l’autenticità disturbante del Postpartum Document di Mary Kelly (con tanto di pannolino sporco incorniciato), o tra le tante raffigurazioni del mito di Apollo e Dafne (spesso focalizzate sul desiderio maschile) e la potente rappresentazione della resistenza femminile in Susanna e i Vecchioni di Artemisia Gentileschi. L’IA, pescando dal canone esistente, rischia di appiattire queste sfumature.
- Sfruttamento dei Dati e Distanza Contestuale: Come accennato, molti modelli AI sono addestrati su enormi dataset di immagini “raschiate” da internet, spesso includendo opere protette da copyright senza il consenso degli artisti. Questo solleva enormi questioni di sfruttamento. Inoltre, la mancanza di trasparenza su quali dati siano stati usati crea una “distanza contestuale”. Il contesto di un’opera (chi l’ha creata, quando, perché, con quali materiali/dati) è fondamentale per la nostra valutazione. Se scoprissimo che un’innocua immagine di un paesaggio viennese generata da IA è stata addestrata (anche) sui dipinti giovanili di Hitler, il nostro apprezzamento cambierebbe radicalmente, no? Questa opacità ci impedisce di esercitare pienamente il nostro giudizio morale e può creare resistenza.
- Il Costo Ambientale Nascosto: Generare arte con l’IA non è a impatto zero, anzi. Si stima che generare una singola immagine consumi tanta energia quanto ricaricare completamente uno smartphone. E questo senza contare l’enorme costo energetico e le emissioni di carbonio associate all’addestramento dei modelli stessi e al mantenimento dei data center. Per creare la sua opera premiata, Allen ha generato migliaia di immagini per mesi. In un’epoca di crescente consapevolezza ecologica, in cui molti artisti si orientano verso la sostenibilità e l’eco-arte, l’uso intensivo di IA può apparire frivolo e moralmente problematico, un’altra ragione per sentirsi a disagio.

Questi problemi morali – bias, sfruttamento, opacità, impatto ambientale – sono macigni che pesano sul valore potenziale dell’arte generata dall’IA e sulla nostra volontà di interagire con essa.
Superare la Resistenza: Quando i Difetti Morali Diventano Pregi Artistici
E allora, siamo condannati a rifiutare l’arte AI in blocco a causa dei suoi problemi etici? O c’è un modo per superare questa resistenza e trovarvi comunque valore? Qui ci viene in aiuto il dibattito filosofico tra autonomismo e moralismo.
- Gli autonomisti sostengono che il giudizio morale su un’opera (o sul suo autore) e il suo valore artistico sono due cose separate. La musica di Wagner non è cattiva perché lui era antisemita.
- I moralisti, invece, ritengono che i difetti morali di un’opera possano (almeno a volte) diminuirne il valore artistico.
Esistono ovviamente posizioni moderate. Ma una prospettiva particolarmente interessante è quella sviluppata da Anne Eaton: a volte, i difetti morali di un’opera possono addirittura contribuire al suo valore artistico. Come? Creando in noi una “resistenza immaginativa”. L’artista ci mette a disagio, ci costringe a confrontarci con qualcosa di moralmente problematico (un personaggio riprovevole, un tema offensivo, o, nel nostro caso, uno strumento eticamente ambiguo come l’IA). Se l’artista è abile, può guidarci attraverso questo disagio, facendoci superare la resistenza e arricchendoci con l’esperienza. Il valore artistico, in questo caso, risiede proprio nel modo in cui l’aspetto immorale viene presentato per stimolare riflessione e superare l’ostacolo emotivo.
Un Caso di Studio: “BECAUSE OF YOU” e la Coscienza Critica dell’IA
Voglio usare questa lente per analizzare un’opera AI che mi ha colpito profondamente e mi ha fatto superare la mia personale resistenza: BECAUSE OF YOU, di Eryk Salvaggio e Avijit Ghosh. Quest’opera affronta di petto i temi dell’estrazione dei dati, dello sfruttamento e della dissoluzione dell’identità personale nei dati, tracciando un parallelo potentissimo tra l’addestramento dei modelli AI su dati non consensuali e la storia di Henrietta Lacks.
Henrietta Lacks era una donna afroamericana a cui, negli anni ’50, furono prelevate cellule tumorali senza il suo consenso. Quelle cellule, chiamate HeLa, si rivelarono “immortali”, capaci di riprodursi all’infinito in laboratorio. Hanno rivoluzionato la ricerca medica (vaccino antipolio, chemioterapia, clonazione), ma la sua famiglia non ne seppe nulla per decenni e non ricevette alcun compenso. Una storia emblematica di sfruttamento e cancellazione dell’individuo in nome del progresso tecnologico.
Salvaggio e Ghosh usano l’IA per raccontare questa storia e riflettere sulle sue implicazioni per l’era digitale. Il video mostra immagini distorte del volto di Henrietta Lacks, generate da IA partendo dalle poche foto esistenti. Le immagini “si avvicinano all’originale ma poi derivano verso l’immagine di una donna nera, chiaramente acconciata per il 2024”, commentano gli artisti, mostrando il divario tra la persona e la sua “dataficazione”. La colonna sonora è una versione stirata e distorta di una ballata del 1951 (l’anno in cui furono prelevate le cellule di Lacks), a simboleggiare l’estensione del tempo e la distorsione dell’identità. La voce narrante non è quella degli artisti, ma un digital double della voce di Ghosh, creato addestrando un algoritmo su un campione della sua voce. Il risultato? Una voce che perde l’accento bengalese originale e assume le inflessioni di un “nordamericano statisticamente medio”, un’ulteriore metafora della cancellazione dell’individualità nel processo di astrazione dei dati.
Ecco, interagendo con BECAUSE OF YOU, ho sentito la mia resistenza all’arte AI vacillare. Perché? Perché gli artisti non nascondono i problemi morali dell’IA, ma li mettono al centro dell’opera. Usano magistralmente le debolezze e le ambiguità dello strumento (distorsione, astrazione, potenziale di sfruttamento) per parlare proprio di quelle debolezze e ambiguità. Il disagio che proviamo di fronte all’uso dell’IA in questo contesto diventa parte integrante dell’esperienza artistica. La scelta di usare questa tecnologia, con tutte le sue implicazioni morali, diventa essa stessa un gesto artisticamente potente e significativo. Il difetto morale dello strumento si trasforma in pregio artistico, contribuendo al valore dell’opera invece di diminuirlo, proprio come suggerito da Eaton.
Verso un Futuro Consapevole: L’Arte AI tra Etica ed Estetica
Cosa possiamo trarre da tutto questo? Che l’arte AI può avere valore, ma probabilmente non ignorando le sue problematiche intrinseche. Forse le opere più significative saranno quelle che, come BECAUSE OF YOU, useranno l’IA in modo critico e consapevole, o quelle che troveranno modi per aggirare i problemi etici.
Stiamo già vedendo artisti che si muovono in questa direzione: alcuni si orientano verso l’astrazione e il “rumore” digitale proprio per allontanarsi dal fotorealismo spesso problematico; altri, come Helena Sarin e Anna Ridler, addestrano le loro IA esclusivamente sulle proprie opere, evitando così lo sfruttamento di dati altrui e preservando la propria estetica unica. Sono segnali che indicano una possibile via d’uscita: un uso dell’IA che sia artisticamente innovativo e moralmente responsabile.
In conclusione, il dibattito sull’arte generata dall’IA non dovrebbe fermarsi alla domanda se sia “vera arte” o se segni la “fine della creatività”. Queste sono, a mio avviso, false piste. La vera sfida è capire come e se possiamo trovare valore in queste opere, considerando le complesse questioni etiche che sollevano. Non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di usarla – e valutarla – con consapevolezza critica. L’arte AI ci invita a riflettere non solo sul futuro dell’arte, ma anche sul nostro rapporto con la tecnologia, i dati, l’etica e l’ambiente. Un invito scomodo, forse, ma tremendamente attuale e necessario.
Fonte: Springer