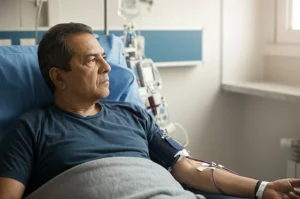Perché non dovrei aspettarmi molto dalla vita? Il viaggio sorprendente verso la guarigione dalla psicosi
Sapete, a volte ci si imbatte in domande che ti scuotono un po’. Una di queste, potentissima, arriva direttamente da uno studio recente: “Perché non dovrei aspettarmi molto dalla vita?”. A porla è Viktoria, una giovane donna che dieci anni fa ha vissuto il suo primo episodio psicotico. Oggi ha un appartamento, amici, un lavoro che le piace e la psicosi è un ricordo. Vista da fuori, sembra clinicamente “guarita”. Ma per lei, il suo percorso di guarigione personale è appena iniziato, perché sta pensando di fare quel “salto” verso un obiettivo di carriera che le avevano sconsigliato. E si chiede, giustamente, perché mai dovrebbe abbassare le sue aspettative.
Questa domanda racchiude l’essenza di una ricerca affascinante che ha voluto capire cosa aiuta davvero le persone a riprendersi a lungo termine dopo un primo episodio di psicosi, sia essa legata alla schizofrenia o a disturbi bipolari. Non si parla solo di “guarigione clinica” – quella misurata dai medici, con meno sintomi e più funzionalità – ma di guarigione personale: quel processo intimo e soggettivo di ritrovare un senso, una vita piena e significativa, anche convivendo con eventuali sintomi residui. E indovinate un po’? Per chi ci è passato, spesso è questa seconda guarigione quella che conta di più.
Abbiamo ascoltato le storie di 20 persone, intervistate 10 o addirittura 20 anni dopo l’inizio del loro percorso di cura. Persone che, secondo i criteri clinici o la loro personale definizione, si considerano “in recupero”. E quello che è emerso è potente, quasi rivoluzionario nel suo messaggio.
Il vero motore della guarigione? Sei tu!
La scoperta più eclatante, quella che ha attraversato tutte le interviste come un filo rosso, è stata questa: i principali artefici della propria guarigione sono le persone stesse. Sì, avete capito bene. Le risorse personali, la propria volontà, la propria agentività – termine un po’ tecnico che significa semplicemente la capacità di agire, di essere protagonisti della propria vita – sono state indicate come il motore fondamentale. I trattamenti, le terapie? Importanti, certo, ma visti come secondari rispetto allo sforzo personale messo in campo.
Questo non significa sminuire l’importanza delle cure, anzi! Ma sposta potentemente il focus: la persona non è un oggetto passivo di trattamento, ma il soggetto attivo che costruisce, giorno dopo giorno, la propria strada verso il benessere. E come lo fanno? Attraverso strategie concrete, scelte quotidiane, un lavoro interiore profondo. Vediamo insieme i temi chiave emersi da queste storie.

Fare la Guarigione Ogni Giorno: Piccoli Passi, Grandi Cambiamenti
La guarigione non è un evento magico, ma qualcosa che si fa, attivamente, nella vita di tutti i giorni. I partecipanti hanno raccontato di una miriade di strategie concrete che hanno adottato, quasi come “trucchi del mestiere” per stare meglio. Qualche esempio?
- Fare esercizio fisico
- Mantenere una routine quotidiana
- Curare il sonno
- Gestire lo stress (ma ne parleremo meglio tra poco)
- Apprezzare la natura
- Coltivare la spiritualità
- Imparare a monitorare i propri segnali interni
Ma al di là delle singole strategie, ciò che conta è l’atteggiamento: prendere in mano le redini, sperimentare cosa funziona per sé. Come Dorthe, una donna di 50 anni che, dopo una carriera interrotta dalla psicosi, ha imparato a trovare gioia e significato anche nelle piccole cose, come guardare la TV di giorno (cosa di cui inizialmente si vergognava) e usarla attivamente per restare informata e avere argomenti di conversazione. Il suo consiglio? “Si tratta di vedere cosa ti porta guarigione. E poi seguire quelle tracce. Aggrappati a ciò che è positivo e alle persone che ti fanno bene.” È l’essenza dell’agentività: essere protagonisti attivi del proprio benessere quotidiano.
Rivalutare il Rischio: Oltre la Paura dello Stress
Questo è un punto davvero interessante e forse controintuitivo. Molti partecipanti, soprattutto all’inizio del loro percorso, avevano ricevuto il consiglio (spesso scritto nero su bianco nelle lettere di dimissione) di evitare lo stress a tutti i costi per prevenire ricadute. Un consiglio basato sul modello stress-vulnerabilità, che ha sicuramente un suo fondamento. Ma cosa succede a lungo termine?
Succede che molte persone, per continuare a crescere e a vivere una vita piena, hanno sentito il bisogno di rivalutare quei limiti autoimposti o suggeriti. Hanno iniziato a testare gradualmente le proprie capacità, a prendersi dei rischi “positivi” per inseguire sogni e aspirazioni. Come William, 30 anni, che ha intrapreso una carriera creativa, stressante sì, ma che per lui è un “gancio di significato” irrinunciabile. O come Dag, anche lui trentenne, che si sentiva “alla deriva su un fenicottero rosa gonfiabile” accettando passivamente i suoi presunti limiti, e che ha deciso di lasciare un lavoro stabile per cercare qualcosa di più significativo, sentendo di aver finalmente iniziato un vero percorso di guarigione personale.
Certo, la paura dello stress e delle ricadute rimane, come per Viktoria all’inizio. Ma emerge chiaramente che una parte cruciale della guarigione a lungo termine è proprio imparare a gestire lo stress in modo diverso, capire che non tutto lo stress è negativo e che evitare ogni sfida può diventare, a sua volta, una gabbia. Si tratta di trovare un nuovo equilibrio, più dinamico e personale, tra protezione e crescita.

Diventare Chi Si Prende Cura: Il Valore di Dare
Un altro aspetto sorprendente emerso dalle storie è il cambiamento nel rapporto con il supporto sociale. Se all’inizio molti erano stati sostenuti da familiari e amici (e questo rimane importante), nella fase di guarigione a lungo termine ciò che sembrava dare più forza e significato era il diventare loro stessi una fonte di supporto per gli altri.
Quasi tutti i partecipanti erano passati dall’essere principalmente “curati” a diventare “curanti”: genitori, partner presenti, amici su cui contare, volontari, persone impegnate nel sociale. Come Iben, che sottolinea come gli amici non siano terapeuti, ma trova grande valore nel prendersi cura dei genitori anziani che l’avevano aiutata anni prima. O Emil, 30 anni, che per molto tempo si è sentito un peso a causa della pensione di invalidità, ma ha ritrovato valore e inclusione aiutando amici e familiari: “Essere una risorsa nella tua comunità… significo qualcosa per gli altri, ho valore… non sono ai margini”.
Prendersi cura degli altri sembra fornire non solo uno scopo, ma anche un’identità positiva che va oltre quella di “paziente” o “utente dei servizi”. Dimostra a sé stessi e al mondo di essere cittadini attivi e preziosi, capaci di dare un contributo significativo.
Negoziare la Normalità: Trovare il Proprio Posto nel Mondo
Come ci si sente dopo aver vissuto un’esperienza così impattante come la psicosi? Come ci si rapporta con il concetto di “normalità”? Le risposte sono state diverse, mostrando una vera e propria negoziazione interiore.
Molti partecipanti, soprattutto all’inizio, sentivano forte il desiderio di “recuperare il tempo perduto”, di raggiungere le tappe considerate normali dai coetanei (lavoro stabile, famiglia, casa) per sentirsi inclusi e non più “diversi”. Magnus, 20 anni, lo dice chiaramente: “una parte importante è essere, forse è una brutta parola in psichiatria, ma essere ‘normale’, seriamente… Voglio solo essere molto nella media”. Per lui, questo significava lavorare sodo per costruirsi una vita ordinaria.
Altri, invece, hanno intrapreso un percorso diverso, quasi rifiutando l’idea di una normalità standardizzata e abbracciando stili di vita più alternativi. Per loro, la guarigione è stata anche liberarsi dalle pressioni sociali e capire chi erano veramente e come volevano vivere. Come Monica, 50 anni, che si chiede: “Chi decide chi ha una buona vita, sai?”. O Geir, 40 anni, che dopo essersi preoccupato a lungo di come appariva agli altri, ha capito che l’importante era smettere di cercare di capire cosa fosse normale: “le persone sono semplicemente diverse”.
Al di là delle scelte individuali, però, emerge un bisogno comune e fondamentale: quello dell’inclusione sociale. Sentirsi parte della società, accettati per quello che si è, con le proprie peculiarità, la propria cultura, le proprie emozioni, senza essere giudicati. Come esclama Liv, 60 anni, con gioia: “Ero così felice per quella domanda [in un questionario]: ti senti parte della società? Sì! Perché prima non mi sentivo così… È meraviglioso essere una persona ordinaria nella società!”. La vera sfida, quindi, non è solo trovare la propria identità, ma anche trovare (e creare) una comunità che sappia accogliere tutti.

Possedere e Condividere la Propria Storia: Il Potere dell’Apertura
Infine, un tema cruciale: quasi tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di aver costruito una narrazione coerente della propria esperienza e di aver trovato il modo e il momento giusto per condividerla con gli altri. L’apertura, anche se strategica (decidere quando, come e con chi aprirsi), sembra essere fondamentale per la guarigione.
Condividere permette di ricevere supporto, di ottenere eventuali accomodamenti necessari (ad esempio sul lavoro), di connettersi con altre persone che hanno vissuto esperienze simili. Ma il presupposto per aprirsi è sentirsi sicuri e aver accettato la propria storia. E qui entra in gioco il pesante fardello dello stigma, specialmente per chi ha ricevuto una diagnosi di schizofrenia.
Molti partecipanti con questa diagnosi hanno espresso disagio per l’etichetta, la paura del giudizio. Come racconta una donna di 30 anni: “Non mi è mai piaciuta quella diagnosi… ho faticato molto ad accettarla. C’è qualcosa nel possedere la tua storia quando devi parlarne”. O Lars, 40 anni, che sente come l’etichetta stessa sia un peso e renda difficile essere onesti: “Avere due cose da gestire, una maschera esterna e un tumulto interiore… lasciar andare questo è importante”.
Possedere la propria storia, accettarla e trovare il coraggio di condividerla, quando e come si ritiene giusto, sembra quindi un passo liberatorio fondamentale. Perché nascondere una parte così importante di sé è faticoso e isolante. Superare lo stigma, sia quello interiorizzato che quello sociale, è una componente essenziale del viaggio.
Cosa possiamo imparare da tutto questo?
Queste storie ci dicono molto. Ci dicono che la guarigione dalla psicosi è un processo lungo, non lineare, spesso ancora in corso anche dopo 10 o 20 anni. Ma è un processo pieno di speranza, dove crescita e cambiamenti positivi possono avvenire anche più tardi nella vita.
Ci dicono che le persone sono incredibilmente resilienti e piene di risorse. E che il supporto migliore è quello che promuove l’agentività, che aiuta le persone a riconoscere e usare i propri punti di forza, a prendere decisioni condivise sul proprio percorso.
Ci suggeriscono che forse dobbiamo ripensare un po’ al messaggio sullo stress: sì, è importante gestirlo, ma anche capire che la capacità di farlo cambia nel tempo, che non tutto lo stress è da evitare e che prendersi dei rischi calcolati può essere vitale per una vita piena. Bisogna supportare quella che Patricia Deegan chiamava “la dignità del rischio e il diritto al fallimento”.
Infine, ci ricordano l’importanza di combattere lo stigma e promuovere una vera inclusione sociale, creando comunità dove tutti possano sentirsi accettati e valorizzati, liberi di possedere e, se lo desiderano, condividere la propria storia. Perché, tornando alla domanda iniziale di Viktoria, tutti meritano di potersi aspettare molto dalla vita.
Fonte: Springer