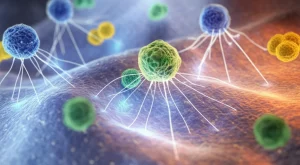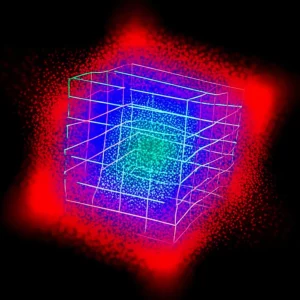Grafene in Acqua: La Nuova Frontiera Sicura per Colpire il Cancro?
Grafene: Meraviglia o Minaccia? La Sfida della Biocompatibilità
Ragazzi, parliamo un attimo di grafene. Sì, quel materiale pazzesco, sottilissimo, super resistente, che sembra uscito da un film di fantascienza. Le sue potenzialità sono enormi, soprattutto in campo medico e oncologico. Immaginate nanoparticelle intelligenti che viaggiano nel corpo per consegnare farmaci direttamente alle cellule malate. Fantastico, vero? Però, c’è un “ma”. Come spesso accade con le novità più potenti, sono emerse preoccupazioni sulla sua possibile tossicità. Diversi studi hanno suonato un campanello d’allarme: alcuni tipi di grafene, o i metodi usati per produrlo, potrebbero non essere così “amichevoli” per le nostre cellule.
Il problema è che la famiglia del grafene è vasta: c’è il grafene a singolo strato (SLG), a pochi strati (FLG), l’ossido di grafene (GO), l’ossido di grafene ridotto (rGO)… ognuno con le sue caratteristiche. Molti metodi di produzione usano solventi chimici aggressivi (come NMP o DMF) o tensioattivi che possono rimanere come “residui” e causare danni alle membrane cellulari o ad altri componenti vitali. L’ossido di grafene (GO), ad esempio, è stato spesso indicato come uno dei più citotossici. Anche le dimensioni, la purezza, il numero di strati e la chimica della superficie dei “fogli” di grafene giocano un ruolo cruciale nella loro interazione con i sistemi biologici. Insomma, non tutto il grafene è uguale, e capire quale sia sicuro ed efficace è fondamentale per portarlo davvero in clinica.
La Nostra Scommessa: Grafene “Pulito” Fatto in Acqua
Di fronte a questa sfida, ci siamo chiesti: è possibile creare un grafene efficace per applicazioni biomediche, ma prodotto in modo più “verde” e sicuro? La risposta, per noi, è stata sì. Abbiamo deciso di puntare sul grafene a pochi strati (FLG) prodotto con una tecnica chiamata esfoliazione in fase liquida assistita da ultrasuoni (ULPE). E la parte migliore? Come solvente abbiamo usato semplice acqua deionizzata purissima! Niente chimici aggressivi, niente solventi tossici.
Abbiamo utilizzato un reattore a ultrasuoni progettato su misura, bombardando polvere di grafite in acqua con onde sonore ad alta energia (24 kHz). Questo processo “sfoglia” la grafite, separando i sottili strati di grafene. Ma non ci siamo fermati qui. Dopo l’esfoliazione, abbiamo centrifugato la sospensione a diverse velocità (500, 1000 e 2000 RPM). Perché? Per separare i “fiocchi” di grafene in base alla loro dimensione e spessore. Abbiamo scoperto che centrifugando a 2000 RPM ottenevamo una frazione (a una concentrazione di circa 16 µg/ml) particolarmente interessante: i fiocchi erano più sottili e la sospensione appariva traslucida, segno di buona qualità.
Ovviamente, dovevamo esserne sicuri. Abbiamo caratterizzato a fondo questo FLG “acquoso” usando spettroscopia UV-Vis (che ha confermato il picco di assorbimento tipico del grafene a 266 nm), spettroscopia Raman (che ha mostrato rapporti tra i picchi D/G, D’/G, 2D/G indicativi di FLG di buona qualità con pochi difetti) e microscopia elettronica a trasmissione ad alta risoluzione (HR-TEM). Quest’ultima ci ha permesso di *vedere* i fiocchi: avevano un’area media di 0.5 µm² e uno spessore medio di 1.5-2 nm, corrispondente a circa 5 strati di grafene. Avevamo tra le mani un FLG ben definito e prodotto in modo ecologico.

Il Test di Sicurezza: Come Reagiscono le Cellule Sane?
Ok, il nostro FLG acquoso sembrava promettente sulla carta. Ma la domanda cruciale era: è sicuro per le cellule viventi? Per scoprirlo, abbiamo iniziato testando la sua citotossicità in vitro su cellule “normali”, i fibroblasti. Abbiamo usato sia una linea cellulare di fibroblasti di topo (NIH 3T3) sia fibroblasti umani (RPE).
Per prima cosa, abbiamo dovuto fare un piccolo aggiustamento. Mettere le cellule direttamente nella nostra sospensione di grafene in acqua pura le faceva… gonfiare e scoppiare (shock osmotico, cose che capitano in laboratorio!). Quindi, abbiamo preparato le nostre dispersioni di FLG in soluzioni isotoniche più adatte alle cellule, come il tampone fosfato salino (PBS) o il terreno di coltura cellulare DMEM (senza siero, per non interferire con il test).
Abbiamo esposto i fibroblasti NIH 3T3 a diverse concentrazioni di FLG ottenute dalle varie centrifugazioni. I risultati sono stati chiari: le frazioni più concentrate (40 µg/ml da 500 RPM e 30 µg/ml da 1000 RPM), che contenevano fiocchi più spessi e aggregati, erano decisamente tossiche, riducendo la vitalità cellulare del 40-45%. Ma la nostra frazione “d’oro” a 16 µg/ml (da 2000 RPM)? Qui la musica cambiava: la vitalità dei fibroblasti rimaneva superiore all’80% dopo 24 ore di esposizione! Questo risultato è in linea con lo standard ISO 10993-5, che considera non citotossico un materiale che permette una vitalità cellulare superiore all’80%.
Per vedere le cose ancora più da vicino, abbiamo usato una tecnica di imaging avanzata: la microscopia multifotone. Questa ci permette di osservare le cellule vive in tempo reale e, contemporaneamente, di visualizzare il grafene (che emette un segnale specifico chiamato Second Harmonic Generation, SHG) senza bisogno di marcarlo. Abbiamo “colorato” i nuclei delle cellule NIH 3T3 con un tracciante fluorescente (Biotracker 650 Red) e poi le abbiamo osservate in presenza del nostro FLG a 16 µg/ml. Le immagini erano spettacolari: vedevamo i nuclei rossi delle cellule vive e vegete, e i segnali verdi dei fiocchi di grafene attorno e tra di loro, senza segni evidenti di danno o stress cellulare. Una conferma visiva della biocompatibilità del nostro materiale a quella concentrazione.

La Sorpresa: Il Grafene “Buono” che Attacca il Cancro
Confortati dai risultati positivi sui fibroblasti sani, abbiamo alzato l’asticella. Come si sarebbe comportato il nostro FLG “eco-friendly” (questa volta preparato in PBS per semplificare) con le cellule tumorali? Abbiamo scelto una linea cellulare molto studiata, le cellule di carcinoma cervicale umano, note come HeLa. Abbiamo testato un range di concentrazioni, sia basse (0.012–0.36 µg/ml) che più alte (0.6–6 µg/ml), confrontando gli effetti sui fibroblasti umani sani (RPE) e sulle cellule HeLa.
Sui fibroblasti umani, i risultati a basse concentrazioni hanno confermato la bassa tossicità: la sopravvivenza cellulare era addirittura superiore al 90%! A concentrazioni più alte (0.6–6 µg/ml), invece, la tossicità aumentava significativamente, causando la morte del 50-60% delle cellule sane. Questo ci dice che c’è una “finestra” di concentrazione in cui il nostro FLG è sicuro per le cellule normali.
E sulle cellule HeLa? Qui è arrivata la vera, intrigante sorpresa. Anche alle basse concentrazioni (0.12–0.36 µg/ml), quelle che erano praticamente innocue per i fibroblasti sani, il nostro FLG causava la morte di circa il 30% delle cellule tumorali HeLa! Questo effetto era paragonabile a quello di un farmaco antimitotico noto, la Reversina, usato come controllo positivo. A concentrazioni più elevate (0.6–6 µg/ml), l’effetto killer sulle HeLa aumentava (50-60% di morte cellulare), ma, come abbiamo visto, a quel punto diventava tossico anche per le cellule sane.
Cosa Significa Tutto Questo? Verso Terapie Mirate e Meno Tossiche
Questo fenomeno di citotossicità selettiva a basse concentrazioni è estremamente interessante. Suggerisce che il nostro FLG acquoso potrebbe avere un duplice ruolo potenziale nella lotta contro il cancro:
- Nanocarrier (Taxi per Farmaci): Essendo biocompatibile a basse dosi per le cellule sane, potrebbe essere usato come veicolo per trasportare farmaci chemioterapici direttamente alle cellule tumorali, riducendo gli effetti collaterali devastanti che questi farmaci hanno sui tessuti sani quando somministrati in modo tradizionale.
- Agente Sensibilizzante: Il fatto che uccida selettivamente una parte delle cellule tumorali a basse dosi suggerisce che potrebbe “indebolire” il tumore, rendendolo più sensibile ad altre terapie come la chemioterapia o la radioterapia a dosi più basse e quindi meno tossiche per il paziente.
Il fatto che siamo riusciti a ottenere questi risultati con un grafene prodotto in acqua, senza solventi tossici, apre scenari davvero promettenti per lo sviluppo di nanotecnologie mediche più sostenibili e sicure (“sustainable-by-design”).

Certo, la strada è ancora lunga. Dobbiamo capire a fondo i meccanismi molecolari che portano a questa uccisione selettiva delle cellule HeLa. Perché il nostro FLG interagisce diversamente con le cellule tumorali rispetto a quelle sane a quelle specifiche concentrazioni? Inoltre, sarà fondamentale testare questo approccio su altri tipi di cancro, magari quelli più aggressivi e difficili da trattare come il cancro al pancreas, alla prostata o al polmone.
Ma i primi passi sono incoraggianti. Aver dimostrato che è possibile produrre un grafene biocompatibile in un sistema acquoso, che mostra una tossicità minima per le cellule sane ma un effetto citotossico mirato sulle cellule cancerose, ci fa ben sperare. Potremmo essere sulla strada giusta per sviluppare nuove armi, più intelligenti e meno dannose, nella nostra battaglia contro il cancro. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro di questa affascinante ricerca!
Fonte: Springer