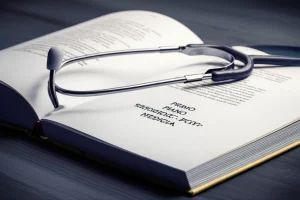Mani che Pensano: Il Linguaggio Segreto dei Gesti nell’Argomentazione Matematica dei Bambini
Avete mai pensato a come i bambini imparano la matematica? Spesso immaginiamo fogli pieni di numeri, operazioni, forse qualche forma geometrica disegnata. Ma se vi dicessi che c’è molto di più? Che l’apprendimento della matematica, fin dalla più tenera età, è un processo vivo, sociale, fatto di discussioni, scoperte e… gesti? Sì, avete capito bene: le mani, il corpo, diventano strumenti potentissimi per esplorare e capire concetti matematici, a volte anche prima che le parole riescano a farlo.
Recentemente mi sono imbattuto in uno studio affascinante che esplora proprio questo: come i bambini in età prescolare usano i gesti durante quelle che gli esperti chiamano “argomentazioni matematiche esplorative”. Sembra un termine complesso, ma l’idea di fondo è semplice e potente. Parliamone un po’.
Ma cos’è l’Argomentazione Matematica Esplorativa (EMA)?
Quando pensiamo all’argomentazione, forse ci viene in mente un dibattito acceso, dove si cerca di convincere l’altro. In matematica, però, soprattutto con i bambini piccoli, l’argomentazione assume una sfumatura diversa, più collaborativa. Non si tratta di “vincere” una discussione, ma di esplorare insieme idee, concetti, possibili soluzioni. È un po’ come costruire qualcosa a più mani: si mettono sul tavolo le proprie scoperte, si sfidano le idee esistenti (anche le proprie!), si cercano schemi, si formulano ipotesi, si traggono conclusioni.
Questo concetto, chiamato Argomentazione Matematica Esplorativa (EMA), vede l’apprendimento come un processo sociale, dove si costruisce conoscenza insieme. Non è solo “imparare ad argomentare”, ma anche “argomentare per imparare”. È un’attività multimodale: non si usano solo le parole, ma anche oggetti, materiali e, appunto, i gesti. Pensateci: quante volte, spiegando qualcosa, abbiamo usato le mani per “disegnare” nell’aria, per indicare, per mimare un’azione? I bambini lo fanno continuamente, ed è una risorsa preziosa.
Lo studio che ha catturato la mia attenzione si concentra proprio su questo aspetto multimodale, analizzando come un gruppo di bambini tedeschi di 5-6 anni affronta un compito di geometria, aiutati da una guida (una studentessa tirocinante). Il fulcro è capire come i gesti, specialmente quelli “collaborativi”, influenzino il loro modo di ragionare e di capire la geometria.
Il Potere Nascosto dei Gesti
Prima di tuffarci nel caso specifico, spendiamo due parole sui gesti. Non sono solo movimenti casuali delle mani mentre parliamo. Gli psicologi e i ricercatori in educazione matematica li hanno studiati a fondo, classificandoli e capendone l’importanza. Ci sono:
- Gesti deittici: i classici gesti dell’indicare, puntando verso oggetti concreti o anche verso uno spazio immaginario a cui abbiamo assegnato un significato.
- Gesti iconici (o descrittivi): quelli che rappresentano visivamente oggetti o azioni. Possono essere statici (formare un triangolo con le mani) o dinamici (mimare la trasformazione di una forma). Questi ultimi sembrano particolarmente legati al ragionamento geometrico.
- Gesti metaforici: rappresentano idee astratte. Immaginate un bambino che mima una sottrazione muovendo la mano da destra a sinistra.
- Gesti coesivi: gesti ricorrenti che aiutano a strutturare il discorso, collegando parti diverse della conversazione.
La cosa straordinaria è che i gesti non servono solo a comunicare con gli altri, ma aiutano anche chi li fa a pensare, a organizzare le idee, a supportare le funzioni cognitive. Sono come un ponte tra la mente e il mondo concreto, esprimendo a volte conoscenze che sono ancora “in formazione”, implicite, non ancora pronte per essere verbalizzate completamente. Ecco perché osservarli nei bambini è così importante!

Gesti Collaborativi: Costruire Idee Insieme
Lo studio introduce un concetto chiave: i gesti collaborativi. Sono quegli scambi gestuali che avvengono quando più persone esplorano insieme idee matematiche, usando i loro corpi “in concerto” per raggiungere un obiettivo comune. È come se un’idea iniziasse con il gesto di una persona e venisse ripresa, modificata, ampliata dal gesto di un’altra.
Una categoria particolarmente interessante di questi gesti è chiamata “Echo and Build” (Eco e Costruzione): una persona fa un gesto, e una seconda persona lo ripete (in tutto o in parte), ma aggiungendo o modificando qualcosa. È proprio questo tipo di interazione gestuale che emerge potentemente nel caso studio analizzato.
Il Caso del Quadrilatero “Strano”
Immaginate la scena: un gruppo di bambini di 5-6 anni, seduti per terra, con davanti tante forme geometriche colorate fatte di gommapiuma. Il compito è semplice: dividerle in triangoli e quadrilateri. Prima, hanno discusso con la loro guida su cosa siano angoli (“Ecke” in tedesco, che significa sia angolo che vertice) e lati, e quanti ne abbiano triangoli e quadrilateri.
Ma c’è un tranello: tra le forme c’è un quadrilatero concavo. Assomiglia molto a un triangolo, ma ha un lato “rientrante” che crea un quarto vertice, appunto, concavo. Come previsto, i bambini inizialmente lo mettono nel gruppo dei triangoli.
La guida chiede allora di verificare che tutti i triangoli abbiano tre vertici e tre lati. Quando arrivano alla forma “strana”, iniziano i problemi. Un bambino, Luca, conta ad alta voce: “Uno, due, tre, quattro lati… e uno, due, tre vertici”. Ops! Qualcosa non torna. La forma viene definita “strana”, “bizzarra”. Un altro bambino, Paul, indica il vertice concavo dicendo: “…qui va dentro così”. Stanno usando gesti deittici (indicare) per supportare il loro conteggio e la loro osservazione.
A questo punto, la guida interviene. Luca, guardandola, le chiede implicitamente aiuto. La guida sposta la forma “strana” tra i due gruppi (triangoli e quadrilateri), aprendo la possibilità che non sia un triangolo. Chiede: “Cos’è un vertice?”. Luca risponde verbalmente: “È sempre dove si incontrano i lati”. Mentre dice l’ultima parte, fa un gesto più dinamico, uno scorrimento della mano verso uno dei vertici “normali” (convessi), come a mimare l’incontro dei lati. Questo gesto diventerà cruciale.

L’Eco che Costruisce la Comprensione
Qui avviene la magia dell’interazione gestuale. La guida riprende l’idea di Luca (“i vertici sono dove si incontrano i lati”), ma fa qualcosa di leggermente diverso con le mani. Adotta il gesto di scorrimento di Luca, ma lo modifica: invece di partire dal vertice, usa entrambi gli indici per scorrere lungo due lati adiacenti fino a farli incontrare nel vertice. Lo fa per i vertici convessi, dicendo: “Allora, QUI i lati si incontrano, quindi abbiamo UN vertice”.
Questo è un perfetto esempio di “Echo and Build”. La guida ha “fatto eco” al gesto di Luca, ma lo ha “costruito”, modificandolo leggermente. Questo piccolo cambiamento sembra innescare qualcosa in Luca. Il focus si sposta: non si tratta più di riconoscere vertici “tipici” e poi applicare la regola (ragionamento induttivo), ma di applicare la definizione in modo più generale (ragionamento deduttivo): ovunque due lati si incontrino, lì c’è un vertice, indipendentemente da come appaia.
Subito dopo questa interazione, Luca riprende il gesto modificato dalla guida e, applicandolo anche al punto concavo, esclama convinto che anche quello è un vertice! Ha usato la definizione, supportata dal gesto collaborativo, per superare l’aspetto ingannevole della forma e arrivare a una comprensione geometrica più profonda. È stato un processo di co-costruzione, dove il gesto è passato da Luca alla guida e di nuovo a Luca, trasformato e potenziato.
La storia non finisce qui. Un altro bambino, Karim, non è ancora convinto. Luca, per difendere la sua idea, formula un’ipotesi: “Se non ci fossero vertici, sarebbe solo un lungo bastone”, accompagnando la frase con un gesto metaforico che mima l’infinito. Poco dopo, un’altra bambina, Marie, ipotizza che piegando la forma in un certo modo diventerebbe un triangolo, mimando la piegatura con un gesto descrittivo dinamico. Vedete? L’argomentazione continua, ricca di ragionamenti ipotetici e supportata da diversi tipi di gesti.

Cosa ci Insegna Tutto Questo?
Questa storia, supportata dall’analisi dettagliata dello studio, ci dice cose importanti. Primo, l’argomentazione matematica nei bambini piccoli è un processo ricco, complesso e multimodale. Secondo, i gesti non sono un contorno, ma una parte integrante del pensiero e della comunicazione matematica, specialmente quando si esplorano concetti nuovi.
In particolare, i gesti collaborativi, come l’“Echo and Build” osservato tra Luca e la guida, possono essere potentissimi catalizzatori per la comprensione. Permettono alle idee di fluire, di essere modellate e rimodellate collettivamente, supportando sia lo sviluppo delle capacità argomentative (“imparare ad argomentare”) sia la costruzione di conoscenza matematica (“argomentare per imparare”).
Quello che trovo incredibile è come un gesto dinamico, come quello dello scorrimento per rappresentare l’incontro dei lati, possa diventare una sorta di “gesto coesivo” che tiene insieme l’argomentazione e aiuta a focalizzarsi sulla definizione chiave, permettendo a Luca di fare un salto logico importante (dal riconoscere esempi al dedurre da una definizione).
Questo studio suggerisce fortemente che noi adulti (insegnanti, educatori, genitori) dovremmo prestare molta più attenzione ai gesti dei bambini durante le attività matematiche. Non solo osservarli, ma forse anche usarli consapevolmente per supportare il loro apprendimento e la loro capacità di esplorare e giustificare le loro idee. Le mani, davvero, possono pensare e aiutare a costruire le fondamenta del pensiero matematico. Non è affascinante?
Fonte: Springer