Germania, Cittadinanza e Migranti: Basta Sguardi a Senso Unico! Verso un Futuro Postmigrante
Eccoci qua, a parlare di un tema che scotta, di quelli che accendono dibattiti e, diciamocelo, spesso ci lasciano con più domande che risposte. Parliamo della Germania, della sua recente riforma sulla cittadinanza del 2024 e di come, forse, è arrivato il momento di guardare alla migrazione con occhi completamente nuovi. Vi siete mai sentiti etichettati, ridotti a una singola caratteristica? Ecco, un po’ è quello che succede spesso quando si parla di migranti: o sono una minaccia, o povere vittime; o una risorsa economica da sfruttare, o un peso sociale. Una visione terribilmente piatta, unidimensionale, che non rende giustizia alla complessità delle persone e della società tedesca di oggi, che è un vero e proprio melting pot in continua evoluzione.
Una Riforma per Cambiare Marcia (Forse)
Partiamo dalla notizia: la Germania ha deciso di riformare le sue leggi sulla cittadinanza. L’obiettivo? Nobile, sulla carta: promuovere l’integrazione e il pluralismo. Il governo di coalizione – formato da Socialdemocratici (SPD), Verdi e Liberali (FDP) – l’ha presentata come una svolta per rendere la Germania “il Paese della speranza”, un posto dove i migranti possano partecipare pienamente alla vita sociale. Tra le novità, la riduzione dei tempi per la naturalizzazione: da otto a sei anni se si frequenta un corso di integrazione, e addirittura cinque per chi mastica il tedesco alla perfezione. Bello, no?
Peccato che, come spesso accade, il diavolo si nasconda nei dettagli e, soprattutto, nel contesto. Proprio mentre si discuteva di queste aperture, saltava fuori la notizia di un incontro segreto a Potsdam tra figure dell’estrema destra, neonazisti e personaggi dell’imprenditoria. Sul tavolo? Un piano di “remigrazione”, ovvero rispedire al mittente milioni di stranieri, compresi quelli con cittadinanza tedesca considerati “non assimilati”. A proporlo, Martin Sellner, un estremista di destra austriaco. E l’AfD (Alternative für Deutschland), il partito di estrema destra tedesco, ha fatto della “remigrazione” un cavallo di battaglia per le elezioni. Sentite René Springer, un loro rappresentante: “Rimanderemo gli stranieri a casa loro. Milioni di loro. Non è un piano segreto. È una promessa”. Brividi, vero?
Queste uscite ci fanno capire quanto sia radicata una certa visione assimilazionista: arrivi, ti spogli della tua cultura d’origine, diventi “tedesco” e fine della storia. Un percorso lineare che, francamente, non esiste più, se mai è esistito. Anche se il termine “integrazione” ha sostituito “assimilazione” nel linguaggio comune, spesso ne è rimasto un sinonimo. E questo approccio vecchio stile continua a influenzare la politica, limitando chi cerca risposte più adeguate alle sfide dell’esclusione e della marginalizzazione.
Superare l’Unidimensionalità: Entra in Scena il “Framework Postmigrante”
Ed è qui che, secondo me e secondo gli autori dello studio che sto analizzando, entra in gioco il concetto di framework postmigrante. Una parolona, forse, ma l’idea di fondo è affascinante. Invece di vedere la migrazione come un problema da risolvere o un fenomeno temporaneo, questo approccio la considera una forza costitutiva e continua della vita sociale. La società non è un blocco monolitico a cui i migranti si devono adattare, ma un organismo dinamico che si trasforma proprio grazie a questi flussi.
Pensateci: la migrazione non è solo una questione di confini e documenti. È un intreccio di storie, esperienze, lotte, che toccano il razzismo, il genere, la classe sociale, l’appartenenza. Il framework postmigrante ci invita a guardare la società nel suo insieme, a capire come negozia il cambiamento e la crescente pluralizzazione. E queste negoziazioni, ammettiamolo, sono spesso polarizzate: da un lato chi vuole estendere diritti e riconoscimenti, dall’altro chi sogna un ritorno a un’immaginaria omogeneità etno-nazionale.
L’approccio unidimensionale, invece, riduce i migranti a soggetti con un’unica etichetta (economica, securitaria) e la migrazione a un singolo tema. Questo non solo è riduttivo, ma ignora il potenziale trasformativo di queste dinamiche. Il framework postmigrante, al contrario, ci offre una bussola per navigare la complessità, tenendo conto del passato, del presente e del futuro della migrazione come parte integrante del tessuto sociale. Vogliamo smettere di vedere i migranti come “altri” e iniziare a considerarli parte del “noi”? Questo è il cambio di prospettiva che serve.

Un Passo Indietro: La Cittadinanza Tedesca tra Sangue e Suolo
Per capire la portata della riforma del 2024, dobbiamo fare un piccolo salto nel passato. Per anni, la Germania si è basata sul principio dello jus sanguinis: eri tedesco se avevi sangue tedesco nelle vene. Un bel problema per i cosiddetti “Gastarbeiter”, i lavoratori ospiti arrivati negli anni ’60 e ’70, e per i loro figli nati e cresciuti in Germania. Poi, nel 2000, una riforma importante ha introdotto elementi di jus soli (cittadinanza per nascita sul territorio), segnando un primo, timido riconoscimento della Germania come paese di immigrazione.
Ma la strada è stata lunga e piena di ostacoli. Pensiamo alla questione della doppia cittadinanza, a lungo osteggiata in nome di una presunta lealtà unica. O alla rappresentanza politica: milioni di residenti stranieri, anche da decenni, esclusi dal diritto di voto, persino a livello locale. E poi c’è il macigno del (non)appartenenza e del razzismo. La parola Ausländer (straniero) si porta dietro uno stigma storico, e gli attacchi razzisti, purtroppo, non sono una novità, colpendo migranti da diverse parti del mondo, afro-tedeschi e altri gruppi razzializzati. Secondo un report del 2022, solo nella Germania orientale e in alcuni altri stati, ci sono stati oltre 2000 attacchi di matrice destrorsa. E non è un fenomeno limitato all’AfD; certi sentimenti anti-immigrati serpeggiano anche tra elettori conservatori e liberali.
Nonostante queste sfide, ci sono stati anche segnali positivi. Una commissione di esperti governativa, nel 2020, ha suggerito di abbandonare l’espressione “persona con background migratorio” (Menschen mit Migrationshintegrund), carica di stereotipi, a favore di “immigrati e loro discendenti”. Piccoli passi, ma significativi, verso un linguaggio più inclusivo.
La Riforma del 2024: Tra Inclusività e Logiche di Mercato
Torniamo alla riforma attuale. Il cancelliere Olaf Scholz ha sottolineato il contributo economico dei migranti alla forza dell’economia tedesca. E l’ex ministra dell’Interno, Nancy Faeser, ha candidamente ammesso che una legge sulla cittadinanza moderna è “una chiave decisiva per la competitività della Germania come piazza economica”. Attireremo i cervelli migliori, dice, solo se potranno diventare pienamente parte della nostra società.
Vedete il pattern? Si parla di inclusione, ma spesso la giustificazione è economica. È quella che Christian Joppke chiama “economizzazione della cittadinanza“: la naturalizzazione diventa uno strumento per attrarre migranti economicamente utili, più che un diritto universale. Questo approccio, che riduce i migranti alla loro desiderabilità sul mercato del lavoro, è stato criticato. Konstantin von Notz, dei Verdi, ha sollevato un punto cruciale: la riforma sarebbe ingiusta se svantaggiasse i migranti richiedendo loro di mantenersi autonomamente, senza sussidi, per ottenere la cittadinanza. La povertà, quindi, come motivo di esclusione.
Anche nel dibattito politico mainstream, l’approccio dominante resta unidimensionale. I migranti devono dimostrare il loro “valore” attraverso il lavoro o conformarsi a ideali europei sempre più escludenti. Si ignora che la migrazione è un processo sfaccettato, non lineare, e che i migranti resistono attivamente a queste classificazioni riduttive.
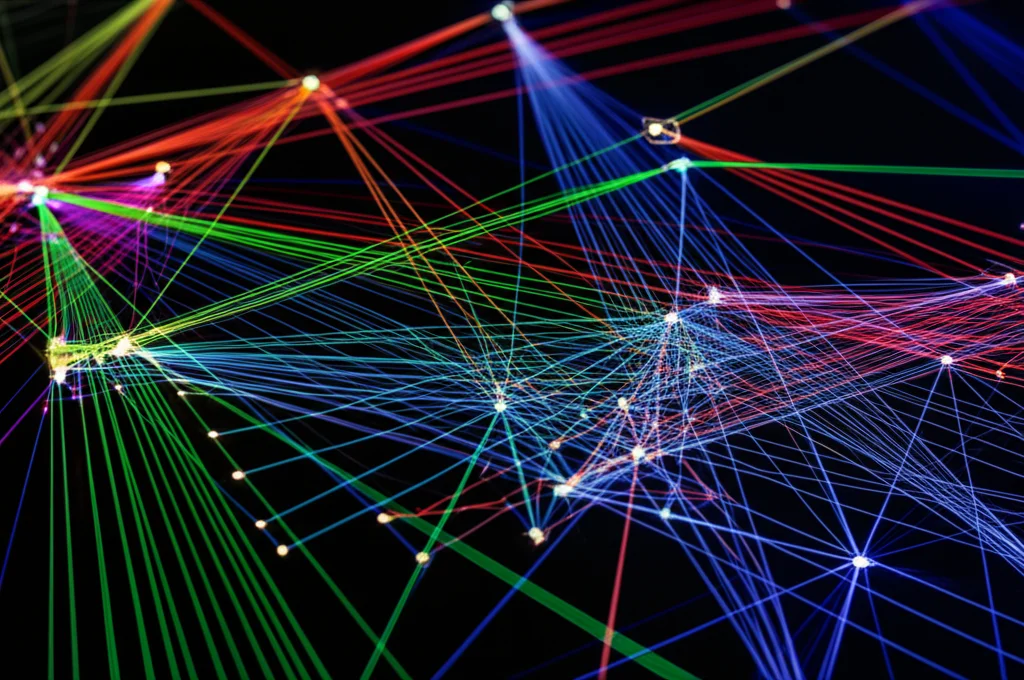
Dalla Ricerca alla Realtà: L’Attivismo Migrante che Fa la Differenza
Per fortuna, non ci sono solo le logiche di palazzo. C’è un mondo di attivismo e ricerca critica che da decenni sfida questa visione monodimensionale. In Germania, la ricerca sulla migrazione è passata da un focus sui “lavoratori ospiti” (Gastarbeiterforschung), poi sugli “stranieri” (Ausländerforschung), fino al paradigma dell’integrazione, che spesso, come dicevamo, si è tradotto in assimilazione.
Ma filoni di ricerca più recenti, come gli studi transnazionali, quelli decoloniali e la “critical migration research”, hanno iniziato a scardinare queste certezze. Hanno mostrato come i migranti mantengano legami transnazionali, come le storie coloniali influenzino le narrative sull’integrazione e come l’agenzia dei migranti sia fondamentale. E qui, il framework postmigrante si sposa perfettamente con queste intuizioni.
Prendiamo l’attivismo. Le lotte dei migranti hanno spesso portato a cambiamenti legislativi e politici. Pensiamo agli scioperi alla Ford negli anni ’70 per i diritti dei lavoratori, o ai dibattiti sull’uso del velo da parte delle insegnanti. Più di recente, in risposta alla riforma sulla cittadinanza, è nata l’iniziativa civile Pass(t) uns allen (“Passaporti per tutti” e, giocando con la ‘t’, “Ci sta bene a tutti”). La loro critica? La riforma, pur aprendo alla doppia cittadinanza, rischia di escludere genitori single poveri, persone con disabilità e apolidi. Chiedono una revisione completa, che adatti la legge alla realtà di una società migratoria diversa e democratica.
E poi c’è il potere delle alleanze intersezionali. Il movimento #unteilbar (#indivisibili) in Germania ha dimostrato come identità diverse possano unirsi, superando le singole rivendicazioni legate alla migrazione per costruire solidarietà più ampie. Le crisi, come ci insegna il politologo Phillip Ayoub, possono acuire la coscienza intersezionale, spingendo gli attivisti a riconoscere la natura interconnessa delle oppressioni (razza, genere, sessualità, classe).
Un esempio toccante è il lavoro di commemorazione portato avanti dalle famiglie delle vittime di attacchi razzisti, come quelli di Mölln (1993) o Hanau (2020). Attraverso organizzazioni e iniziative come “Möllner Rede im Exil” (Discorso di Mölln in esilio) o “NSU-Komplex auflösen” (Sciogliere il complesso NSU), creano piattaforme alternative per parlare delle vittime, chiedere giustizia e costruire una memoria collettiva che sfidi le narrazioni ufficiali. Queste voci ci ricordano che una riforma della cittadinanza, da sola, non basta. Serve una trasformazione collettiva, lo smantellamento delle strutture razziste nella politica, nella polizia, nel sistema giudiziario.

Verso una Società Davvero Postmigrante: Un Invito alla Trasformazione
Allora, cosa ci portiamo a casa da tutto questo? Che il framework postmigrante non è solo una teoria accademica, ma uno strumento potente per ripensare la migrazione e la cittadinanza. Ci aiuta a vedere oltre le etichette, a riconoscere la complessità e, soprattutto, ad affermare i migranti come membri a pieno titolo della società, non definiti solo dal loro status legale o dalla loro utilità economica.
La società postmigrante porta con sé una promessa, quella di un’utopia di uguaglianza che va oltre la categoria di “migrante” come marcatore di differenza. Ma, e questo è il punto cruciale, non si tratta di cancellare la categoria “migrante” in un futuro immaginario. Si tratta di riconoscere che proprio da lì, dalle esperienze e dalle lotte dei migranti, può partire la trasformazione e la democratizzazione della società intera.
La Germania, con la sua storia e le sue contraddizioni, si trova a un bivio. La riforma della cittadinanza del 2024 è un segnale, ma la vera sfida è culturale e politica. Si tratta di passare da una logica di gestione e controllo a una di riconoscimento e partecipazione. Solo così si potrà davvero “disfare l’unidimensionalità” e abbracciare la migrazione non come un fardello o una minaccia, ma come un’abbondanza di possibilità per una trasformazione collettiva. E io, da osservatore appassionato di queste dinamiche, non posso che sperare che questa sia la strada che verrà intrapresa.
Fonte: Springer







