Genocidio: Il Crimine Ignorato dai Criminologi? Un’Assenza Inquietante
Amici lettori, oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi lascia davvero perplesso, quasi incredulo. Mi occupo di crimine, delle sue cause, delle sue manifestazioni, e come tanti nel mio campo, la criminologia, tendiamo a concentrarci su reati che sentiamo più “vicini”: omicidi, rapine, furti, violenze che accadono nelle nostre città. Studiamo anche crimini internazionali come il traffico di esseri umani, il terrorismo, la pirateria. Eppure, c’è un abisso, un vuoto quasi assordante che riguarda uno dei crimini più atroci che l’umanità abbia mai concepito: il genocidio.
Sembra assurdo, vero? Parliamo del “crimine dei crimini”, come è stato definito, eppure, sfogliando le più prestigiose riviste scientifiche di criminologia, internazionali e americane, si scopre una realtà sconcertante: il genocidio è un fantasma. Pochissimi studi, un interesse marginale, quasi un’irrilevanza che stride terribilmente con la gravità del fenomeno.
Cos’è il Genocidio? Un Promemoria Necessario
Forse vale la pena ricordare di cosa parliamo. Il termine “genocidio” fu coniato da Raphäel Lemkin, un avvocato polacco di origine ebraica fuggito agli orrori nazisti. Unì le parole latine geno (razza, tribù) e cide (uccidere) per descrivere lo sforzo coordinato volto a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Ciò che distingue il genocidio dall’omicidio di massa è proprio questo: si viene presi di mira perché si appartiene a quel gruppo specifico.
Grazie all’instancabile lavoro di Lemkin, la comunità internazionale adottò la Convenzione delle Nazioni Unite per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio nel 1948. Questa definisce il genocidio come atti commessi con l’intento di distruggere un gruppo, includendo:
- Uccidere membri del gruppo;
- Causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;
- Sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale;
- Imporre misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;
- Trasferire forzatamente i bambini del gruppo a un altro gruppo.
E pensate che, nonostante il solenne “Mai più” pronunciato dopo l’Olocausto, abbiamo assistito ad almeno altri otto genocidi confermati dal 1945: Cambogia, Guatemala, Ruanda, Srebrenica, Sudan, Iraq, Myanmar… e le preoccupazioni per situazioni attuali, come quella degli Uiguri in Cina, sono altissime. Ci sono persino progetti, come l’Early Warning Project del US Holocaust Memorial Museum, che monitorano costantemente i paesi a rischio di uccisioni di massa. Afghanistan, Pakistan, Yemen, Sudan, India… la lista per il 2023-2024 è lunga e angosciante.

La Scioccante Verità: I Numeri Non Mentono
Di fronte a questa realtà, come è possibile che noi criminologi sembriamo voltare le spalle? Uno studio recente, che ha ispirato questo mio sfogo, ha analizzato 17 importanti riviste internazionali di criminologia in lingua inglese tra il 1999 e il 2023. I risultati sono, francamente, deprimenti.
Su un totale di 15.559 articoli pubblicati in questo periodo, la parola “genocidio” appariva in qualche modo (anche solo in bibliografia o come esempio storico) in 1.231 manoscritti (circa l’8%). Sembrerebbe tanto? Aspettate. Quando i ricercatori hanno setacciato questi 1.231 articoli per trovare quelli che effettivamente studiavano il genocidio come fenomeno criminale, applicando teorie o analisi criminologiche… beh, il numero è crollato.
Tenetevi forte: in 24 anni, solo 115 articoli! Avete letto bene. Centoquindici su oltre quindicimila. E la maggior parte (79) concentrati in una sola rivista, il Journal of International Criminal Justice. Altre, come Crime, Law and Social Change, ne contavano 11. Nove riviste su diciassette, tra cui alcune molto influenti negli Stati Uniti come Crime and Delinquency, Journal of Criminal Justice e Justice Quarterly, non hanno pubblicato nemmeno un articolo che soddisfacesse i criteri dello studio. Zero.
Già nel 2000, uno studio simile di Yacoubian aveva denunciato questa lacuna. Ventiquattro anni e diversi genocidi dopo, la situazione è cambiata pochissimo. Il genocidio rimane insignificante per la stragrande maggioranza della ricerca criminologica.
Ma Perché Questa Indifferenza? Tentativi di Spiegazione
Mi chiedo spesso il perché di questa assenza. Le ragioni possono essere diverse, e forse intrecciate tra loro.
- Focalizzazione sul “locale”: Come dicevo all’inizio, la criminologia, specialmente quella statunitense che ha dominato a lungo il campo, tende a concentrarsi sui problemi di criminalità percepiti come più immediati e rilevanti a livello nazionale o locale. Il genocidio può sembrare “lontano”, un problema di altri.
- Complessità e “lentezza”: Studiare il genocidio non è semplice. Richiede competenze interdisciplinari (storia, scienze politiche, psicologia), accesso a dati difficili da reperire, spesso in contesti post-conflitto. È quella che viene chiamata “slow scholarship”, una ricerca che richiede tempo, pazienza e risorse, forse meno attraente in un mondo accademico che a volte premia la quantità e la velocità.
- Inerzia accademica: Cambiare area di specializzazione è impegnativo. Significa costruire nuove reti di contatti, trovare nuove riviste per pubblicare, imparare nuovi approcci. Forse molti studiosi preferiscono rimanere nel loro “orticello” consolidato.
- Sensibilità politica: Chiamare un evento “genocidio” mentre accade è politicamente esplosivo. Spesso i governi esitano, preferendo termini più vaghi come “pulizia etnica” (che non è un crimine definito a livello internazionale con obblighi di intervento) per non dover agire, come tristemente accaduto in Ruanda o Bosnia. Questa riluttanza politica può forse influenzare anche l’agenda della ricerca?
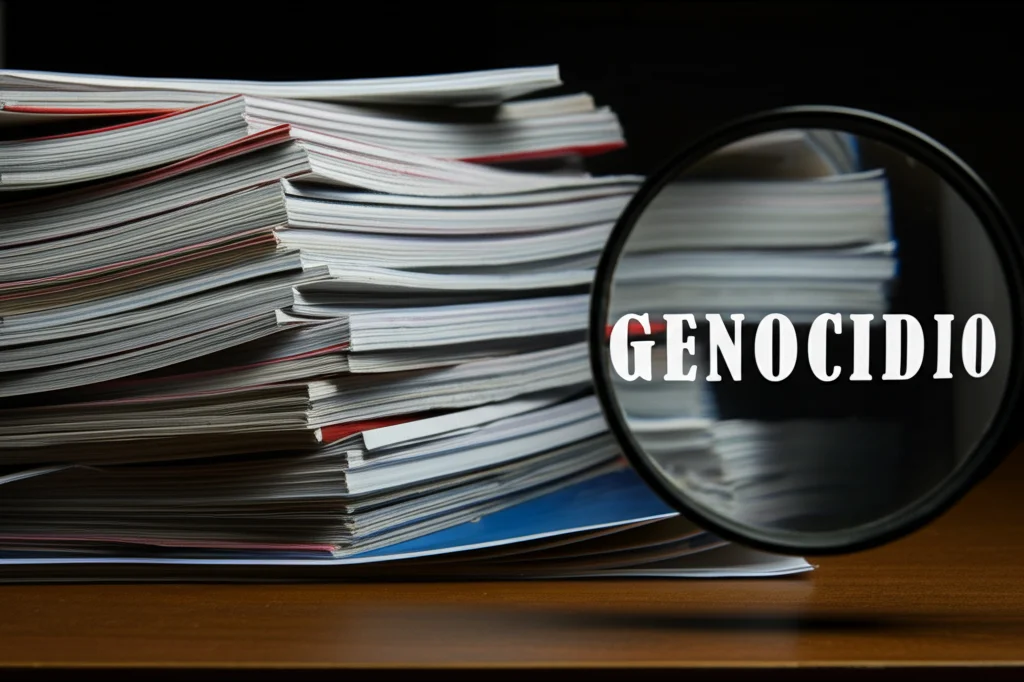
Un Appello Urgente: Criminologi, Fatevi Avanti!
Eppure, credo fermamente che noi criminologi abbiamo tantissimo da offrire alla comprensione e, soprattutto, alla prevenzione del genocidio. Non è un fenomeno al di fuori della nostra portata, non più del terrorismo, che pure ha radici politiche e storiche complesse.
Pensateci: il genocidio è un crimine. Ha autori, vittime, dinamiche specifiche. Avviene in luoghi e contesti particolari. È spesso preceduto da segnali di allarme, da un’escalation di violenza e deumanizzazione. Tutto questo rientra perfettamente nel nostro campo di studi!
Abbiamo teorie consolidate per spiegare il comportamento deviante, la violenza individuale e di gruppo, l’influenza delle situazioni, delle opportunità, delle attività routinarie (routine activity theory), delle scelte razionali (rational choice). Possiamo analizzare come certi luoghi diventano “campi di sterminio”. Possiamo applicare i nostri modelli di prevenzione del crimine (situational crime prevention) per identificare i fattori di rischio e progettare interventi mirati a impedire che le pratiche genocide mettano radici.
Possiamo studiare le relazioni tra vittime e carnefici, che spesso vivono fianco a fianco prima e dopo l’orrore. Possiamo dare voce a gruppi di vittime che magari non rientrano strettamente nella definizione legale di genocidio, ma subiscono violenze assimilabili. Possiamo analizzare il ruolo dell’incitamento all’odio (hate speech), della propaganda, della deumanizzazione nel preparare il terreno al massacro.
Lasciare lo studio del genocidio solo agli storici, ai politologi, agli psicologi o agli “studiosi di genocidio” (un campo a sé stante) significa privare la lotta contro questo crimine di strumenti analitici e preventivi potentissimi che noi possediamo. È un errore critico.
Qualche Spiraglio di Luce (Ma Troppo Debole)
Certo, qualche lavoro criminologico interessante esiste. Ci sono studi che hanno applicato la teoria del conflitto al genocidio in Sudan, la teoria del ciclo di vita (life-course theory) per capire chi partecipa ai massacri in Ruanda (scoprendo, ad esempio, che i genocidari sono in media più anziani dei criminali comuni e che anche le donne partecipano, sebbene meno degli uomini), o analisi sulla vulnerabilità di certi gruppi a diventare vittime, come nel caso del genocidio armeno.
Questi studi dimostrano che l’approccio criminologico è non solo possibile, ma estremamente prezioso. Eppure, rimangono eccezioni. La maggior parte delle volte che il genocidio viene menzionato nelle nostre riviste, è solo di sfuggita, come contesto storico o punto di paragone, senza un’analisi approfondita del crimine in sé con le lenti della criminologia.

In conclusione, la sensazione è amara. Nonostante gli appelli passati, il genocidio continua ad essere un argomento marginale, quasi invisibile, nella criminologia mainstream. È un’assenza che pesa, perché come studiosi del crimine abbiamo il dovere, e gli strumenti, per contribuire a comprendere e prevenire l’inenarrabile. Spero davvero che questa tendenza si inverta. Il mondo ha bisogno anche della nostra voce per gridare, e far sì che sia davvero, “Mai più”.
Fonte: Springer






