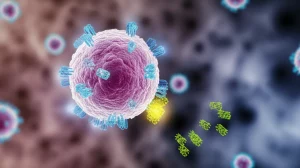Discinesia da Levodopa nel Parkinson: Ehi DNA, Cosa Ci Nascondi?
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che tocca da vicino molte persone che convivono con il Parkinson: la discinesia indotta da Levodopa, o LID (Levodopa-Induced Dyskinesia). Immaginate la Levodopa come il farmaco “gold standard”, il campione indiscusso per gestire i sintomi motori del Parkinson. Funziona alla grande, davvero, ma a volte porta con sé un effetto collaterale piuttosto fastidioso: movimenti involontari, appunto la discinesia. È un po’ come un’arma a doppio taglio che può compromettere seriamente la qualità della vita. E, purtroppo, le soluzioni per contrastarla sono ancora limitate.
Il Viaggio Complesso della Levodopa
Pensate al viaggio che fa la Levodopa una volta ingerita. Non è una passeggiata! Deve attraversare lo stomaco, essere assorbita nell’intestino, superare la barriera che protegge il nostro cervello (la barriera emato-encefalica) e finalmente arrivare dove serve, nello striato. Qui, viene trasformata in dopamina, il neurotrasmettitore mancante nel Parkinson. Ma l’uso a lungo termine, e spesso intermittente, di Levodopa può innescare cambiamenti biochimici e molecolari complessi proprio nello striato. Si parla di rilascio eccessivo di dopamina da terminali non dopaminergici (quelli serotoninergici), recettori super-sensibili, vie di segnalazione intracellulare alterate e persino modifiche nella struttura fisica dei neuroni. Insomma, un bel subbuglio a livello molecolare! E non solo nello striato, anche la corteccia frontale sembra andare “su di giri” nei pazienti con LID.
Alla Ricerca di Indizi nel DNA: L’Approccio GWAS
Dietro tutta questa attività biologica così intensa, c’è ovviamente l’espressione genica. In passato, ci si è concentrati su geni specifici legati al metabolismo della dopamina, come COMT e MAO-B, trovando alcune varianti genetiche associate al rischio di LID. Ma data la complessità del fenomeno, serviva uno sguardo più ampio. Ed è qui che entra in gioco il GWAS (Genome-Wide Association Study). È come usare una lente d’ingrandimento potentissima per scandagliare l’intero genoma alla ricerca di varianti genetiche (principalmente SNP, Single Nucleotide Polymorphisms) associate alla suscettibilità alla LID.
Il problema è che trovare un’associazione tra una variante genetica e la LID non ci dice *come* quella variante influenzi il rischio. Sappiamo però che circa metà delle varianti genetiche influenzano l’espressione dei geni (cioè quanto “attivo” è un gene) in diversi tessuti. Sono i cosiddetti eQTL (expression Quantitative Trait Loci).
Un Passo Avanti: Il TWAS e l’Importanza dell’Espressione Genica
Ecco perché abbiamo pensato: e se le varianti genetiche lungo il percorso della Levodopa (dallo stomaco al cervello) influenzassero il rischio di LID proprio modificando l’espressione di certi geni? Per verificarlo, abbiamo usato un metodo chiamato TWAS (Transcriptome-Wide Association Study). In pratica, abbiamo integrato i dati del nostro GWAS (condotto su una coorte multicentrica cinese di pazienti con Parkinson seguiti per 2.5 anni) con dati pubblici sull’espressione genica (eQTL) provenienti da sei tessuti chiave nel viaggio della Levodopa:
- Stomaco
- Sangue
- Caudato (una regione dello striato)
- Putamen (altra regione dello striato)
- Nucleus Accumbens (coinvolto nel sistema di ricompensa)
- Corteccia Frontale
L’idea era identificare geni la cui *espressione* fosse associata al rischio di sviluppare LID.

Le Nostre Scoperte: Nuovi Geni Sotto i Riflettori
Cosa abbiamo scoperto? Beh, diverse cose interessanti!
1. Il Gene BRD3: Sia il nostro GWAS sulla popolazione cinese, sia una meta-analisi che integrava i nostri dati con quelli di popolazioni europee, hanno puntato il dito su un gene chiamato BRD3 (Bromodomain Containing 3). Curiosamente, le specifiche varianti genetiche all’interno di *BRD3* erano diverse tra le due analisi, ma il gene era sempre lui! Questo gene non era mai stato associato alla LID prima. Le proteine BRD3 fanno parte della famiglia BET, che agisce come “lettore” di modifiche epigenetiche (acetilazione degli istoni) e collabora con altri fattori per controllare l’espressione genica. Studi precedenti su modelli animali avevano mostrato che la stimolazione cronica con Levodopa aumentava l’espressione delle proteine BET nello striato, facilitando l’espressione di geni coinvolti nella plasticità neuronale e nello sviluppo della LID. Inoltre, le proteine BET sono implicate nella neuroinfiammazione, altro fattore importante nella LID. Quindi, è plausibile che varianti nel gene *BRD3* influenzino la suscettibilità alla LID modulando l’espressione di geni chiave. È interessante notare che il nostro TWAS non ha trovato un’associazione significativa tra l’espressione del gene *BRD3* e il rischio di LID, suggerendo che le varianti identificate potrebbero alterare la funzione della proteina BRD3 piuttosto che la sua quantità. Serviranno studi futuri per chiarire questo punto.
2. TRAPPC12-AS1 e WBSCR27: L’Espressione Conta! L’analisi TWAS multi-tessuto è stata particolarmente rivelatrice. Abbiamo identificato due geni la cui espressione sembrava associata alla LID in *tutti e sei* i tessuti analizzati lungo il percorso della Levodopa: TRAPPC12-AS1 (TRAPPC12 Antisense RNA 1) e WBSCR27 (Williams Beuren Syndrome Chromosome Region 27, noto anche come METTL27).
3. Causalità o Semplice Associazione? La Randomizzazione Mendeliana (SMR) Per capire se ci fosse un legame causale tra l’espressione di questi due geni e la LID (e non solo una coincidenza o un effetto pleiotropico), abbiamo usato un’altra tecnica statistica avanzata chiamata SMR (Summary data-based Mendelian Randomization). I risultati hanno confermato l’ipotesi! Abbiamo trovato che i livelli di espressione di entrambi i geni in tutti i tessuti erano causalmente associati al rischio di LID. Nello specifico:
- Una maggiore espressione di TRAPPC12-AS1 era associata a un minor rischio di sviluppare LID. Questo gene produce un RNA “antisenso” che regola negativamente l’espressione del gene TRAPPC12, coinvolto nel traffico di membrane cellulari (fondamentale per il trasporto di proteine). Forse, meno proteina TRAPPC12 significa una minore capacità di supportare l’intensa attività biologica che porta alla LID.
- Una maggiore espressione di WBSCR27 era associata a un maggior rischio di sviluppare LID. La funzione esatta di questa proteina (una metiltransferasi) non è del tutto nota, ma la sua regione cromosomica è implicata nella sindrome di Williams-Beuren, suggerendo un ruolo biologico importante. Forse interviene in modifiche post-trascrizionali che contribuiscono allo sviluppo della LID.

Cosa Significa Tutto Questo? Limiti e Prospettive Future
Questo è il primo studio che usa un approccio così integrato (GWAS + TWAS + SMR) per indagare le basi genetiche della LID. Abbiamo identificato tre nuovi geni candidati (*BRD3*, *TRAPPC12-AS1*, *WBSCR27*) e, soprattutto, abbiamo mostrato come la variabilità genetica possa influenzare il rischio di LID agendo sull’espressione genica in tessuti cruciali per l’azione della Levodopa.
Certo, il nostro studio ha dei limiti. La dimensione del campione non era enorme per un’analisi genomica, e ci sono aspetti metodologici che potrebbero aver introdotto qualche “falso positivo”. L’ideale sarebbe integrare dati genomici e di espressione genica dalla stessa, grande popolazione, ma è difficile da realizzare nella pratica clinica.
Tuttavia, questi risultati aprono nuove, affascinanti prospettive. Ci suggeriscono che non dobbiamo guardare solo ai geni in sé, ma anche a *quanto* e *dove* vengono espressi. Questi geni candidati potrebbero rappresentare nuovi bersagli per future terapie mirate a prevenire o trattare la discinesia da Levodopa. La strada è ancora lunga, e serviranno studi più ampi e di conferma, ma abbiamo aggiunto alcuni tasselli importanti al complesso puzzle della LID. Continueremo a scavare!
Fonte: Springer