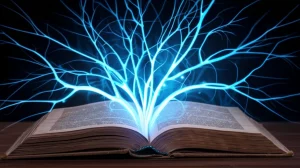Occhi Che Imparano: Sveliamo i Segreti del Cervello con l’Eye-Tracking
Ciao a tutti! Avete mai pensato a come impariamo davvero? Specialmente quando si tratta di concetti scientifici un po’ ostici, quelli che magari ci portiamo dietro in modo sbagliato fin dalle scuole superiori? È un bel rompicapo, vero? Ecco, nel mio campo di ricerca, ci siamo tuffati proprio in questo mistero: capire cosa succede nella nostra testa quando finalmente riusciamo a “cambiare idea” su un concetto scientifico, abbandonando una vecchia convinzione errata per abbracciare quella corretta. Questo processo si chiama cambiamento concettuale, ed è fondamentale per l’apprendimento scientifico.
Il Mistero delle Idee Sbagliate (e Come Correggerle)
Partiamo da un fatto: le nostre “concezioni alternative” – quelle idee un po’ sballate che tutti abbiamo su come funziona il mondo – sono dure a morire. Non sono semplici errori, spesso sono convinzioni radicate, resistenti anche alle migliori spiegazioni in classe. Pensate a quante volte abbiamo sentito o pensato cose come “le stagioni dipendono dalla distanza Terra-Sole” o “gli oggetti pesanti cadono più velocemente di quelli leggeri”. Sbagliato! Ma perché è così difficile sradicarle?
La ricerca ci dice che per far avvenire questo cambiamento, spesso serve creare un “conflitto cognitivo”, cioè farci rendere conto che la nostra idea attuale non regge, che c’è qualcosa che non torna. Ma non basta! Sembra cruciale anche fornire dei nuovi “mental set“, una sorta di ‘schema mentale’ o ‘cornice interpretativa’ nuova e più efficace per capire il fenomeno. Immaginate di dover montare un mobile IKEA senza le istruzioni giuste: potreste anche capire che state sbagliando (conflitto cognitivo), ma senza lo schema corretto (il nuovo mental set), difficilmente arriverete al risultato desiderato.
Il ragionamento scientifico gioca un ruolo chiave in tutto questo. Non basta vedere un esperimento che contraddice la nostra idea; dobbiamo essere in grado di ragionare sul perché la nuova spiegazione è più logica e convincente, collegandola a ciò che già sappiamo. Ma come avviene esattamente questo processo a livello cognitivo? Cosa succede nella nostra mente, istante per istante?
L’Esperimento: Occhi Puntati sullo Schermo
Per indagare più a fondo, abbiamo messo a punto un esperimento affascinante. Abbiamo creato dei programmi al computer progettati apposta per sfidare alcune comuni concezioni alternative in fisica, biologia e chimica. Abbiamo coinvolto 60 studenti universitari con una solida base scientifica e li abbiamo divisi casualmente in due gruppi:
- Un gruppo (chiamiamolo RWMS) usava un programma che, dopo aver mostrato un video-esperimento “spiazzante”, forniva esplicitamente dei nuovi “mental set” su cui ragionare.
- L’altro gruppo (RWOMS) vedeva lo stesso video ma non riceveva questi aiuti espliciti per il ragionamento.
Abbiamo anche variato la difficoltà dei compiti: alcuni erano più semplici (richiedevano un solo nuovo mental set per essere capiti), altri più complessi (ne richiedevano diversi).
Ma la vera chicca è stata questa: mentre gli studenti affrontavano questi compiti, abbiamo usato un eye-tracker! Si tratta di uno strumento incredibile che segue con precisione millimetrica dove si posa lo sguardo sullo schermo, per quanto tempo (fissazioni), come si sposta (saccadi) e se torna a leggere parti già viste (rereading). L’idea di base, nota come “ipotesi occhio-mente”, è che c’è una forte correlazione tra dove guardiamo e a cosa stiamo pensando in quel momento. In pratica, l’eye-tracker ci ha aperto una finestra diretta sui processi attentivi e cognitivi degli studenti durante il cambiamento concettuale.

Cosa Ci Hanno Detto gli Occhi? Risultati Sorprendenti
Ebbene, cosa abbiamo scoperto spiando… ehm, monitorando i loro occhi?
1. I “Mental Set” Fanno la Differenza (ma non sempre):
Come ci aspettavamo, il gruppo RWMS, quello che riceveva l’aiuto esplicito per il ragionamento, ha avuto risultati significativamente migliori nel spiegare verbalmente il perché dei fenomeni osservati. Questo conferma che fornire attivamente nuovi schemi mentali aiuta a ristrutturare le conoscenze. Curiosamente, però, quando si trattava solo di scegliere la risposta corretta tra opzioni multiple alla fine, i due gruppi si sono quasi equivalevati. Forse le opzioni stesse fungevano da “mental set” implicito all’ultimo minuto? Da indagare!
2. Facile è Meglio (ovviamente!), ma gli Occhi si Comportano Diversamente:
Non sorprende che gli studenti abbiano avuto più successo con i compiti a bassa difficoltà. Ma l’eye-tracker ci ha rivelato dettagli interessanti:
- Nei compiti facili: fissazioni mediamente più lunghe (MFD), saccadi medie più lunghe (MSD) e tempi medi di rilettura più lunghi (MRT). Sembra indicare un’elaborazione più approfondita e mirata.
- Nei compiti difficili: più fissazioni totali (NOF), più saccadi totali (NOS), più riletture (NOR) e tempo totale di rilettura maggiore (TRT). Questo suggerisce uno sforzo maggiore, forse un po’ di confusione, una ricerca più affannosa di informazioni.
3. Lo Sguardo di Chi Capisce è Diverso:
Questa è forse la scoperta più affascinante, emersa analizzando i dati con tecniche come le “heat map” (mappe di calore che mostrano dove si concentra lo sguardo) e l’analisi sequenziale (LSA), che studia l’ordine in cui si guarda diverse aree di interesse (AOI).
Prendiamo l’esempio dell’esperimento delle candele (quello in cui si mette un barattolo sopra delle candele accese e si vede l’acqua salire):
- Chi riusciva a capire il concetto corretto (legato alla dilatazione/contrazione dell’aria per il calore, non al consumo di ossigeno) tendeva a fissare più a lungo le aree cruciali (es. le candele accese, il livello finale dell’acqua). Ma soprattutto, l’analisi sequenziale ha mostrato connessioni bidirezionali significative tra le aree di interesse (es. guardavano avanti e indietro tra il barattolo con 5 candele e quello con 3, confrontando attivamente). Questo suggerisce un processo attivo di confronto, integrazione e verifica delle ipotesi.
- Chi invece non riusciva a cambiare la propria idea sbagliata, fissava meno le AOI e mostrava più connessioni unidirezionali. Sembrava quasi che seguissero gli eventi senza integrarli e confrontarli efficacemente per mettere in discussione la loro idea preconcetta.
![]()
Il Potere Predittivo dello Sguardo
Ma non è finita qui. Analizzando tutti i dati con modelli statistici avanzati (GEE), abbiamo scoperto qualcosa di potentissimo: i movimenti oculari possono predire sia la difficoltà del compito che lo studente sta affrontando, sia la probabilità che riesca a raggiungere il cambiamento concettuale!
In particolare, il numero di fissazioni (NOF) è emerso come il fattore predittivo più importante:
- Un NOF più alto era associato alla probabilità di star lavorando su un compito a bassa difficoltà.
- Un NOF più alto era anche il miglior predittore del successo nel cambiamento concettuale (seguito, a distanza, dalla durata media delle fissazioni, MFD).
Questo è rivoluzionario! È la prima volta che si dimostra che possiamo “leggere” negli occhi non solo l’attenzione, ma anche la difficoltà percepita e la probabilità di successo nell’apprendimento di concetti scientifici complessi. Un numero maggiore di fissazioni, in questo contesto, sembra indicare una ricerca attiva e un’elaborazione più distribuita delle informazioni cruciali presentate nel video, fondamentale per costruire i nuovi mental set.
Uno Sguardo al Futuro: Eye-Tracking e Apprendimento Intelligente
Cosa significa tutto questo per il futuro dell’educazione? Le potenzialità sono enormi! L’eye-tracking, pur essendo ancora agli inizi nell’applicazione didattica, ci offre uno strumento potentissimo per:
- Capire meglio come gli studenti interagiscono con i materiali didattici.
- Identificare in tempo reale dove incontrano difficoltà.
- Visualizzare i percorsi attentivi e promuovere l’automonitoraggio negli studenti.
Immaginate sistemi di apprendimento online che, monitorando lo sguardo, capiscono se siete bloccati o confusi e vi offrono aiuti personalizzati (un suggerimento, un video esplicativo, un richiamo a un concetto chiave) proprio nel momento del bisogno. Combinando l’eye-tracking con l’intelligenza artificiale (magari quella generativa, capace di creare feedback istantanei), potremmo creare esperienze di apprendimento davvero adattive e personalizzate, capaci di guidare lo studente verso le aree cruciali e facilitare quel delicato processo di cambiamento concettuale.
Certo, ci sono limiti. L’eye-tracking ci dice dove guardiamo, ma non direttamente cosa stiamo pensando o quale specifica conoscenza stiamo recuperando dalla memoria. Per questo, la ricerca futura dovrà integrare questi dati con altre tecniche, come il “think-aloud” (chiedere agli studenti di verbalizzare i loro pensieri) o misure neuroscientifiche.
Ma la strada è tracciata. Osservando attentamente gli occhi di chi impara, stiamo iniziando a decifrare i complessi meccanismi cognitivi che sottostanno all’apprendimento scientifico. È un viaggio affascinante nel cuore della mente umana, e siamo solo all’inizio!

Fonte: Springer