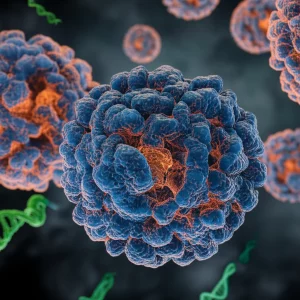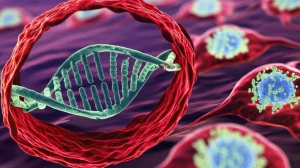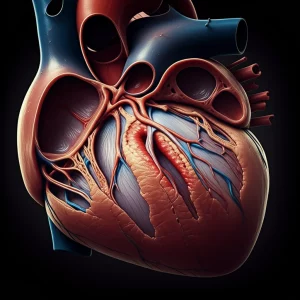Infarto e Gene Nascosto: L’Ematopoiesi Clonale Rivela Rischi a Lungo Termine dopo 10 Anni
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi sta molto a cuore, letteralmente! Parliamo di infarto, in particolare di quello che i medici chiamano STEMI (infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST). È una brutta bestia, lo sappiamo. Ma vi siete mai chiesti perché, a parità di cure, alcuni pazienti se la cavano meglio di altri nel lungo periodo? Ecco, è una domanda che ci siamo posti anche noi, e dopo 10 anni di ricerca, abbiamo scovato un potenziale colpevole, un po’ subdolo, che si nasconde nel nostro sangue: l’ematopoiesi clonale.
Cos’è questa Ematopoiesi Clonale (CHIP)?
Magari vi state chiedendo: “Ematopoiesi clonale? Che roba è?”. Tranquilli, cerco di spiegarvelo in parole povere. Immaginate le cellule staminali del vostro midollo osseo, quelle che producono tutte le cellule del sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine). A volte, soprattutto con l’avanzare dell’età, ma non solo, alcune di queste cellule “capostipiti” subiscono delle mutazioni genetiche. Se queste cellule mutate iniziano a proliferare più delle altre, si crea un “clone” di cellule del sangue che portano tutte quella specifica mutazione. Quando questo fenomeno si verifica in persone che non hanno ancora sviluppato un vero e proprio tumore del sangue (come una leucemia), parliamo di ematopoiesi clonale di potenziale indeterminato, o più semplicemente CHIP (dall’inglese Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential).
Per anni, la CHIP è stata considerata una condizione pre-maligna, un campanello d’allarme per possibili futuri problemi ematologici. Ma la ricerca più recente, inclusa la nostra, sta svelando un lato ancora più insidioso: il suo legame con le malattie cardiovascolari.
Il Nostro Studio Decennale: Cosa Abbiamo Fatto?
Per capirci di più, abbiamo condotto uno studio prospettico, seguendo per un periodo lunghissimo, oltre 10 anni (120 mesi, per la precisione!), un gruppo di 101 pazienti che avevano avuto uno STEMI e che erano stati sottoposti a un intervento di angioplastica coronarica percutanea (PCI) d’urgenza. Abbiamo prelevato campioni di sangue e, grazie a una tecnica super avanzata chiamata sequenziamento dell’intero esoma, siamo andati a caccia di queste mutazioni CHIP. Poi, abbiamo confrontato i dati genomici di questi pazienti con quelli di un gruppo di controllo composto da 706 individui senza eventi cardiovascolari pregressi.
L’obiettivo era duplice: capire quanto fosse diffusa la CHIP nei pazienti con STEMI e, soprattutto, se la sua presenza potesse influenzare la loro prognosi a lungo termine, cioè il rischio di andare incontro a nuovi problemi cardiaci.
Le Scoperte Chiave: CHIP e Infarto, un Legame Pericoloso
E cosa abbiamo scoperto? Beh, preparatevi, perché i risultati sono piuttosto eloquenti.
- Innanzitutto, la CHIP è risultata significativamente più comune nei nostri pazienti con STEMI: ben il 37,6% di loro presentava mutazioni somatiche associate alla CHIP (con una frequenza allelica variante dell’1% o superiore), rispetto al 22,8% riscontrato nel gruppo di controllo. Una bella differenza, no?
- Abbiamo anche identificato i “colpevoli” più frequenti. Nei pazienti con STEMI, le mutazioni più comuni riguardavano i geni ASXL1 e CREBBP, entrambi presenti nel 5% dei casi in questo gruppo.
- Ma la scoperta più impattante riguarda il follow-up a lungo termine. I pazienti con STEMI che presentavano CHIP hanno avuto un’incidenza significativamente più alta di eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE). Per MACE intendiamo un insieme di brutte cose: morte per qualsiasi causa, infarto miocardico ricorrente, ictus, necessità di nuove rivascolarizzazioni (altri bypass o angioplastiche) e ricoveri per angina o scompenso cardiaco. Dopo aver aggiustato i dati per altri fattori di rischio come età e sesso, il rischio per i portatori di CHIP era più che raddoppiato, con un hazard ratio di 2.23!

Questo significa che la presenza di CHIP non è solo una curiosità genetica, ma un vero e proprio fattore di rischio che può peggiorare la prognosi di chi ha già subito un infarto.
Perché Proprio Quei Geni? E le Differenze Etniche?
Una delle cose che ci ha colpito è stata la “personalità” di queste mutazioni. Mentre studi precedenti, spesso condotti su popolazioni caucasiche, avevano messo in luce geni come DNMT3A e TET2, nel nostro studio su una coorte asiatica sono emersi con forza ASXL1 e CREBBP. Questo suggerisce che potrebbero esserci delle differenze etniche nella prevalenza e nel tipo di mutazioni CHIP più rilevanti, un po’ come accade per altre condizioni o per la risposta ad alcuni farmaci. Pensate al “paradosso dell’Asia orientale” con il clopidogrel: maggiore reattività piastrinica nonostante la terapia, ma tassi inferiori di eventi ischemici, legati a varianti genetiche specifiche.
Ma perché proprio ASXL1 e CREBBP sembrano così “cattivi” nel contesto dello STEMI?
- Il gene CREBBP è un po’ un direttore d’orchestra nella cellula: è un’acetiltransferasi istonica che regola l’espressione di molti geni, influenzando processi come l’ematopoiesi, la differenziazione cellulare, la riparazione del DNA e la sorveglianza immunitaria. Mutazioni in CREBBP possono compromettere queste funzioni, ad esempio riducendo la presentazione dell’antigene e facilitando l’evasione immunitaria, ma anche attivando percorsi pro-infiammatori. Questo stato infiammatorio cronico esagerato può contribuire alla rottura della placca aterosclerotica e promuovere un rimodellamento cardiaco sfavorevole (fibrosi) dopo l’infarto.
- Il gene ASXL1 è anch’esso coinvolto nella regolazione epigenetica. Le sue mutazioni sono state associate a uno stato pro-trombotico, in parte attraverso una maggiore attivazione dell’inflammasoma AIM2, che porta a un aumento della secrezione di citochine pro-infiammatorie come l’IL-1β. In pratica, le cellule con ASXL1 mutato possono promuovere l’infiammazione vascolare e creare un ambiente più favorevole alla formazione di trombi.
Nel nostro studio, le mutazioni in ASXL1 sono state associate a un rischio di MACE addirittura 13.7 volte superiore, e quelle in CREBBP a un rischio 9.9 volte superiore! Questi due “giocatori” sembrano quindi avere un impatto particolarmente pesante.
Cosa Significa Tutto Questo per i Pazienti?
Queste scoperte aprono scenari molto interessanti. L’idea è che, in futuro, lo screening per la CHIP potrebbe diventare uno strumento in più per stratificare meglio il rischio dei pazienti dopo uno STEMI. Non tutti gli infarti sono uguali, e non tutti i pazienti rispondono allo stesso modo nel tempo. Identificare quelli con mutazioni CHIP ad alto rischio, come quelle in ASXL1 o CREBBP, potrebbe permetterci di personalizzare le strategie di prevenzione secondaria.
Immaginate di poter dire a un paziente: “Guarda, hai questa particolare mutazione che ti espone a un rischio maggiore. Dobbiamo essere ancora più aggressivi con la terapia anti-infiammatoria o con quella anti-trombotica”. Potremmo pensare a farmaci specifici che agiscono sui meccanismi infiammatori o trombotici esacerbati da queste mutazioni. Ad esempio, farmaci che bersagliano l’IL-1β (come il canakinumab, che nello studio CANTOS ha mostrato benefici specie in chi aveva CHIP in TET2) o regimi antiaggreganti più potenti potrebbero essere considerati per questi pazienti.

Il nostro studio ha usato il sequenziamento dell’intero esoma con una soglia di VAF (frequenza allelica variante) dell’1%, più bassa rispetto ad altri studi che usavano il 2%. Questo ci ha permesso di catturare un spettro più ampio di mutazioni, incluse quelle presenti in cloni cellulari più piccoli, ma che sembrano comunque avere un impatto clinico rilevante.
Limiti e Prospettive Future
Certo, come ogni studio, anche il nostro ha dei limiti. È stato condotto in un singolo grande ospedale universitario, e la popolazione era asiatica, quindi i risultati andranno confermati in altre etnie. Inoltre, il numero di pazienti, sebbene seguito per un tempo molto lungo, potrebbe non essere sufficiente per trarre conclusioni definitive su ogni singola e rara mutazione CHIP. Non avevamo nemmeno dati sui livelli di biomarcatori infiammatori specifici come IL-6 o IL-1β, che sarebbero stati interessanti da correlare.
Nonostante ciò, i nostri dati illuminano la notevole prevalenza delle mutazioni CHIP, in particolare in geni come ASXL1 e CREBBP, tra i pazienti con STEMI. Il fatto che le mutazioni in ASXL1 siano più frequenti nei pazienti con STEMI rispetto ai controlli ne sottolinea il potenziale ruolo nella patogenesi dell’infarto stesso. Queste mutazioni influenzano significativamente la sopravvivenza libera da eventi cardiovascolari avversi, il che ci spinge a chiedere ulteriori studi, più ampi e multicentrici, per corroborare queste scoperte.
In conclusione, l’ematopoiesi clonale sta emergendo come un attore importante, e non sempre benigno, sulla scena cardiovascolare. Capire il suo ruolo e identificare le mutazioni specifiche che conferiscono un rischio maggiore potrebbe davvero fare la differenza nella gestione a lungo termine dei pazienti che hanno superato la fase acuta di un infarto. La strada è ancora lunga, ma ogni scoperta ci avvicina a una medicina sempre più personalizzata e precisa. E questa, per me, è la parte più affascinante del nostro lavoro!
Fonte: Springer