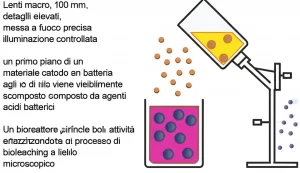Batterie al Litio: La Svolta Oltre il 99,9% con un Elettrolita “Superconcentrato” e Compresso!
Ciao a tutti! Scommetto che anche voi, come me, sognate un mondo dove i nostri smartphone durano giorni, le auto elettriche percorrono migliaia di chilometri con una carica e l’energia rinnovabile può essere immagazzinata in modo super efficiente. Beh, una grossa fetta di questo sogno passa attraverso il miglioramento delle batterie, e in particolare, quelle al litio metallico.
Da tempo noi ricercatori consideriamo il litio metallico come l’elettrodo negativo “definitivo”, il Santo Graal per batterie ad altissima densità energetica, capaci di superare la soglia dei 500 Wh/kg. Immaginate quanta energia in più potremmo stipare! Ma, come in ogni bella storia, c’è un “ma”, anzi, più di uno.
Il Tallone d’Achille del Litio Metallico
Il problema principale è che il litio metallico è un tipo piuttosto… reattivo. Ha un potenziale redox estremamente basso, il che significa che tende a reagire con quasi tutto, specialmente con gli elettroliti liquidi con cui deve convivere all’interno della batteria. Queste reazioni collaterali sono un vero disastro: consumano il litio attivo, degradano l’elettrolita e portano a un rapido fallimento della batteria, soprattutto quando si cerca di usare poco elettrolita e una quantità risicata di litio, come si fa nelle applicazioni pratiche per massimizzare l’energia.
Al centro di questa battaglia c’è la cosiddetta SEI (Solid Electrolyte Interphase). Immaginate una pellicola protettiva che si forma sulla superficie del litio quando entra in contatto con l’elettrolita. Idealmente, questa SEI dovrebbe essere stabile, condurre ioni litio ma bloccare gli elettroni, proteggendo il litio da ulteriori reazioni. Purtroppo, spesso questa pellicola è instabile, si rompe e si riforma continuamente, consumando sempre più litio ed elettrolita. Un vero incubo!
Negli anni, abbiamo provato di tutto per domare questa bestia: elettroliti ad alta concentrazione, elettroliti localmente concentrati (LHCE), elettroliti fluorurati, additivi speciali, persino gas liquefatti come elettroliti. L’idea di base di molte di queste strategie è quella di “convincere” più anioni (le particelle cariche negativamente nell’elettrolita) ad avvicinarsi agli ioni litio, in modo da formare una SEI più robusta e ricca di composti inorganici, derivati proprio da questi anioni.
Gli LHCE, ad esempio, hanno mostrato risultati promettenti, superando il 99,5% di efficienza coulombica (CE). L’efficienza coulombica, in parole povere, ci dice quanto del litio che “depositiamo” durante la carica riusciamo a “recuperare” durante la scarica. Più è alta, meglio è. Però, molti LHCE usano diluenti fluorurati che, pur aiutando, possono partecipare alla formazione della SEI e causare perdite aggiuntive, oltre a limitare un po’ la quantità di anioni che possono effettivamente circondare gli ioni litio. Insomma, c’era ancora spazio per migliorare e puntare a quel fatidico 99,9% e oltre, senza ricorrere a soluzioni troppo costose o complicate da gestire.
La Nostra Idea: Un Elettrolita “Sotto Pressione” con Struttura di Solvatazione Compressa
Ed è qui che entra in gioco la nostra ultima fatica! Ci siamo detti: e se potessimo letteralmente “comprimere” la struttura di solvatazione attorno agli ioni litio? La solvatazione è il processo in cui le molecole di solvente (e gli anioni) si dispongono attorno a uno ione. L’idea era di spingere più anioni possibile vicino agli ioni litio, formando dei “cluster” di solvatazione super compatti. È un po’ come cercare di far stare più amici in una macchina piccola: si stringono un po’, ma ci stanno tutti!
Per fare questo, abbiamo messo a punto un elettrolita che abbiamo chiamato “super-saturo con struttura di solvatazione compressa”. Abbiamo usato un sale di litio molto performante, il LiFSI (bis(fluorosulfonyl)imide di litio), e lo abbiamo sciolto in una miscela di solventi composta da DME (dimetossietano) e un componente chiave: il ClDEE (2,2-diclorodietiletere). Il ClDEE, da solo, non scioglie quasi per niente il LiFSI, quindi agisce come una sorta di “diluente non solvatante”. Però, quando combinato con il DME in un rapporto specifico (1:7 in volume DME:ClDEE), ci ha permesso di sciogliere una quantità di LiFSI pari a 2M, che si traduce in una concentrazione locale pazzesca di 16 mol/L di sale LiFSI nella fase DME! Un vero record!
Questa “compressione” non solo rende l’elettrolita intrinsecamente più stabile contro la riduzione sul litio metallico, ma favorisce anche una passivazione rapida e completa dell’elettrodo, portando a una deposizione e rimozione del litio estremamente efficienti.

Cosa Ci Dicono le Analisi? Un’occhiata da Vicino
Per capire cosa succedeva a livello microscopico, abbiamo usato simulazioni di dinamica molecolare (MD). Queste ci hanno mostrato che nel nostro elettrolita Cl 7 (così l’abbiamo battezzato per via del rapporto 1:7 DME:ClDEE), il numero di anioni FSI– coordinati attorno allo ione litio era significativamente più alto (2.51) rispetto a quello delle molecole di solvente DME (1.13). Inoltre, gli atomi di ossigeno del ClDEE si posizionavano appena fuori dalla prima shell di solvatazione, come uno strato esterno che “comprimeva” il tutto.
Abbiamo confermato questi risultati con esperimenti. La spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) del 7Li ha mostrato un comportamento anomalo nel nostro Cl 7: la densità di nuvola elettronica attorno al Li+ era notevolmente più alta rispetto agli elettroliti convenzionali ad alta concentrazione. Questo, secondo noi, è dovuto proprio alla ridotta distanza tra Li+ e anioni FSI– nella struttura compressa, che porta a cluster di solvatazione più piccoli e a una nuvola elettronica più densa.
Anche la diffrazione di raggi X a grande angolo (WAXS) ci ha dato una mano, rivelando la presenza di distanze interatomiche più corte nell’elettrolita Cl 7, a ulteriore conferma dei cluster di solvatazione più compatti. Insomma, tutte le prove convergevano: avevamo davvero creato una struttura di solvatazione super-arricchita di anioni e molto compatta!
L’Efficienza Coulombica: Quel Magico 99,9% (e Oltre!)
Ma la vera prova del nove è sempre quella elettrochimica. Abbiamo testato la compatibilità del nostro elettrolita con il litio metallico in celle Li||Cu. La voltammetria ciclica ha mostrato una decomposizione riduttiva estremamente soppressa per l’elettrolita Cl 7, segno di una stabilità intrinseca superiore.
E l’efficienza coulombica? Preparatevi: in condizioni di deposizione/strippaggio completo (0.5 mA/cm2, 1 mAh/cm2), l’elettrolita Cl 7 ha raggiunto un’efficienza iniziale del 97.81%, salendo rapidamente al 99% in soli 6 cicli e mantenendo una media del 99.48% per oltre 500 cicli! Ma non ci siamo fermati qui. Usando il metodo di Aurbach modificato, che è più rappresentativo delle condizioni reali, abbiamo toccato un incredibile 99.91% di CE, e dopo ulteriori 150 cicli, siamo arrivati addirittura al 99.96%! Questi valori sono tra i migliori mai riportati per elettroliti liquidi, un risultato di cui andiamo molto fieri.
Anche le celle simmetriche Li||Li, con elettrodi di litio sottilissimi (20 µm), hanno mostrato una stabilità impressionante con l’elettrolita Cl 7, superando le 2000 ore di ciclo a una profondità di scarica del 75%. Un contrasto netto con gli elettroliti tradizionali che si esaurivano rapidamente.
La SEI: Un Vero Scudo Protettivo, Sottile e Robusto
Ovviamente, eravamo curiosissimi di vedere com’era fatta la SEI formata con il nostro elettrolita. Abbiamo usato la spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS) per analizzarne la composizione. È emerso che la SEI nel Cl 7 era ricca di prodotti di decomposizione “buoni” dell’anione FSI–, come il Li2S, e soprattutto, una maggiore quantità di Li2O. Recenti studi indicano che una SEI ricca di Li2O è fondamentale per ottenere alte efficienze coulombiche. Inoltre, la quantità di composti organici derivati dalla riduzione del solvente era marcatamente ridotta, e il ClDEE stesso mostrava un’eccellente stabilità, decomponendosi pochissimo.
La microscopia elettronica a trasmissione criogenica (cryo-TEM) ci ha poi mostrato la morfologia: la SEI formata nel Cl 7 era sottile, uniforme e costellata di nanocristalli di LiF e Li2O ben distribuiti. Al contrario, con elettroliti meno performanti, la SEI era spessa, irregolare e prevalentemente organica.
Infine, la microscopia a forza atomica (AFM) ha confermato che la SEI del Cl 7 era significativamente più liscia e, cosa importantissima, meccanicamente più robusta, con un modulo DMT (che misura la rigidezza) di 8.2 GPa, più del doppio rispetto a quella formata in un elettrolita 10M tradizionale (3.9 GPa).

Dalle Celle a Bottone alle Pouch Cell: I Risultati Pratici
Tutti questi bei risultati ci hanno spinto a testare il nostro elettrolita Cl 7 in condizioni ancora più severe, quelle di una cella completa Li||NCM811 (un catodo molto promettente). Abbiamo usato elettrodi di litio sottilissimi (20 µm) e catodi ad alta capacità (2.5 mAh/cm2 e 3.8 mAh/cm2).
I risultati sono stati entusiasmanti:
- Con un rapporto N/P (negativo/positivo) di 1.6 e catodo da 2.5 mAh/cm2, la cella con Cl 7 ha superato i 600 cicli, mantenendo l’80% della capacità dopo 429 cicli.
- Aumentando il carico del catodo a 3.8 mAh/cm2 e riducendo il rapporto N/P a 1.05 (condizioni molto sfidanti!), la cella ha mantenuto circa l’80% della capacità dopo 350 cicli. Prestazioni che si collocano tra le migliori riportate in letteratura per batterie al litio metallico con poco litio e catodi ad alto carico.
L’analisi post-ciclo degli elettrodi di litio ha mostrato che, anche in condizioni estreme, il litio nell’elettrolita Cl 7 manteneva una morfologia relativamente piatta e compatta, con un rigonfiamento molto contenuto (spessore finale di 31 µm contro i 60 µm di un elettrolita 10M).
Ma la ciliegina sulla torta è stata la realizzazione di una pouch cell (quelle batterie piatte e flessibili che troviamo in molti dispositivi). Abbiamo ottimizzato tutti i parametri: foglio di litio da 100 µm senza collettore di corrente in rame, catodo NCM811 ad altissimo carico (30 mg/cm2), pochissimo elettrolita (1.1 g/Ah) e minimizzazione di tutti i componenti inattivi. Il risultato? Una pouch cell da 5.6 Ah con un’energia specifica di 510.3 Wh/kg (basata sul peso totale della cella!) che ha mantenuto l’84% della capacità e l’83% dell’energia dopo 116 cicli. Un traguardo notevole che dimostra il potenziale pratico della nostra strategia!
Un Futuro Più Energetico (e Stabile)
In sintesi, comprimendo la shell di solvatazione primaria degli ioni litio grazie al ClDEE, siamo riusciti a far sì che gli ioni litio formassero cluster di solvatazione più stretti con gli anioni FSI–, raggiungendo una concentrazione di sale di litio senza precedenti nella fase solvente. Questa struttura di solvatazione compressa conferisce una stabilità eccezionale all’elettrodo di litio metallico e facilita la rapida decomposizione dei sali di litio per formare una SEI robusta, omogenea e ricca di LiF e Li2O, portando l’efficienza di deposizione/strippaggio del litio metallico fino al 99.9%.
Grazie a questa innovazione, non solo le celle a bottone con poco litio hanno dimostrato una durata superiore, ma anche la pouch cell da 510.3 Wh/kg ha funzionato stabilmente per oltre 100 cicli. Crediamo che questa strategia della “struttura di solvatazione compressa” apra nuove ed entusiasmanti prospettive per lo sviluppo di elettroliti ricchi di anioni e, in definitiva, per la realizzazione di batterie al litio metallico altamente reversibili e performanti. La strada è ancora lunga, ma ogni passo avanti come questo ci avvicina a un futuro energetico più pulito e potente. E noi, modestamente, siamo entusiasti di aver dato il nostro contributo!
Fonte: Springer