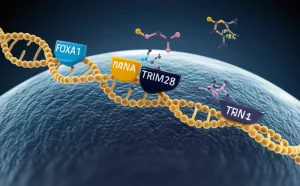Piastre d’Ancoraggio: Il Segreto Nascosto (e Fondamentale!) per Gallerie Stabili in Roccia Tenere
Amici appassionati di ingegneria e grandi opere, oggi voglio parlarvi di un dettaglio che, a prima vista, potrebbe sembrare secondario, ma che in realtà gioca un ruolo da protagonista nella sicurezza e durabilità delle gallerie scavate in rocce tenere: la piastra d’ancoraggio nei sistemi di cavi precompressi. Vi siete mai chiesti come facciamo a tenere insieme montagne intere mentre ci scaviamo dentro? Beh, una parte della risposta sta proprio qui.
Quando il gioco si fa duro… e la roccia è tenera!
Tradizionalmente, per sostenere le gallerie, specialmente quelle montane, ci siamo affidati a un sistema “passivo”: calcestruzzo proiettato (il famoso spritz-beton), centine metalliche e un rivestimento secondario bello spesso. Funziona, per carità, ma quando ci si avventura in terreni profondi, con geologie complesse e rocce non proprio granitiche – pensate alle sfide lungo la ferrovia Sichuan-Tibet in Cina o al tunnel Guillermo Gaviria Echeverry in Colombia – questo approccio inizia a mostrare la corda. Fessurazioni estese nel calcestruzzo, deformazioni eccessive del rivestimento… insomma, non proprio l’ideale se la roccia è “tenera” e magari pure un po’ “nervosa” a causa di movimenti tettonici.
Ispirandoci a quanto già si fa con successo nelle miniere di carbone in profondità, alcuni ricercatori hanno iniziato a proporre un sistema di supporto “attivo” basato su cavi d’ancoraggio precompressi. L’idea è semplice quanto geniale: invece di aspettare che la roccia si muova per poi contrastarla, la “mettiamo in riga” subito, applicando una forza che la ricompatta e la stabilizza. Immaginate di stringere un pacco di fogli sparsi per renderlo un blocco unico: ecco, il concetto è simile. Questo sistema è stato testato con successo, ad esempio, nella galleria di Muzhailing in Cina, dove i problemi con il supporto passivo erano all’ordine del giorno. Applicando rapidamente la precompressione dopo lo scavo, si è riusciti a ridurre significativamente le deformazioni della galleria.
L’importanza dei dettagli: la piastra d’ancoraggio
Finora, gran parte della ricerca si è concentrata sulle caratteristiche meccaniche generali dei cavi precompressi e sul confronto tra sistemi di supporto. Ma c’è un componente piccolo ma cruciale che merita più attenzione: la piastra d’ancoraggio. Questa non è solo un pezzo di metallo! È l’intermediario che trasferisce la forza di precompressione dal cavo alla roccia circostante, ampliandone l’area di influenza e migliorando la capacità portante della roccia stessa. Se la piastra non funziona come dovrebbe – se si deforma troppo o, peggio, si stacca – l’intero sistema di ancoraggio precompresso rischia di fallire.
Il problema è che la superficie della roccia, dopo lo scavo, è raramente liscia e uniforme come un tavolo da biliardo. Anzi, spesso è irregolare, frastagliata, piena di sporgenze e rientranze. E qui casca l’asino, o meglio, si deforma la piastra! Un contatto non uniforme tra piastra e roccia può portare a concentrazioni di sforzo pazzesche, deformazioni significative della piastra e, di conseguenza, a una perdita di precompressione nel cavo. E questa perdita non è stata quasi mai quantificata sistematicamente negli studi precedenti.

Classificare il caos: i cinque tipi di contatto piastra-roccia
Per capirci qualcosa di più, basandoci su osservazioni dirette in cantiere (proprio nella galleria di Muzhailing), abbiamo identificato e classificato cinque condizioni di contatto principali tra la piastra d’ancoraggio e la roccia. Immaginateveli così:
- Contatto completo (Full-face): Il sogno di ogni ingegnere! La piastra appoggia perfettamente su tutta la sua superficie contro la roccia. La deformazione post-tensionamento è minima.
- Contatto parziale (Partial-face): Solo una parte della piastra tocca la roccia, l’altra è “sospesa”. Quando si tira il cavo, la parte a contatto si deforma verso l’esterno, quella sospesa verso l’interno. Un bel pasticcio per la distribuzione del carico.
- Contatto concavo (Concave): A volte, per via dello scavo o della perforazione per l’ancoraggio, si crea una depressione, una sorta di “conca” attorno al foro. La piastra, una volta tensionata, si deforma verso l’interno al centro e si solleva ai quattro angoli.
- Contatto irregolare (Irregular): Un mix di punti e piccole aree di contatto, dovuto a una superficie rocciosa molto frastagliata. La piastra si deforma in modo imprevedibile e lo stress si distribuisce in maniera tutt’altro che uniforme.
- Contatto angolare (Angular): Qui c’è un bello spazio vuoto tra piastra e roccia, dovuto a superfici rocciose spigolose post-scavo. Il centro della piastra si inflette notevolmente all’indietro nello spazio vuoto, e rimangono zone di contatto puntiforme con stress elevatissimi.
Indovinate un po’? Il contatto completo è raro come un quadrifoglio. Quelli più comuni, ahimè, sono il contatto irregolare e quello angolare, seguiti dal concavo. Capite bene che ignorare come la piastra interagisce con queste superfici “difficili” è un errore da non fare.
Simulazioni e prove sul campo: cosa succede davvero?
Per vederci chiaro, abbiamo messo in piedi simulazioni numeriche (con il software FLAC3D, per i più tecnici) e condotto test direttamente in galleria. Abbiamo modellato il sistema cavo-piastra-dado e applicato una forza di precompressione di 350 kN, simulando le cinque condizioni di contatto sia su arenaria che su scisti carboniosi (le rocce principali della galleria di Muzhailing).
I risultati sono stati illuminanti! Con un contatto completo, stress e deformazioni sulla piastra sono minimi e distribuiti uniformemente. Ma appena il contatto diventa parziale, concavo, e soprattutto irregolare o angolare, la musica cambia. Le concentrazioni di stress schizzano alle stelle, la piastra si deforma in modi complessi e, cosa più importante, si verifica una perdita di precompressione nel cavo.
Ad esempio, nel contatto angolare, la piastra si inflette parecchio verso lo spazio vuoto dietro di essa. Lo stress massimo si sposta sulla faccia interna della piastra (quella a contatto con la roccia), e la deformazione è la più alta tra tutti i casi. È emerso anche che gli scisti carboniosi, essendo più fragili, tendono a frantumarsi sotto carico, peggiorando ulteriormente le condizioni di contatto e portando a stress e deformazioni maggiori sulla piastra rispetto all’arenaria.
La perdita di precompressione: un nemico subdolo
Ma cos’è questa perdita di precompressione? In pratica, è la differenza tra la forza che applichiamo al cavo durante il tensionamento e quella che effettivamente rimane “attiva” nel sistema una volta che tutto si è assestato. I test sul campo, effettuati con un sistema chiamato PT-20S (che ri-tensiona leggermente il cavo per misurare la forza residua), hanno confermato i timori.
Con un contatto completo, la perdita di precompressione media era del 31%. Non poco, ma accettabile. Con contatti parziali e concavi, salivamo al 33-34%. Ma con contatti irregolari e angolari, la perdita media schizzava al 40-41%! Questo significa che quasi metà della forza che pensavamo di aver messo nel sistema se n’è andata in fumo (o meglio, in deformazione e attrito).

Da cosa dipende questa perdita, al di là della deformazione della piastra? Principalmente da due fattori legati al modo in cui il cavo si “piega” a causa del contatto imperfetto:
- Attrito del cavo al centro della piastra: Se la piastra si deforma o si inclina, il cavo non esce dritto, ma si piega. Questo piegamento crea attrito tra il cavo e il foro della piastra (o la roccia subito dietro), dissipando energia.
- Attrito nella sezione libera del cavo: Il piegamento può far sì che la sezione libera del cavo (quella non inghisata) sfreghi contro le pareti del foro di perforazione, causando ulteriore perdita.
- Retrazione dei trefoli e movimento della piastra: Quando c’è uno spazio vuoto dietro la piastra (contatti concavi, irregolari, angolari), durante il tensionamento la piastra si muove per “chiudere” questo spazio. Questo movimento, unito a una leggera retrazione dei trefoli d’acciaio del cavo, contribuisce alla perdita.
Una minore precompressione effettiva significa minore capacità di supporto a lungo termine, maggior rischio di rilassamento della roccia e possibili deformazioni secondarie. Un bel problema!
Una soluzione a portata di mano: aumentare lo spessore della piastra
Se la piastra si deforma troppo, perché non renderla più robusta? Sembra banale, ma aumentare lo spessore della piastra può essere un modo semplice ed efficace per migliorare le prestazioni del sistema. Le piastre da 15.5 mm usate inizialmente mostravano deformazioni notevoli. Così, abbiamo simulato piastre con spessori crescenti (da 15.5 mm fino a 40 mm).
I risultati? Come c’era da aspettarsi, all’aumentare dello spessore, lo stress massimo e lo spostamento massimo della piastra diminuiscono, specialmente nei casi critici di contatto irregolare e angolare. Ad esempio, passando da 20 a 25 mm di spessore in condizioni di contatto irregolare su arenaria, lo spostamento massimo della piastra è crollato quasi del 30%!
Per confermare, siamo tornati in cantiere e abbiamo installato piastre da 31 mm di spessore accanto a quelle da 15.5 mm, nelle stesse condizioni di roccia. Ebbene sì, le piastre più spesse si sono deformate molto meno. Ma soprattutto, la perdita di precompressione media è scesa dal 39% (con piastre da 15.5 mm) al 30% (con piastre da 31 mm). Un miglioramento netto!
Conclusioni: non sottovalutiamo le piastre!
Cosa ci portiamo a casa da tutta questa storia?
Innanzitutto, che il contatto tra piastra d’ancoraggio e roccia è un fattore cruciale. Aver classificato i cinque tipi di contatto ci dà uno strumento per valutare meglio la situazione.
Poi, che i contatti irregolari e angolari sono i più problematici e portano a perdite di precompressione significative. Non è solo una questione di deformazione della piastra, ma anche di come questa influisce sul comportamento del cavo.
Infine, abbiamo una soluzione pratica: ottimizzare lo spessore della piastra in base alle condizioni di contatto. Una piastra da 15.5 mm può andare bene per contatti completi, parziali o concavi. Ma per quelli irregolari e angolari, è decisamente meglio passare a una piastra da 31 mm per ridurre la deformazione e trattenere più precompressione.
L’uso di sistemi di ancoraggio precompressi nelle gallerie in roccia tenere è una frontiera promettente, ma siamo ancora agli inizi. Questo studio sull’effetto delle condizioni di contatto e sull’ottimizzazione dello spessore delle piastre è un piccolo passo, ma spero possa essere d’aiuto per progettare sistemi più efficienti e sicuri. Perché quando si scava nelle montagne, ogni dettaglio conta! E la piastra d’ancoraggio, amici miei, è un dettaglio che fa davvero la differenza.
Fonte: Springer