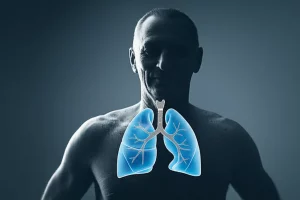Occhi Aperti e Orecchie Tese sulla Salute: Come l’Educazione Può Fare la Differenza per Chi Ha Disabilità Visive o Uditive
Amici lettori, oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante, quello dell’educazione sanitaria pensata apposta per chi vive con una disabilità visiva o uditiva. Immaginate per un attimo le sfide quotidiane: accedere a informazioni sulla salute, comprendere indicazioni mediche complesse, o semplicemente partecipare attivamente alla gestione del proprio benessere. Non è scontato, vero? Ecco perché uno studio recente, una “scoping review” per usare il termine tecnico, ha voluto fare luce su come stiamo andando in questo campo, analizzando gli interventi di educazione sanitaria dedicati. E credetemi, i risultati sono un mix di luci e ombre che meritano tutta la nostra attenzione.
Un Mondo di Sfide, Ma Anche di Grandi Potenzialità
Partiamo da un dato: nel 2021, oltre 2,2 miliardi di persone nel mondo convivevano con una disabilità visiva e più di 466 milioni con una disabilità uditiva. Numeri impressionanti, che ci fanno capire quanto sia cruciale questo tema. Queste persone, come sottolinea l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), incontrano ostacoli significativi: opportunità educative limitate, accesso ristretto a risorse accademiche, ritardi o carenze nei servizi di supporto. Pensate a quanto può essere complicato apprendere se non vedi bene le slide o non senti chiaramente le spiegazioni.
La disabilità, come la definisce l’OMS attraverso l’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), non è solo una questione fisica, ma tiene conto anche dei fattori ambientali che possono facilitare o ostacolare la vita di una persona. E quando si parla di disabilità sensoriali, come la perdita dell’udito o della vista, le difficoltà si moltiplicano, impattando la comunicazione, la mobilità e l’accesso alle informazioni. A volte, queste due disabilità possono anche coesistere, rendendo il quadro ancora più complesso.
L’educazione sanitaria, in questo contesto, diventa uno strumento potentissimo. Aiutare le persone con disabilità a gestire autonomamente la propria salute migliora la qualità della vita e i risultati sanitari. Ma per farlo, servono interventi “su misura”, che tengano conto delle caratteristiche uniche di ognuno.
La Lente d’Ingrandimento della Ricerca: Cosa Abbiamo Analizzato?
Lo studio che vi racconto ha seguito una metodologia rigorosa, quella di Arksey e O’Malley, per setacciare la letteratura scientifica. L’obiettivo? Capire quali tipi di interventi di educazione sanitaria esistono per persone con disabilità visive o uditive, come sono strutturati e quali risultati portano. Sono stati consultati database importanti come Cochrane, Ovid MEDLINE e Google Scholar, alla ricerca di studi pubblicati fino a giugno 2023.
Dopo una prima scrematura di ben 3.168 articoli, ne sono stati selezionati 34 per l’analisi finale: 19 riguardavano persone con disabilità visiva e 15 persone con disabilità uditiva. È interessante notare che nessuno studio si concentrava specificamente su chi vive con una doppia disabilità sensoriale, un vuoto che andrà colmato.
I ricercatori hanno esaminato vari aspetti: il tipo di intervento (ad esempio, neuro-motorio, sensoriale, di acquisizione e sviluppo, cognitivo-psicosociale), la modalità di erogazione (faccia a faccia o a distanza), chi lo conduceva (infermieri, medici, altro personale), il luogo, la durata e la frequenza.
Interventi per la Disabilità Visiva: Imparare a “Vedere” la Salute
Per le persone con disabilità visiva, la maggior parte degli interventi (8 su 19) si è concentrata sull’acquisizione e lo sviluppo di competenze. Pensate a imparare a usare ausili visivi, a gestire il diabete se si ha difficoltà a leggere le etichette o a misurare l’insulina, o a migliorare la mobilità in sicurezza. Altri interventi (6) hanno avuto un focus cognitivo-psicosociale, aiutando ad esempio a gestire l’ansia o la depressione legate alla condizione.
La stragrande maggioranza di questi programmi (17 studi) è stata erogata faccia a faccia, spesso individualmente. Solo in pochi casi si è fatto ricorso a smartphone o telefoni tradizionali. Gli operatori sanitari, come infermieri e paramedici, sono stati i principali facilitatori, e gli interventi si sono svolti prevalentemente in istituzioni sanitarie o a domicilio.
Un esempio? Un programma di formazione visiva di sei mesi ha portato a un miglioramento delle funzioni di movimento oculare. Un altro ha aiutato anziani con problemi di vista a sentirsi più sicuri nelle loro attività quotidiane grazie all’apprendimento dell’uso di ausili ottici.

Interventi per la Disabilità Uditiva: “Ascoltare” i Bisogni di Salute
Passando alle persone con disabilità uditiva, anche qui la categoria di intervento più comune (9 studi su 15) è stata quella dell’acquisizione e sviluppo. Immaginate corsi per migliorare la percezione del parlato, l’uso di apparecchi acustici o impianti cocleari, o strategie di comunicazione efficace. Seguono gli interventi cognitivo-psicosociali (5 studi).
Anche in questo caso, le interazioni faccia a faccia hanno dominato la scena (13 studi su 15), con un paio di eccezioni che hanno utilizzato video educativi. Le sessioni erano spesso individuali e condotte da personale clinico in centri sanitari o istituti educativi.
Un esempio significativo è un intervento educativo tramite video che ha migliorato la fiducia accademica e l’impegno nel trattamento in persone con problemi di udito.
Risultati: Tra Successi Incoraggianti e Tassi di Abbandono Preoccupanti
La buona notizia è che la maggior parte degli studi ha riportato risultati positivi. Per le persone con disabilità visiva, 18 studi su 19 hanno mostrato miglioramenti significativi in variabili come la funzione visiva, il cambiamento del comportamento, la qualità della vita, l’autoefficacia e l’autogestione. Per quelle con disabilità uditiva, 8 studi su 15 hanno evidenziato progressi nella percezione del parlato, nelle risposte uditive, nelle conoscenze e nella qualità della vita.
Questi successi sono probabilmente dovuti alla durata degli interventi (molti duravano più di 8 settimane) e all’approccio individualizzato. Quando l’educazione è “cucita addosso”, i risultati si vedono!
Tuttavia, c’è un “ma” importante: il tasso di abbandono. Questo variava dallo 0% a circa il 50% per gli interventi sulla disabilità visiva e dallo 0% al 47,4% per quelli sulla disabilità uditiva. Sono cifre alte, che ci dicono che qualcosa non funziona come dovrebbe. Le ragioni? Diverse: problemi di salute, difficoltà logistiche come il trasporto per raggiungere i centri, barriere linguistiche o di comunicazione, perdita di motivazione. Molti studi, purtroppo, non hanno approfondito le cause, rendendo difficile proporre soluzioni mirate. È chiaro però che l’accessibilità e la sostenibilità degli interventi sono nodi cruciali.
Tecnologia: Un’Alleata Ancora Poco Sfruttata
Una cosa che mi ha colpito è il limitato utilizzo della tecnologia. Solo 5 studi su 34 hanno provato a usare smartphone, telefoni o video. Eppure, le potenzialità sono enormi! Pensate ad app personalizzate, video con sottotitoli o lingua dei segni, promemoria per appuntamenti medici. La tecnologia potrebbe aiutare a superare molte barriere di accessibilità e offrire ambienti di apprendimento più flessibili. C’è un grande margine di miglioramento qui, soprattutto considerando che ricerche precedenti hanno già evidenziato i benefici delle app mobili per la gestione di malattie croniche.

Cosa Ci Insegna Questa Ricerca e Dove Andare da Qui?
Questa “scoping review” ci offre un quadro prezioso. Sappiamo che gli interventi di educazione sanitaria, soprattutto quelli focalizzati sull’acquisizione di competenze e sugli aspetti cognitivo-psicosociali, possono davvero fare la differenza. L’approccio faccia a faccia e individualizzato sembra essere efficace, ma dobbiamo fare i conti con i tassi di abbandono.
Cosa possiamo fare?
- Personalizzare ancora di più: Ogni persona è un universo. Gli interventi devono tenere conto del grado di disabilità, delle esigenze comunicative, delle esperienze vissute e di ogni altra necessità di adattamento.
- Sfruttare la tecnologia: È ora di esplorare seriamente come strumenti digitali possano rendere l’educazione sanitaria più accessibile, coinvolgente e flessibile.
- Affrontare il problema dell’abbandono: Servono studi longitudinali per capire meglio le cause e sviluppare strategie per mantenere alta la partecipazione. Magari offrendo supporto per il trasporto, orari più flessibili, o modalità di fruizione a distanza.
- Più ricerca rigorosa: C’è bisogno di più studi controllati randomizzati (RCT) per avere prove ancora più solide sull’efficacia dei diversi approcci.
- Non dimenticare la doppia disabilità: È fondamentale avviare ricerche e sviluppare interventi per chi vive con disabilità sia visive che uditive.
- Usare un linguaggio comune: L’ICF dell’OMS si è rivelato uno strumento utile per classificare e confrontare gli interventi. Continuare su questa strada può migliorare la chiarezza e l’applicabilità della ricerca.
Insomma, la strada è tracciata, ma c’è ancora molto lavoro da fare. L’obiettivo è garantire che ogni persona, indipendentemente dalle proprie capacità sensoriali, abbia gli strumenti e le conoscenze per prendersi cura al meglio della propria salute. E io credo fermamente che, con impegno e innovazione, possiamo raggiungere questo traguardo.
Fonte: Springer