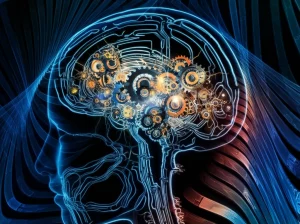La Dolorosa Santità del Reale: E Se la Sofferenza Fosse Parte di un Disegno Più Grande?
Avete mai pensato al problema del male, della sofferenza nel mondo? Di solito, è un rompicapo che associamo ai credenti: come può un Dio buono e onnipotente permettere tanto dolore? Beh, tenetevi forte, perché secondo un libro affascinante di Yujin Nagasawa, “The Problem of Evil for Atheists”, questo dilemma non è affatto esclusiva dei teisti. Anzi, riguarda un po’ tutti noi: teisti, panteisti, assiarchisti e persino atei. Sembra strano, vero? Eppure, l’argomento di Nagasawa mi ha fatto riflettere parecchio.
Il Dilemma Condiviso: L’Aspettativa Infranta
In pratica, Nagasawa dice questo: tutte queste visioni del mondo – che tu creda in Dio, nel Cosmo divino, in principi ultimi buoni o semplicemente nella Natura e nell’evoluzione – partono dall’idea che la realtà ultima sia, in qualche modo, buona. Questo ci porta ad avere un certo “ottimismo modesto”: dovremmo trovare la vita degna di essere vissuta, non lamentarci troppo delle difficoltà, provare gratitudine e riverenza per la realtà ultima, qualunque essa sia.
Il problema? Il nostro universo è talmente intriso di dolore e sofferenza che questo ottimismo sembra ingiustificato. Anzi, a guardare bene, la realtà sembrerebbe supportare un pessimismo estremo. C’è quindi uno “scollamento tra aspettativa assiologica e realtà”, come lo chiama Nagasawa. Ci aspettiamo un universo fondamentalmente buono e accogliente, e invece ci scontriamo con una realtà spesso brutale. Questo, secondo lui, è il problema della sofferenza condiviso da tutti.
Ora, io credo che Nagasawa abbia ragione nel dire che tutte queste posizioni vedono la realtà ultima come buona e implicano un certo ottimismo. Ma c’è un punto debole nel suo ragionamento, secondo me. Lui dà per scontato che “buono” significhi massimizzare il piacere e minimizzare il dolore (un’ottica che potremmo definire utilitarista). Ma è davvero così che queste tradizioni intendono la “bontà” della realtà ultima?
Una Via d’Uscita: La Santità che Include il Dolore
Qui entra in gioco un concetto potente, che Nagasawa menziona ma non esplora a fondo: la santità. E se la “bontà” della realtà ultima non fosse la sua premura nel renderci felici (quella che potremmo chiamare “sollecitudine”), ma la sua santità?
Ecco la mia proposta, che credo risuoni in tutte e quattro le posizioni:
- La bontà della realtà ultima è la sua santità.
- La santità non mira a massimizzare la felicità, ma a massimizzare il valore intrinseco (complessità, bellezza, eccellenza funzionale, diversità…).
- La massimizzazione del valore intrinseco, specialmente attraverso processi come l’evoluzione biologica, implica un’enorme quantità di sofferenza.
- La sofferenza, per quanto psicologicamente sgradevole, potrebbe non essere così significativa dal punto di vista metafisico o religioso.
Se le cose stanno così, allora anche se il dolore ci porta a un pessimismo psicologico, potremmo ancora mantenere un ottimismo metafisico o religioso. E quest’ultimo, essendo più fondamentale, dovrebbe prevalere. L’ottimismo modesto sarebbe quindi giustificato.
La Santità all’Opera: Uno Sguardo alle Diverse Visioni
Vediamo come funziona. Prendiamo il teismo, in particolare quello dell’Antico Testamento. Il Dio descritto lì è potente, terrificante, la cui santità comporta ira distruttiva (pensate al diluvio, a Sodoma e Gomorra, persino alle sofferenze di Giobbe, innocente). Questo Dio non sembra un massimizzatore di felicità. È pura potenza creativa. E la creatività pura è anche trasformativa, quindi distruttiva: crea dal nulla, trasforma ciò che esiste in qualcosa di nuovo. Questa trasformazione è spesso dolorosa. Il Dio di Giobbe celebra la forza bruta della natura, i predatori, la violenza intrinseca nell’evoluzione (“rosso di denti e artigli”). Se la bontà di Dio è la sua santità creativa, allora la sofferenza non la contraddice, anzi, ne è una conseguenza.

Passiamo al panteismo: l’universo è Dio. Come può un universo pieno di sofferenza essere divino? I panteisti rispondono: perché è santo, glorioso nella sua complessità e potenza. La sofferenza è parte integrante del processo cosmico (Deus sive natura) che massimizza il valore intrinseco. Pensate agli Stoici: per loro piacere e dolore erano assiologicamente irrilevanti. L’universo evoca meraviglia, timore reverenziale (il numinoso). Questo suggerisce una potenza sacra all’opera, una sorta di “fuoco artefice” (pyr technikon) che guida l’evoluzione della complessità. Certo, ci sono obiezioni (l’universo è limitato? E il multiverso è davvero un “tutto organico”?), ma l’idea centrale rimane: la divinità sta nella gloriosa, anche se dolorosa, totalità.
E l’assiarchismo? L’idea qui è che una “Bontà” impersonale (simile al Bene platonico) sia responsabile dell’esistenza concreta. Questa Bontà agisce come un filtro, selezionando per l’esistenza solo le forme cosmiche “brillanti”, quelle che rappresentano un miglioramento in termini di valore intrinseco. Esiste una potenza produttiva ultima (che potremmo chiamare “l’Uno” o, di nuovo, pyr technikon) che genera tutte le possibilità e concretizza quelle selezionate dalla Bontà. Questo processo crea il “Mondo Migliore” possibile (un “albero del mondo” di universi in continuo miglioramento), che è massimamente ricco di valore intrinseco, ma proprio per questo, anche pieno di sofferenza. Anche qui, la sofferenza non è il punto focale assiologico; lo è il valore intrinseco, la gloria.

Infine, l’ateismo. Nagasawa sottolinea che anche molti atei provano meraviglia, riverenza, gratitudine verso la natura, l’universo, l’evoluzione. Hanno un loro ottimismo. Ma come conciliarlo con la brutalità dell’evoluzione darwiniana, un sistema che sembra intrinsecamente basato sulla sofferenza? La mia proposta è che anche l’ateo, per essere coerente, può appellarsi a una forma di “santità” naturale. L’evoluzione può essere vista come un algoritmo che massimizza il valore intrinseco (fitness, complessità, bellezza). È l’espressione più intensa di quel pyr technikon, quel fuoco creativo naturale. La santità di questo processo appare in ogni atto di predazione: il falco che mangia il coniglio esprime la “santità attiva” del pyr technikon; il coniglio che lotta dolorosamente per sopravvivere esprime la “santità reattiva”. Il dolore diventa un meccanismo protettivo essenziale per preservare il valore intrinseco raggiunto. Senza dolore, l’ecosistema collasserebbe. Quindi, anche per l’ateo, la sofferenza può essere vista come un sottoprodotto necessario e forse persino “santo” (nel senso di funzionale a un valore più alto) del processo che genera la complessità e la bellezza che ammirano. Certo, questo avvicina pericolosamente l’ateismo al panteismo o all’assiarchismo. Forse, come suggerisce Nagasawa, sono facce della stessa medaglia?

Oltre l’Idolatria: Verso un “Reale” Più Ampio
Il lavoro di Nagasawa, interpretato attraverso la lente della santità, fa qualcosa di molto interessante. Ricorda il lavoro di John Hick sul “Reale”, il nucleo comune a tutte le religioni. Nagasawa, includendo panteismo, assiarchismo e ateismo, espande questo concetto. Lo libera da caratteristiche troppo legate al monoteismo tradizionale (come una trascendenza vista come “potere superiore” o un’eccessiva focalizzazione sulla benevolenza umana).
Il “Reale” che emerge è più vasto, profondo, forse più impersonale. Non è necessariamente “buono” nel senso di gentile o premuroso verso di noi. È santo nel senso che massimizza il valore intrinseco, la gloria, la complessità. E questo processo, come abbiamo visto, è intrinsecamente doloroso. Assomiglia più al Dio di Giobbe che a un Babbo Natale cosmico.
Questa prospettiva, che riconosce la “dolorosa santità del reale”, può sembrare dura, ma ha un vantaggio: combatte l’idolatria. Ci impedisce di proiettare sulla realtà ultima i nostri desideri di comfort e felicità facile. Ci costringe a confrontarci con l’universo così com’è: un luogo di incredibile bellezza e complessità, ma anche di inevitabile sofferenza.
Nuove Opportunità Religiose?
Per chi si oppone all’idolatria – e molti atei si collocano proprio qui, vedendo le religioni tradizionali come proiezioni umane – questo approccio apre nuove strade. Permette di trovare un senso religioso, un ottimismo profondo, non *nonostante* la sofferenza, ma quasi *attraverso* di essa, riconoscendola come parte integrante di un processo cosmico grandioso e creatore di valore. Si potrebbero sviluppare nuove forme di naturalismo religioso, teologie processuali naturalizzate, religioni della natura che abbracciano pienamente la realtà evolutiva.
Insomma, forse il problema della sofferenza non è un vicolo cieco, ma un invito a ripensare cosa intendiamo per “bontà” ultima. Passare da una visione focalizzata sulla felicità a una centrata sulla santità e sul valore intrinseco potrebbe non eliminare il dolore dalle nostre vite, ma potrebbe aiutarci a collocarlo in una cornice di significato più ampia e, paradossalmente, più ottimista. È una strada impegnativa, certo, ma affascinante.
Fonte: Springer