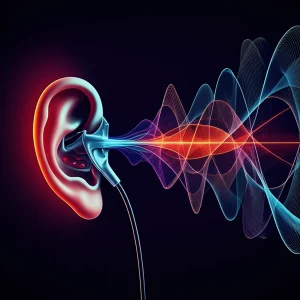Bypass al Cuore Meno Invasivo: Quale Anestesia Regionale Vince la Sfida del Dolore?
Ciao a tutti, appassionati di scienza e benessere! Oggi voglio parlarvi di un argomento che tocca da vicino molti di noi, direttamente o indirettamente: il dolore post-operatorio, specialmente dopo un intervento al cuore. E non un intervento qualsiasi, ma una procedura sempre più diffusa e meno invasiva chiamata MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass), ovvero bypass coronarico diretto minimamente invasivo. Una vera manna dal cielo per chi deve affrontare questo tipo di operazione, perché significa meno traumi, recupero più rapido e cicatrici più piccole. Ma, come dico sempre, “minimamente invasivo” non significa “privo di dolore”!
Il Dolore Post-Operatorio: Un Nemico da Non Sottovalutare
Eh sì, perché anche con le tecniche più moderne, il dolore dopo un intervento al torace può essere bello tosto. Pensateci: c’è un’incisione, anche se piccola, e poi i tubi di drenaggio toracico che, diciamocelo, non sono proprio una passeggiata. Questo dolore, se non gestito bene, non è solo una brutta esperienza, ma può anche portare a complicazioni. Lo stress causato dal dolore può infatti aumentare il rischio di problemi cardiovascolari e allungare i tempi di degenza in terapia intensiva e in ospedale. Insomma, un buon controllo del dolore è fondamentale!
Tradizionalmente, si usavano dosi massicce di oppioidi, ma sappiamo tutti che questi farmaci portano con sé effetti collaterali non proprio simpatici come depressione respiratoria, nausea e vomito. Per fortuna, la medicina fa passi da gigante e oggi si punta sempre di più su approcci multimodali che cercano di ridurre l’uso di oppioidi, sfruttando anche le meraviglie dell’anestesia regionale.
MIDCAB: Innovazione Chirurgica, Ma il Dolore Resta
Negli ultimi vent’anni, il MIDCAB ha fatto passi da gigante. È una tecnica usata soprattutto per pazienti a basso rischio con lesioni specifiche, come quelle all’arteria discendente anteriore sinistra, ma anche in pazienti ad alto rischio che non possono affrontare un bypass tradizionale. Le linee guida europee del 2018 la indicano come un’alternativa molto interessante. I vantaggi? Meno infezioni della ferita, recupero più sprint e meno problemi perioperatori. Però, come accennavo, il dolore dovuto alla lesione dei nervi intercostali e all’irritazione dei drenaggi resta un osso duro.
L’analgesia epidurale toracica (EA) e il blocco paravertebrale (PVB) sono considerati i “campioni” dell’anestesia regionale dopo toracotomia, ma il loro uso dopo MIDCAB è un po’ controverso, specialmente se durante l’intervento si usa eparina (un anticoagulante). Ecco perché si cercano alternative valide e sicure.
ESPB vs. ICNB: Due Tecniche a Confronto per il Controllo del Dolore
Qui entrano in gioco i protagonisti del nostro racconto: il Blocco del Piano Erettore Spinale (ESPB) e il Blocco Nervoso Intercostale Continuo (ICNB). L’ICNB si è già dimostrato efficace nel dare sollievo dopo un MIDCAB. L’ESPB, descritto per la prima volta nel 2016, è una tecnica più recente ma molto promettente. Immaginatelo come un’iniezione di anestetico locale in uno spazio specifico della schiena, vicino ai muscoli erettori spinali. Studi su cadaveri e con risonanza magnetica hanno mostrato che l’anestetico si diffonde nello spazio paravertebrale, offrendo un effetto analgesico sia somatico (sulla parete toracica) che viscerale (sugli organi interni). È una tecnica considerata sicura e tecnicamente meno complessa di altre.
Ma la domanda che si sono posti i ricercatori è: tra ESPB con boli intermittenti programmati (PIB) e ICNB, quale dei due offre un miglior controllo del dolore nei pazienti sottoposti a MIDCAB? Ed è proprio di questo che parla lo studio che voglio raccontarvi oggi.

Parliamo di uno studio randomizzato e controllato, il “gold standard” della ricerca scientifica. Ottanta pazienti candidati a MIDCAB sono stati divisi a caso in due gruppi: uno riceveva l’ESPB, l’altro l’ICNB. L’obiettivo primario era valutare il dolore (usando la scala NRS, quella da 0 a 10) al movimento subito dopo l’estubazione. Poi, c’erano una serie di obiettivi secondari, come il dolore a riposo e al movimento a 8, 24 e 48 ore, il consumo di analgesici, gli eventi avversi e i dati sul recupero.
Lo Studio: Come Hanno Fatto?
I pazienti inclusi avevano un’età tra i 40 e gli 80 anni e uno stato di salute ASA 2-3 (cioè con malattie sistemiche lievi o moderate, ma controllate). Sono stati esclusi pazienti con controindicazioni ai blocchi nervosi, problemi di coagulazione, allergie ai farmaci dello studio o che facevano uso cronico di analgesici.
Una cosa interessante: lo studio era “in aperto”, il che significa che anestesisti, chirurghi e pazienti sapevano quale tipo di blocco veniva eseguito. Questo perché i tempi di esecuzione (prima dell’induzione dell’anestesia per l’ESPB, durante la chiusura chirurgica per l’ICNB) e la posizione dei cateterini erano diversi. Tuttavia, le infermiere che valutavano il dolore erano all’oscuro dell’assegnazione ai gruppi, il che aiuta a mantenere l’obiettività.
Tutti i pazienti hanno ricevuto un’anestesia generale standard. L’ESPB veniva eseguito con guida ecografica prima dell’induzione, mentre l’ICNB veniva fatto dal chirurgo prima della chiusura della ferita, inserendo un catetere nel quinto spazio intercostale. Dopo l’intervento, entrambi i gruppi ricevevano una somministrazione continua di ropivacaina (un anestetico locale) allo 0.2% attraverso una pompa elettronica, con la possibilità per il paziente di auto-somministrarsi boli aggiuntivi (PCA) ogni 30 minuti se necessario. Tutti seguivano anche un protocollo analgesico multimodale che includeva dexmedetomidina e butorfanolo.
I Risultati: Chi Ha Vinto? (O Forse un Pareggio?)
E ora, il momento della verità! Dopo aver analizzato i dati di 73 pazienti (alcuni sono stati esclusi per vari motivi), cosa è emerso? Beh, tenetevi forte: non c’è stata una differenza significativa nei punteggi del dolore (scala NRS) né a riposo né al movimento tra i due gruppi, sia subito dopo l’estubazione che a 8, 24 e 48 ore. Anche l’area sotto la curva (AUC) dei punteggi del dolore nel tempo – una misura che considera sia l’intensità che la durata del dolore – non ha mostrato differenze statisticamente rilevanti. E nemmeno la necessità di analgesici di “salvataggio” (morfina o tramadolo se il dolore superava un certo livello) è cambiata tra i due gruppi.
Quindi, potremmo dire che in termini di efficacia analgesica post-operatoria, ESPB e ICNB si sono dimostrati sostanzialmente equivalenti in questo contesto. Un pareggio, insomma!
Meno Oppioidi Durante l’Intervento: Un Vantaggio dell’ESPB?
C’è però un dato interessante: il gruppo ESPB ha richiesto una quantità significativamente inferiore di sufentanil (un potente oppioide) durante l’intervento chirurgico rispetto al gruppo ICNB (93.8 µg contro 128.9 µg). Questo, secondo gli autori, è probabilmente dovuto al fatto che l’ESPB veniva eseguito prima dell’inizio dell’intervento, offrendo quindi un effetto analgesico già durante la procedura, mentre l’ICNB veniva fatto alla fine. Non indica necessariamente una superiorità della tecnica ESPB in sé, ma piuttosto un vantaggio legato al tempismo della sua somministrazione.

Questo è un punto importante, perché ridurre l’uso di oppioidi intraoperatori può contribuire a un risveglio più dolce e a minori effetti collaterali. Quindi, se si opta per l’ICNB, forse varrebbe la pena considerare di eseguirlo in una fase più precoce, se possibile.
Cosa Significa Tutto Questo per Noi Pazienti?
La conclusione principale di questo studio è che sia l’ESPB che l’ICNB, inseriti in un protocollo analgesico multimodale, offrono un controllo del dolore acuto simile dopo un intervento di MIDCAB. Non c’è un “vincitore” assoluto in termini di sollievo dal dolore nelle 48 ore successive all’estubazione.
Questo è positivo, perché significa che i medici hanno a disposizione due valide opzioni. La scelta tra l’una e l’altra potrebbe dipendere da altri fattori, come l’esperienza dell’anestesista, le caratteristiche del paziente o, come suggerito dal minor uso di sufentanil, dal momento in cui il blocco può essere eseguito.
Non sono state osservate differenze significative nemmeno per quanto riguarda i tempi di ventilazione meccanica, la ripresa della motilità intestinale, il primo pasto, la prima deambulazione, la durata del catetere urinario o la degenza ospedaliera. Anche l’incidenza di effetti collaterali legati agli oppioidi o ai blocchi è stata simile e bassa (solo due casi di rimozione accidentale del catetere).
Sicurezza e Qualche Piccola Ombra
L’ESPB è generalmente considerato una procedura a basso rischio di sanguinamento, tanto che le linee guida più recenti (del 2022, quindi successive alla registrazione di questo studio avvenuta nel 2019) ne permettono l’uso anche in pazienti in terapia antitrombotica. Questo studio, per prudenza data l’epoca, aveva escluso pazienti con disturbi della coagulazione.
È importante ricordare che, sebbene sicuro, anche l’ESPB non è privo di potenziali rischi, seppur rari. In pazienti fragili è stata riportata instabilità emodinamica, forse dovuta a una diffusione epidurale dell’anestetico. Essendo un blocco “volume-dipendente” (cioè l’efficacia dipende anche dalla quantità di farmaco iniettato), c’è un rischio teorico di tossicità sistemica da anestetico locale (LAST) se si usano grandi volumi, specialmente in pazienti con disfunzioni cardiache o epatiche. Per mitigare questi rischi, si possono usare concentrazioni più basse di anestetico o aggiungere adiuvanti che ne potenzino l’effetto, permettendo di ridurne la dose.
Lo studio ha alcune limitazioni, come il disegno “in aperto” (anche se chi valutava il dolore era cieco) e il fatto che l’ESPB fosse preoperatorio e l’ICNB postoperatorio, il che, come abbiamo visto, ha probabilmente influenzato il consumo di oppioidi intraoperatori. Inoltre, non sono state fatte analisi per sottogruppi basate su età o peso corporeo ideale, che potrebbero influenzare come il corpo gestisce gli anestetici locali.
Guardando al Futuro
Cosa ci portiamo a casa da tutto questo? Che nel complesso, l’effetto analgesico post-operatorio dell’ESPB e dell’ICNB nei pazienti sottoposti a MIDCAB è risultato simile. Entrambe le tecniche sono valide all’interno di una strategia multimodale per il controllo del dolore.
La ricerca futura, suggeriscono gli autori, potrebbe concentrarsi sull’ottimizzazione dei dosaggi e dei regimi di infusione dei blocchi regionali per massimizzare i loro effetti analgesici e minimizzare ulteriormente la necessità di oppioidi. Magari esplorando anche l’uso di adiuvanti come la dexmedetomidina, il magnesio solfato o la ketamina, che si sono già mostrati promettenti.
Per noi, la buona notizia è che la scienza continua a cercare modi sempre migliori per rendere un’esperienza difficile come un intervento chirurgico un po’ meno dolorosa e più gestibile. E avere più frecce al proprio arco è sempre un vantaggio!
Fonte: Springer