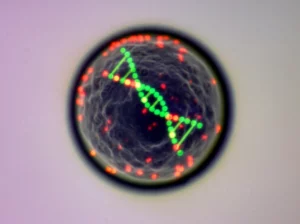DNA in Lavatrice: Il Bucato che Svela Segreti (e Complica le Indagini!)
Ehi, amici scienziati e curiosi! Oggi voglio portarvi con me in un’avventura che unisce due mondi apparentemente distanti: il banale cestello della lavatrice e l’affascinante, a volte intricato, universo della genetica forense. Sì, avete capito bene! Parleremo di come un semplice lavaggio possa diventare un vero e proprio rompicapo per chi cerca tracce di DNA sulla scena di un crimine. Sembra roba da CSI, vero? Beh, in un certo senso lo è.
Il DNA: Un Testimone Silenzioso (Ma Fragile)
Come saprete, il DNA è una sorta di carta d’identità biologica unica per ognuno di noi (tranne per i gemelli monozigoti, ma questa è un’altra storia!). Trovare DNA su un oggetto può collegare una persona a un luogo o a un evento. Pensate a tracce di pelle, capelli, sangue o saliva. Questo è quello che chiamiamo trasferimento primario o diretto. Ma c’è anche il trasferimento secondario o indiretto: il DNA passa da una superficie a un’altra, e poi magari a un’altra ancora. Immaginate di stringere la mano a qualcuno e poi toccare una maniglia: ecco un potenziale trasferimento indiretto.
Ora, mettete tutto questo nel contesto di una lavatrice. Cosa succede quando indumenti “contaminati” con DNA vengono lavati insieme ad altri capi “puliti”? È possibile che il DNA si trasferisca? E se sì, quanto ne rimane? Si degrada? Queste sono le domande cruciali che ci siamo posti in uno studio recente, perché le risposte hanno implicazioni enormi per le indagini forensi.
La Nostra Indagine nel Cestello
Per capirci qualcosa di più, abbiamo messo in piedi due esperimenti principali coinvolgendo 53 volontari di età diverse (dai 2 ai 64 anni!). Abbiamo considerato fattori come sesso, età e persino l’uso di creme idratanti, che potrebbero influenzare la quantità di DNA che una persona “perde”.
Nel primo esperimento, abbiamo chiesto ai volontari di strofinare e stringere energicamente per 30 secondi un pezzetto di tessuto di cotone bianco (5×5 cm), precedentemente sterilizzato con luce UV. Chiamiamolo il “Tessuto Toccato” (TF). Poi, questo TF è stato lavato in lavatrice insieme a un altro pezzetto di cotone pulito, l'”Accettore Pulito per cellule Epiteliali” (CAF-C). L’idea era vedere se le cellule della pelle trasferite sul TF potessero passare al CAF-C durante il lavaggio.
Nel secondo esperimento (non fatto sui minori di 19 anni), abbiamo simulato una piccola macchia di sangue. Dopo una minuscola puntura sul polpastrello, abbiamo fatto depositare 3 o 4 gocce di sangue su un altro pezzetto di cotone pulito, il “Tessuto con Sangue” (FB). Anche questo è stato poi lavato con un “Accettore Pulito per Sangue” (CAF-B). Volevamo simulare situazioni reali, come schizzi di sangue su un vestito.
Tutti i lavaggi sono stati fatti singolarmente (un tessuto “donatore” e uno “accettore” per volta) in una lavatrice standard, con un programma a 40°C per 57 minuti, usando un comune detersivo in polvere. Niente ammorbidente! E, cosa importante, la lavatrice è stata usata solo per questi esperimenti, con lavaggi di candeggina tra un test e l’altro per evitare contaminazioni incrociate. Abbiamo anche fatto dei test di controllo lavando tessuti puliti per assicurarci che la macchina fosse “pulita” da DNA preesistente.
Dopo il lavaggio e l’asciugatura, abbiamo estratto il DNA da tutti i campioni e cercato di ottenere dei profili genetici. Per valutare la presenza del DNA del volontario (la Persona di Interesse o POI), abbiamo usato un parametro statistico chiamato Likelihood Ratio (LR), che ci dice quanto è più probabile che il DNA trovato provenga dal POI rispetto a una persona a caso.

Risultati: Un Puzzle di Alleli
Allora, cosa abbiamo scoperto? Beh, la faccenda è più complicata di quanto si possa pensare!
Partiamo dalle cellule epiteliali (esperimento 1):
- Sui Tessuti Toccati (TF) lavati, abbiamo recuperato pochissimi alleli (le varianti genetiche che compongono un profilo) del volontario. Spesso solo 1 o 2. In nessun caso abbiamo ottenuto un profilo completo. Solo in 8 casi su 53 il valore di LR era superiore a 1, indicando un debole supporto per la presenza del DNA del POI.
- Sui Tessuti Accettori Puliti (CAF-C), la situazione era simile, se non peggiore. Nessun LR superiore a 1.
- Un dato interessante: in moltissimi campioni, sia TF che CAF-C, abbiamo trovato “alleli extra”, cioè non appartenenti al volontario. A volte, questi alleli extra costituivano la maggioranza del profilo!
Passiamo al sangue (esperimento 2):
- Sui Tessuti con Sangue (FB) lavati, i risultati sono stati un po’ migliori. In circa l’11% dei casi (3 su 27) abbiamo ottenuto un profilo completo del POI! E in circa il 22% dei casi, l’LR era superiore a 1000, un valore considerato significativo. Questo ci dice che se c’è sangue, anche poco, e il tessuto è quello direttamente macchiato, c’è una chance di identificare la persona.
- Sui Tessuti Accettori Puliti (CAF-B), invece, niente profili completi. Solo in un caso l’LR era maggiore di 1. Quindi, il trasferimento di DNA da una macchia di sangue a un altro capo durante il lavaggio sembra molto limitato, almeno in queste condizioni.
- Anche qui, una marea di “alleli extra” in quasi tutti i campioni.
Un aspetto che mi ha colpito è che, confrontando gli alleli extra trovati sui tessuti toccati e quelli con sangue dello stesso volontario adulto, abbiamo notato che una parte di questi alleli extra erano gli stessi. Questo suggerisce che alcuni di questi “intrusi” potrebbero provenire da contatti precedenti del volontario, DNA presente sulle sue mani che si è trasferito. Ma non spiega tutto.
Fattori in Gioco e il Mistero degli Alleli Extra
Abbiamo notato che l’età dei volontari e il tipo di campione (sangue vs. cellule epiteliali) facevano una differenza significativa. Il sangue, come intuibile, resiste un po’ di più. Per quanto riguarda l’età, sembra che i giovanissimi (2-18 anni, testati solo con cellule epiteliali) e le persone tra i 18 e i 23 anni e sopra i 49 anni abbiano mostrato percentuali diverse di alleli condivisi, ma i risultati sono complessi e non sempre lineari. L’uso di creme idratanti, invece, non sembrava avere un impatto decisivo dopo il lavaggio: l’effetto “pulente” della lavatrice è predominante.
Il vero rompicapo sono questi alleli extra. Da dove vengono?
- Non dai tessuti stessi: i controlli sui tessuti sterilizzati erano negativi.
- Non dalla lavatrice: i controlli con lavaggi “a vuoto” erano negativi.
- Forse dal DNA del POI stesso, ma super frammentato? Il detersivo (con enzimi come proteasi e lipasi, e un pH basico), la temperatura dell’acqua (40°C) e la centrifugazione sono un cocktail micidiale per il DNA. Potrebbe essere che il DNA del POI venga talmente spezzettato che i piccoli frammenti residui vengano amplificati casualmente, a volte mimando alleli che non c’entrano nulla, o che siano troppo degradati per dare un profilo corretto. Usiamo kit molto sensibili, pensati per DNA scarso (Low Template DNA o LTDNA), che possono amplificare anche questi frammenti.
Questa alta percentuale di alleli extra ci dice che dobbiamo essere super cauti nell’interpretare i profili ottenuti da indumenti lavati.

Implicazioni Forensi: Un Terreno Minato
Cosa significa tutto questo per chi fa il mio mestiere, cioè l’analisi forense del DNA? Significa che dobbiamo andarci con i piedi di piombo.
Se troviamo un profilo parziale su un indumento lavato, specialmente se è un capo “accettore” (cioè non quello direttamente a contatto con la fonte di DNA), l’identificazione del donatore è altamente improbabile, quasi impossibile stando ai nostri risultati.
Anche se troviamo il DNA del POI sul capo direttamente “contaminato” (come il tessuto con la macchia di sangue), sarà probabilmente un profilo parziale, pieno di artefatti e alleli extra, e la sua interpretazione richiederà criteri molto più restrittivi, simili a quelli usati per i campioni LTDNA e le miscele complesse di DNA.
Pensateci: se un indumento viene lavato, magari per eliminare le prove, la possibilità di recuperare un profilo utile si riduce drasticamente. E se si trova qualcosa, bisogna chiedersi:
- È davvero del sospettato?
- O è una coincidenza casuale dovuta alla frammentazione e agli alleli extra?
- O magari è DNA trasferito da altri capi lavati insieme, appartenenti a familiari (il che complica ulteriormente le miscele)?
- Oppure il contatto è avvenuto *dopo* il lavaggio?
Queste domande ci portano a un livello di interpretazione più alto, quello dell'”attività” (activity level), che cerca di capire *come* e *quando* il DNA si è depositato, non solo *di chi* è.
Conclusioni: Lavare con Cautela (Interpretativa!)
Insomma, la lavatrice è un ambiente ostile per il DNA. Il nostro studio conferma che è possibile recuperare profili parziali, soprattutto da piccole macchie di sangue su tessuti di cotone lavati, ma il trasferimento a capi “accettori” è minimo e non permette un’identificazione affidabile.
L’età del donatore, il tipo di campione, il volume (anche se piccolo) e il tempo di contatto iniziale sembrano influenzare il recupero, ma l’effetto “distruttivo” del lavaggio è potente.
La massiccia presenza di alleli extra, probabilmente dovuti alla frammentazione del DNA del donatore stesso, impone una grandissima cautela. I profili da indumenti lavati vanno trattati come LTDNA e miscele, con tutte le difficoltà interpretative del caso.
Quindi, la prossima volta che fate il bucato, pensate a questo piccolo dramma molecolare che si consuma nel cestello! E per noi forensi, la lezione è chiara: ogni traccia va contestualizzata, e quelle provenienti da indumenti lavati richiedono un’analisi ancora più critica e rigorosa. La scienza forense è un puzzle, e ogni pezzetto, anche il più degradato, va maneggiato con cura.
Fonte: Springer