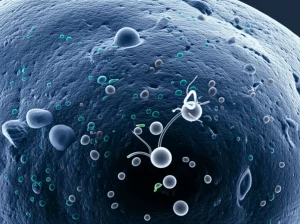Cure Palliative: L’Etnia Conta? Disparità Nascoste nelle Prescrizioni Mediche
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento tanto delicato quanto fondamentale: le cure palliative. Ma non solo. Voglio portarvi dentro una questione specifica che mi ha fatto riflettere molto: le disparità etniche nella prescrizione di farmaci in questo contesto, specialmente nei paesi ad alto reddito. Mi sono imbattuto in una revisione sistematica rapida (un modo veloce ma rigoroso per analizzare la ricerca esistente) che ha cercato di fare luce proprio su questo. E, vi anticipo, quello che emerge è piuttosto preoccupante.
Cosa Sono le Cure Palliative e Perché la Prescrizione è Cruciale?
Prima di tuffarci nel cuore del problema, facciamo un passo indietro. Cosa intendiamo per cure palliative? Non si tratta, come alcuni pensano, solo dell'”ultima spiaggia”. Sono un approccio che mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti (e delle loro famiglie) che affrontano malattie inguaribili e progressive. Come? Gestendo i sintomi fisici (dolore, nausea, affanno…), ma anche affrontando bisogni emotivi, sociali e spirituali.
In questo quadro, la prescrizione dei farmaci è un tassello chiave. Pensateci: bisogna scegliere i medicinali giusti, al dosaggio giusto, per alleviare la sofferenza, bilanciando attentamente i benefici con i possibili effetti collaterali o il “peso” che l’assunzione comporta per il paziente. Non è semplice. Spesso i pazienti hanno sintomi complessi e mutevoli, magari assumono già tanti farmaci per altre condizioni (la famosa polifarmacia), e il loro corpo, indebolito dalla malattia, può reagire in modo diverso. Serve un approccio personalizzato, sartoriale direi.
Qui entra in gioco l’importanza di un team multidisciplinare, dove figure come i farmacisti specializzati possono fare la differenza. Loro hanno l’expertise per ottimizzare le terapie, controllare le interazioni, suggerire aggiustamenti e anche aiutare nel processo, a volte necessario, di “deprescrizione” (cioè togliere farmaci non più utili o dannosi). Possono anche educare pazienti e famiglie sull’uso corretto dei medicinali.
Il Nocciolo della Questione: Disparità Etniche Emerse dalla Ricerca
Ed eccoci al punto dolente. La revisione sistematica che ho analizzato (registrata su PROSPERO, per chi ama i dettagli tecnici, con il numero CRD42023476977) ha setacciato migliaia di studi pubblicati tra il 2000 e il 2023 su database come MEDLINE, Embase e CINAHL. L’obiettivo? Capire se l’appartenenza etnica influenzi il tipo di cure farmacologiche palliative ricevute.
Sapete quanti studi hanno soddisfatto i criteri di inclusione dopo questa enorme scrematura? Solo dieci. E la cosa che salta subito all’occhio è che tutti provenivano dagli Stati Uniti. Questo già ci dice qualcosa sulla localizzazione geografica della ricerca su questo tema.
Cosa hanno scoperto questi dieci studi? Beh, la tendenza generale è abbastanza chiara: esistono disparità etniche significative. In particolare, le popolazioni appartenenti a minoranze etniche (come afroamericani, ispanici, asiatici) sembrano avere meno probabilità di ricevere farmaci adeguati per la gestione dei sintomi, soprattutto per il controllo del dolore, e in particolare gli oppioidi, rispetto ai pazienti bianchi non ispanici. Uno studio, ad esempio, ha rilevato che i pazienti ispanici, neri e di altre etnie avevano meno probabilità di ricevere dosi più elevate di oppioidi rispetto ai bianchi. Altri studi, pur con qualche sfumatura, confermano questa tendenza: le minoranze etniche sembrano ricevere meno farmaci antidolorifici verso la fine della vita.

Non solo dolore. Alcuni studi suggeriscono che le persone di minoranze etniche potrebbero ricevere meno farmaci anche per gestire il disagio emotivo (come antidepressivi, antipsicotici, ansiolitici) o la nausea. Curiosamente, uno studio ha indicato che potrebbero invece ricevere più farmaci per la stanchezza (fatigue) o per l’anoressia (stimolanti dell’appetito). Un quadro complesso, insomma, ma con un filo rosso preoccupante legato all’accesso diseguale alle terapie fondamentali.
Non Solo Etnia: L’Intreccio con Altri Fattori (Intersectionality)
La faccenda si complica ulteriormente. La revisione ha utilizzato un approccio interessante, basato sul cosiddetto “Kunonga Framework”, che a sua volta si appoggia al “PROGRESS-Plus”. Non spaventatevi per i nomi! In pratica, significa guardare non solo all’etnia, ma a come questa si intreccia con altri fattori sociali e personali che determinano la nostra salute. Parliamo di:
- Luogo di residenza: Vivere in un’area urbana o rurale fa differenza? Sembra di sì, ma i risultati non sono sempre univoci. Ad esempio, chi vive in aree meno urbanizzate potrebbe avere più difficoltà ad accedere a certi farmaci, ma magari più facilmente ad altri.
- Genere/Sesso: Anche qui i risultati sono contrastanti. Alcuni studi suggeriscono che gli uomini ricevano più antidolorifici, altri il contrario. Le donne sembrano ricevere meno farmaci per anoressia e stanchezza, ma forse di più per dispnea, disagio emotivo e nausea.
- Età: L’età avanzata sembra essere un fattore associato a una minore probabilità di ricevere farmaci antidolorifici. Per altri sintomi, la relazione con l’età è meno chiara o variabile.
- Status Socioeconomico (SES): La povertà o la ricchezza influenzano le cure? Assolutamente sì. La revisione ha trovato che il SES interagisce con l’etnia, a volte mitigando, a volte peggiorando le disparità. Ad esempio, in aree ad alta povertà, le disparità per pazienti asiatici e ispanici sembravano ridursi leggermente, ma peggioravano per i pazienti afroamericani.
- Capitale Sociale: Persino lo stato civile può contare! Uno studio ha suggerito che le persone non sposate potrebbero ricevere meno farmaci per anoressia, disagio emotivo e nausea rispetto a quelle sposate.
Questo concetto di “intersectionality” è fondamentale: le disuguaglianze non nascono da un solo fattore, ma dall’intersecarsi di diverse condizioni sociali e personali che creano barriere uniche e composite. Solo uno studio ha adottato una prospettiva “lifecourse”, cioè ha guardato a come le disuguaglianze si sviluppano nel corso della vita, scoprendo che per alcuni gruppi, come i pazienti afroamericani, le disparità possono addirittura peggiorare nel tempo.

Uno Sguardo Oltre gli Stati Uniti? Il Grande Punto Interrogativo
Come dicevo, tutti gli studi inclusi nella revisione sono stati condotti negli USA. Questo è un limite enorme. Ci dice molto sul sistema sanitario americano e sulle sue specifiche dinamiche sociali e razziali, ma ci lascia con un grande punto interrogativo: cosa succede nel resto del mondo? E in Italia? Esistono anche da noi disparità simili nell’accesso alle cure palliative farmacologiche basate sull’origine etnica, magari intrecciate con lo status socioeconomico, la provenienza geografica (Nord vs Sud, città vs campagna) o altri fattori?
La revisione sottolinea proprio questa necessità: serve urgentemente ricerca al di fuori degli Stati Uniti per capire se queste disparità siano un fenomeno globale o specifico di certi contesti. Senza dati da altri paesi ad alto reddito (e potenzialmente anche da quelli a medio e basso reddito), è difficile avere un quadro completo e sviluppare strategie efficaci a livello internazionale.
Limiti dello Studio e Prospettive Future: Cosa Possiamo Fare?
Ogni ricerca ha i suoi limiti, ed è giusto riconoscerli. Essendo una revisione “rapida”, la ricerca è stata limitata a tre database e agli studi in lingua inglese, escludendo la “letteratura grigia” (come report, tesi, etc.). Questo potrebbe aver fatto perdere qualche pezzo del puzzle. Inoltre, la maggior parte degli studi si concentrava sul dolore, lasciando un po’ in ombra la gestione di altri sintomi palliativi importanti. Non è stato possibile, data l’eterogeneità degli studi, fare una meta-analisi (un’analisi statistica combinata), ma ci si è basati su una sintesi narrativa. Infine, l’impatto della pandemia di COVID-19, che ha sicuramente stravolto anche le cure palliative, non è stato analizzato specificamente.
Cosa possiamo portarci a casa, allora? La consapevolezza che, almeno nel contesto statunitense, l’accesso a cure farmacologiche palliative adeguate non sembra essere uguale per tutti. L’etnia gioca un ruolo, spesso in negativo per le minoranze, e questo ruolo è modulato da tanti altri fattori sociali.
Cosa fare? La revisione suggerisce alcune piste:
- Migliorare la competenza culturale degli operatori sanitari: capire e rispettare background culturali diversi è fondamentale per comunicare efficacemente e personalizzare le cure.
- Integrare maggiormente i farmacisti nei team di cure palliative: la loro expertise può aiutare a ottimizzare le terapie e ridurre le disparità.
- Promuovere la ricerca: servono più studi, soprattutto fuori dagli USA, che usino metodologie rigorose, definiscano bene l’etnia, considerino l’intersectionality e la prospettiva lifecourse, e indaghino anche le variazioni farmacogenetiche tra gruppi etnici (come i diversi gruppi rispondono ai farmaci), un campo ancora poco esplorato nelle minoranze.
- Affrontare le barriere d’accesso: non basta migliorare le prescrizioni una volta che il paziente è “nel sistema”, bisogna capire perché alcuni gruppi etnici potrebbero avere più difficoltà ad accedere proprio ai servizi di cure palliative specialistiche.
In conclusione, anche se i farmaci sono strumenti potenti per alleviare la sofferenza alla fine della vita, sembra che non tutti abbiano le stesse possibilità di beneficiarne appieno. È una questione di equità e di dignità che non possiamo ignorare. La speranza è che questa revisione, pur con i suoi limiti, stimoli più ricerca e più azione per garantire che le cure palliative siano davvero per tutti, indipendentemente dall’origine etnica.
Fonte: Springer