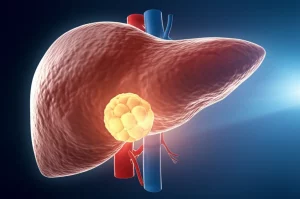Drenaggi Ventricolari e Infezioni in Terapia Intensiva: Un Sospetto è Abbastanza per Curare?
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi nel cuore pulsante della terapia intensiva neurologica, un posto dove la tecnologia e la cura si fondono per salvare vite in condizioni critiche. Parliamo di un dispositivo fondamentale: il drenaggio ventricolare esterno (DVE). Sapete, quei tubicini che aiutano a gestire la pressione nel cervello di pazienti molto gravi. Strumenti salvavita, certo, ma con un tallone d’Achille non da poco: il rischio di infezioni.
Il Grosso Problema: Le Infezioni Associate ai DVE (EVDI)
Immaginate la scena: un paziente neurocritico, già fragile, a cui viene inserito un DVE. È una procedura necessaria, ma apre una porta, seppur piccola, a batteri indesiderati. Le infezioni associate ai DVE, che chiameremo EVDI (dall’inglese EVD-associated infections), sono un incubo. Possono colpire fino al 35% dei pazienti con DVE, peggiorando drasticamente la prognosi, aumentando la mortalità, i deficit neurologici a lungo termine, i tempi di degenza e, ovviamente, i costi. Un bel problema, vero?
Ma la faccenda si complica ulteriormente. Definire con certezza un’EVDI non è così semplice come sembra. Non esiste una definizione universale, i criteri diagnostici variano da studio a studio e, diciamocelo, i segni clinici e biochimici (come quelli che cerchiamo nel liquido cefalorachidiano, o liquor) possono essere molto ambigui nei pazienti critici. Febbre? Alterazioni nel liquor? Potrebbero essere dovute all’infezione, ma anche a mille altre cause legate alla condizione di base del paziente o all’infiammazione “sterile” (asettica) del sistema nervoso.
Il Dilemma del Clinico: Trattare o Non Trattare?
E qui casca l’asino. Nel dubbio, cosa fa il medico? Spesso, per non rischiare, inizia una terapia antibiotica “ad ampio spettro”, cioè che copre tanti batteri diversi. È una scelta comprensibile, dettata dalla prudenza. Ma se il sospetto poi si rivela infondato? Se quella che sembrava un’infezione era solo un’infiammazione asettica? Il risultato è un massiccio sovrautilizzo di antibiotici. Questo non solo espone il singolo paziente a farmaci non necessari (con i loro potenziali effetti collaterali), ma contribuisce a un problema ancora più grande a livello globale: l’antibiotico-resistenza. Un nemico silenzioso ma temibilissimo.
Ecco perché un gruppo di ricercatori del Karolinska University Hospital, in Svezia, si è posto una domanda cruciale: i parametri che usiamo di routine per monitorare questi pazienti sono davvero efficaci nel distinguere un’infezione vera da una sospetta? Possono aiutarci a evitare di trattare chi non ne ha bisogno? Hanno così condotto uno studio retrospettivo enorme, analizzando i dati di ben 1828 pazienti trattati con DVE tra il 2006 e il 2023. Un lavoro imponente!

Lo Studio Svedese: Numeri che Fanno Riflettere
I ricercatori hanno diviso i pazienti in tre gruppi:
- Nessuna Infezione (NI): Colture del liquor negative, nessuna terapia antibiotica mirata per EVDI.
- Infezione Sospetta (SI): Colture negative (o considerate contaminazioni), ma terapia antibiotica mirata iniziata sulla base del sospetto clinico e biochimico.
- Infezione Verificata (VI): Colture positive e terapia antibiotica mirata.
I risultati? Preparatevi, perché sono abbastanza sconcertanti. Su 1828 pazienti:
- Il 70% non ha avuto infezioni (NI).
- Ben il 25.7% (quasi 470 pazienti!) è stato trattato per un’infezione sospetta (SI) che poi non è stata confermata dalle colture.
- Solo il 4.1% (75 pazienti) ha avuto un’infezione confermata dalle colture (VI).
Il dato più allarmante è proprio quel 25.7% di “sospetti”. Significa che un quarto dell’intera coorte ha ricevuto antibiotici ad ampio spettro probabilmente inutilmente! Pensate all’impatto: questi pazienti, che rappresentavano circa il 3% del totale dei ricoveri in terapia intensiva in quell’ospedale, hanno consumato il 15% di tutti gli antibiotici usati nell’intero reparto in 17 anni (misurato in giorni di trattamento). Una cifra enorme!
I Parametri Tradizionali: Un Aiuto Limitato
Ma allora, quali parametri hanno analizzato i ricercatori per vedere se potevano distinguere i gruppi SI e VI? Hanno guardato tutto: cellule nel liquor (globuli bianchi come granulociti e monociti), proteine, glucosio, lattato, rapporto glucosio liquor/sangue, proteina C-reattiva (CRP) nel sangue, temperatura, stato neurologico (Glasgow Coma Scale)… insomma, tutto l’armamentario diagnostico standard.
E il verdetto è stato impietoso. Nessuno di questi parametri, né da solo né combinato in modelli statistici complessi, è riuscito a distinguere in modo affidabile tra infezione sospetta (SI) e infezione verificata (VI). I modelli predittivi migliori avevano un’accuratezza bassissima (un pseudo-R² di appena 0.06, che in pratica significa spiegare pochissimo della differenza tra i gruppi).
Il lattato nel liquor è emerso come il singolo fattore “migliore” in analisi semplici, essendo significativamente più alto nel gruppo VI rispetto al SI. Ma attenzione: la sua capacità discriminatoria era comunque molto bassa. Lo studio ha identificato un possibile cut-off di >8.9 mmol/L per sospettare fortemente un’infezione vera, ma solo 3 pazienti del gruppo VI (il 4%!) superavano questa soglia. In pratica, clinicamente poco utile. Inoltre, livelli elevati di lattato (>4.0 mmol/L, soglia spesso usata) erano presenti anche in un quarto dei pazienti senza infezione (NI), suggerendo che possa essere legato anche alla malattia di base e non solo all’infezione. Usare soglie basse come 4.0 mmol/L potrebbe quindi contribuire proprio al sovratrattamento che vogliamo evitare.
E gli altri?
- Glucosio nel liquor e rapporto liquor/sangue: Differenze minime o non significative tra SI e VI, scarsa utilità predittiva.
- Conteggio dei globuli bianchi (pleocitosi): Nessuna differenza significativa nei granulociti tra SI e VI. I monociti erano leggermente diversi, ma con un potere predittivo quasi nullo. L’aumento dei globuli bianchi, spesso considerato un segno d’infezione, sembra essere un indicatore molto poco affidabile in questo contesto, probabilmente perché l’infiammazione asettica (dovuta magari a sangue nel cervello) può causare quadri simili.
- Proteina C-Reattiva (CRP) nel sangue: Addirittura, i livelli erano più alti nel gruppo SI che nel VI! Questo probabilmente non significa che la CRP protegga dalle infezioni, ma che i medici tendono a considerare la CRP alta come un segno d’allarme (anche se la letteratura non supporta un forte legame con le EVDI) e quindi iniziano più facilmente la terapia antibiotica, “gonfiando” il gruppo SI di pazienti con CRP alta.
- Altri parametri (temperatura, GCS): Nessuna differenza utile.

Il succo è questo: i test che usiamo oggi, basati su segni indiretti di infezione, non riescono a distinguere l’infiammazione “buona” (asettica) da quella “cattiva” (infettiva) in modo affidabile nei pazienti neurocritici con DVE.
Perché Questa Difficoltà? E Cosa Fare?
Gli autori dello studio ipotizzano che le rigorose misure igieniche adottate (come quelle del Karolinska: inserimento sterile in sala operatoria, medicazioni quotidiane, campionamento asettico) riducano la carica batterica nelle eventuali infezioni. Questo potrebbe rendere la risposta infiammatoria meno “esplosiva” e più difficile da distinguere dall’infiammazione di base. Inoltre, i batteri più comuni in queste infezioni (come gli Stafilococchi coagulasi-negativi) possono dare quadri più subdoli rispetto a quelli di una meningite classica.
Cosa ci portiamo a casa da questo studio imponente? Un messaggio forte e chiaro: dobbiamo ripensare radicalmente l’approccio diagnostico alle EVDI. Continuare a basarci solo sui parametri attuali porta inevitabilmente a un eccesso di prescrizione antibiotica, con tutte le conseguenze negative che conosciamo.
La strada da percorrere? Sembra puntare verso tecnologie più dirette e rapide per identificare i batteri nel liquor. Gli autori suggeriscono, ad esempio, i metodi di sequenziamento rapido “al letto del paziente” (bedside sequencing). Immaginate di poter avere una risposta affidabile sulla presenza e sul tipo di batterio in tempi brevi, invece di aspettare giorni per una coltura (che potrebbe comunque essere negativa anche in caso di sospetto clinico forte). Questo permetterebbe decisioni terapeutiche molto più mirate e tempestive, riservando gli antibiotici solo a chi ne ha davvero bisogno.

Certo, lo studio ha i suoi limiti (retrospettivo, monocentrico, dati mancanti), ma le sue dimensioni e la robustezza dell’analisi lo rendono un punto di riferimento importante. Ci sbatte in faccia un problema clinico rilevante: nel tentativo di proteggere i nostri pazienti più fragili, rischiamo di esporli a trattamenti non necessari e di alimentare il mostro dell’antibiotico-resistenza. È ora di investire in ricerca e innovazione per trovare strumenti diagnostici più precisi. Ne va della salute dei singoli pazienti e della collettività.
Fonte: Springer