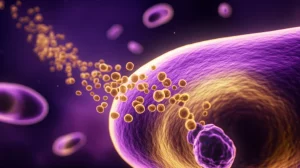Diabete Tipo 2 e Sete Incontrollabile: Quando un Farmaco Svela un Raro Segreto
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di una storia medica davvero intrigante, una di quelle che ti fanno capire quanto il nostro corpo sia una macchina complessa e, a volte, imprevedibile. Immaginate di avere il diabete di tipo 2 (T2DM), una condizione già abbastanza impegnativa da gestire. Ora, aggiungete un’altra condizione rara, il diabete insipido centrale (CDI), che emerge dopo una crisi seria come lo stato iperosmolare iperglicemico (HHS). Sembra un rompicapo, vero? Beh, lo è stato, soprattutto perché un farmaco comunemente usato per il diabete ha aggiunto un ulteriore livello di mistero.
Una Diagnosi Complicata Fin Dall’Inizio
Tutto inizia con una giovane donna di 22 anni. Le viene diagnosticato il diabete di tipo 2. Parametri classici: glicemia a digiuno alta, emoglobina glicata (HbA1C) pure, familiarità, obesità… ma niente sintomi evidenti come la sete eccessiva (polidipsia) o il bisogno continuo di urinare (poliuria). Le viene prescritta la metformina e consigliato un cambio di stile di vita.
Poco dopo, scopre di essere incinta e interrompe la metformina. Ma la gravidanza porta con sé una complicazione gravissima: a sette settimane, arriva al pronto soccorso con vomito insistente, debolezza, una sete improvvisa e intensa, e una produzione di urina aumentata. La diagnosi è pesante: stato iperosmolare iperglicemico (HHS). I suoi valori sono alle stelle: glicemia altissima, sodio sierico corretto a livelli pericolosi (166.96 mmol/L), creatinina elevata. La situazione è critica.
Il Mistero dell’Ipernatriemia Senza Sete
In poche ore, la paziente perde conoscenza, finisce in terapia intensiva. Viene trattata secondo i protocolli per l’HHS, e fortunatamente si riprende in 24 ore. Ma le complicazioni non finiscono: sviluppa una pancreatite acuta grave e, purtroppo, ha un aborto spontaneo. Viene curata per lo shock, l’insufficienza renale acuta, la pancreatite.
Dopo dieci giorni, HHS e pancreatite migliorano, ma ecco che emerge un problema strano: il sodio nel sangue (ipernatriemia) torna alto e rimane tale, nonostante la somministrazione di liquidi. La produzione di urina aumenta fino a 10 litri al giorno, con una bassa densità specifica, inizialmente attribuita alla fase di recupero renale. Viene dimessa, ma la situazione non è risolta.
Tornata a casa, continua ad avere problemi, perde peso. Viene ricoverata di nuovo nel nostro reparto di endocrinologia per l’ipernatriemia persistente e il diabete mal controllato. Il sodio è ancora alto (165.7 mmol/L), e la cosa più strana è che non ha sete (adipsia), nonostante la disidratazione. Questo ci fa sospettare un diabete insipido adipsico. Una risonanza magnetica (MRI) della ghiandola pituitaria mostra l’assenza del segnale luminoso tipico della neuroipofisi nelle immagini T1, un segno classico di CDI, ma senza altre anomalie evidenti. Gli ormoni ipofisari anteriori sono normali.

Il Colpo di Scena: Arriva un Nuovo Farmaco
La paziente viene dimessa con una terapia insulinica intensificata, ma il controllo glicemico peggiora con l’aumento dell’assunzione di cibo e il recupero di peso. Per aiutarla con glicemia e obesità, in un altro ospedale le viene aggiunto un farmaco della classe degli inibitori SGLT2: la dapagliflozina.
E qui succede l’incredibile. Poco dopo aver iniziato la dapagliflozina, la paziente sviluppa una sete progressiva e incontenibile (polidipsia), arrivando a bere fino a 10 litri d’acqua al giorno! Paradossalmente, durante questo periodo, l’ipernatriemia si risolve. Viene ricoverata di nuovo da noi per valutare questa situazione esplosiva: iperglicemia, polidipsia e poliuria estrema.
La sua HbA1C è schizzata al 13.6%. La produzione di urina è di circa 7.5 litri in 24 ore, ma la densità specifica delle urine oscilla tra 1.008 e 1.018. Questo è strano: nel diabete insipido ci aspetteremmo urine costantemente molto diluite (densità < 1.015).
Svelare il Vero Problema: L’Effetto Mascherante dell’SGLT2 Inibitore
La nostra ipotesi? La dapagliflozina stava confondendo le acque. Gli inibitori SGLT2 funzionano facendo eliminare glucosio (e sodio) attraverso le urine. Questo processo, chiamato glicosuria, aumenta la concentrazione di soluti nelle urine (aumentando la densità e l’osmolalità) e provoca una diuresi osmotica (più urina a causa dei soluti). Il diabete insipido, invece, causa una poliuria ipotonica (tanta urina molto diluita) per mancanza dell’ormone antidiuretico (vasopressina o ADH).
In pratica, l’effetto della dapagliflozina (e del glucosio stesso dovuto al diabete scompensato) stava “mascherando” la bassa densità urinaria tipica del CDI. Era come se due forze opposte agissero sulle urine: il CDI le diluiva, la dapagliflozina (e il glucosio) le concentrava (relativamente parlando).
Decidiamo quindi di sospendere la dapagliflozina. Dopo 48 ore, eseguiamo il test di deprivazione idrica. I risultati sono chiari: l’osmolalità del siero sale molto (da 306 a 330 mOsm/kg), mentre quella delle urine aumenta pochissimo (da 19 a 86 mOsm/kg), con una densità massima di 1.010. Bingo! Conferma di diabete insipido centrale (CDI).

Iniziamo il trattamento con desmopressina orale (un analogo sintetico della vasopressina). La risposta è immediata: la produzione di urina scende a 3 litri al giorno, la poliuria notturna scompare e l’osmolalità urinaria sale a 388 mOsm/kg. La paziente viene dimessa con insulina e desmopressina. A distanza di due anni, sta bene, con diabete controllato e livelli di sodio normali, ma ha ancora bisogno della desmopressina per mantenere l’equilibrio idrico.
Perché è Successo Tutto Questo? E Cosa Impariamo?
La coesistenza di T2DM e CDI è rara. Le cause del CDI possono essere diverse (tumori, metastasi, sindromi genetiche come quella di Wolfram). In questo caso, l’origine esatta non è chiara, ma è probabile che sia legata alla cascata di eventi stressanti: l’HHS, lo shock ipovolemico dovuto alla pancreatite e alla disidratazione, forse anche la gravidanza stessa (anche se il diabete insipido gestazionale è stato escluso). L’ipotesi più probabile è che lo shock o la grave disidratazione abbiano danneggiato le cellule dell’ipotalamo o dell’ipofisi posteriore responsabili della produzione o del rilascio di vasopressina.
L’aspetto affascinante è il ruolo dell’inibitore SGLT2:
- Ha mascherato la diagnosi: impedendo di vedere la tipica urina diluita del CDI a causa della glicosuria indotta.
- Ha probabilmente esacerbato i sintomi: una volta che la sete è tornata (forse per il recupero dei neuroni che la regolano), l’effetto diuretico aggiuntivo dell’SGLT2 ha peggiorato la poliuria e la polidipsia.
- Studi suggeriscono che gli SGLT2 inibitori potrebbero influenzare l’espressione dei canali dell’acqua (acquaporina-2) nei reni, potenzialmente riducendo leggermente l’efficacia della desmopressina.

Il Messaggio Chiave
Questa storia ci insegna alcune cose fondamentali:
1. Bisogna pensare al CDI nei pazienti con diabete tipo 2 che sviluppano ipernatriemia persistente dopo un episodio di HHS, anche se non hanno sete inizialmente.
2. Gli inibitori SGLT2 possono complicare la diagnosi e la gestione del CDI. Mascherano la poliuria ipotonica e alterano l’osmolalità urinaria.
3. È cruciale sospendere gli inibitori SGLT2 se si sospetta un CDI, per poter eseguire test diagnostici affidabili (come il test di deprivazione idrica) e valutare correttamente la funzione renale e l’equilibrio idrico.
Insomma, un caso complesso che ci ricorda di guardare sempre oltre le apparenze e di considerare come i diversi farmaci e condizioni possano interagire in modi inaspettati. Alla prossima!
Fonte: Springer