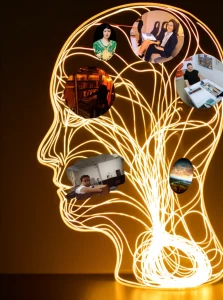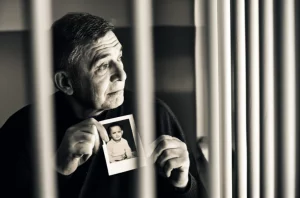Decolonizzare gli Aiuti: È Ora di Entrare nella Zona di Disagio per Cambiare Davvero
Sapete una cosa? Ne parliamo tutti, continuamente. A conferenze, workshop, riunioni, davanti a un caffè o a un aperitivo. “Il cambiamento è necessario, ma va troppo lento”, diciamo noi progressisti del settore umanitario. E allora, perché, nonostante questa diffusa volontà, le relazioni di potere nel sistema degli aiuti umanitari restano così sbilanciate? Perché le risorse continuano a fluire in modo ineguale tra gli attori locali e nazionali (spesso nel Sud del mondo) e le Organizzazioni Non Governative Internazionali (ONG Internazionali, o INGO, con sede spesso nel Nord del mondo)? Bella domanda, vero? Oggi voglio provare a dare qualche spunto, partendo da un presupposto: noi, operatori dei programmi nelle INGO, abbiamo un ruolo e una responsabilità che forse non ci prendiamo fino in fondo.
L’inerzia che ci blocca: perché le buone intenzioni non bastano
Negli ultimi decenni, il sistema umanitario ha fatto passi da gigante. Pensiamo al progetto Sphere, nato nel 1997, che ha definito standard minimi e una carta umanitaria per garantire dignità e assistenza di qualità. Un faro per tutti noi. Eppure, le sfide persistono, anzi, i bisogni umanitari globali sono in aumento. Così, nel 2016, è arrivato il Grand Bargain: un patto tra stati, ONG, agenzie ONU e altri attori potenti, che prometteva cambiamenti sistemici enormi. Parole d’ordine: partecipazione, localizzazione (cioè più potere e risorse agli attori locali) e finanziamenti di qualità (flessibili, pluriennali, per rafforzare le capacità locali). Sembrava la svolta. E invece? Rapporti recenti, commissionati dallo stesso sistema del Grand Bargain, ci dicono che i cambiamenti sono lenti, a volte addirittura in regressione. John Mitchell, consulente di ALNAP, parla da anni di “inerzia funzionante”. Deborah Doane, nel suo recente libro “The INGO Problem”, sottolinea come sia proprio il predominio delle INGO a perpetuare questo stallo, a scapito dei partner locali.
Spesso, quando si parla di attori, si pensa ai leader, a chi ha influenza su politiche e finanze. Certo, loro hanno un ruolo dominante nel mantenere lo status quo. Ma io voglio accendere un faro su un altro gruppo: noi, gli operatori programmatici delle INGO. Siamo quelli che lavorano direttamente sui programmi, che hanno contatti quotidiani con i partner locali nei luoghi dove c’è bisogno. Dorothea Hilhorst (2018) sostiene che spesso noi operatori umanitari minimizziamo il nostro ruolo. Io credo, invece, che siamo in una posizione privilegiata per essere mediatori del cambiamento. Abbiamo conoscenze, esperienza, motivazione e una posizione sociale che ci permetterebbe di connettere idee, mentalità e pratiche diverse. Il problema, a mio avviso, è che spesso non ci assumiamo attivamente questa responsabilità. Come? Principalmente in due modi: scaricando il barile sul “sistema umanitario” e scaricandolo sui “partner locali e nazionali”.
Smettiamola di dare la colpa al “Sistema”
Quante volte abbiamo detto o sentito dire: “Eh, ma è il sistema che non funziona, che è troppo burocratico, che ha procedure rigide…”? Certo, le procedure farraginose, le politiche restrittive e gli interessi politici rendono il quadro istituzionale poco flessibile. Ma il punto è un altro: non possiamo usare “il sistema” come scudo per la nostra inazione. Il sistema umanitario non è un’entità astratta che agisce da sola. È un’industria, sono reti, un’arena sociale e politica fatta di persone che lavorano in organizzazioni con diversi livelli di potere e influenza. È un campo sociale, per dirla con Bourdieu, dove i giocatori dominanti – gli incumbent – vogliono mantenere lo status quo, mentre quelli insoddisfatti – gli insurgent – cercano di cambiare le regole del gioco. Ecco, la mia sfida è proprio questa: noi operatori programmatici delle INGO dobbiamo diventare insurgent, non incumbent, praticando un lavoro umanitario che sfidi lo status quo, che spesso indulge in pratiche coloniali e razziste strutturali. E qui arriviamo al cuore della questione: la decolonizzazione degli aiuti.
Un esempio classico di come si scarica il barile è proprio riferirsi all’eredità coloniale e al razzismo strutturale “del sistema”. Noi operatori, generalmente, non ci consideriamo colonizzatori o razzisti. E riferirsi al colonialismo e al razzismo innati del sistema ci permette di prendere facilmente le distanze da quelle azioni e procedure discriminatorie che perpetuano le strutture coloniali e razziste. Invece, da ex operatrice programmatica, sostengo che è proprio qui che dobbiamo metterci in gioco: riconoscere la nostra posizione e il nostro ruolo nel mondo e nella sua storia, e quindi renderci conto del nostro margine di azione per cambiare il sistema. Possiamo dare un contributo vitale alla decolonizzazione degli aiuti umanitari, se osiamo impegnarci in questo processo, anche se ci porterà un certo disagio. E, diciamocelo, chi di noi non ha mai vissuto il colonialismo e il razzismo strutturale sulla propria pelle, ha bisogno dell’aiuto di chi invece li ha vissuti.

Ora, parliamo di come spesso si sposti l’attenzione sui partner locali e nazionali, sostenendo che loro devono cambiare prima che il cambiamento possa avvenire. Mi riferisco agli sforzi per aumentare la loro partecipazione e per il rafforzamento delle loro capacità (capacity strengthening). Intenzioni lodevoli, per carità. Una maggiore partecipazione dovrebbe garantire interventi più pertinenti e significativi, costruire resilienza locale e rendere sostenibili i cambiamenti positivi. Il “capacity strengthening” una volta si chiamava “capacity building”, ma poi è sorto il disagio verso questa narrazione che implicava una mancanza di capacità da parte degli altri. Così, gli attori progressisti hanno iniziato a parlare di “rafforzamento”, per sottolineare che le capacità c’erano, ma andavano potenziate. Di solito, ci si concentra su capacità tecniche specifiche o sull’adeguare il loro lavoro umanitario alle procedure e alle pratiche normative del settore, per garantire efficienza ed efficacia. Negli ultimi anni, il termine si è evoluto in “capacity sharing” (condivisione delle capacità). VOICE, una grande rete di ONG umanitarie europee, lo definisce come un approccio che mira a integrare e rafforzare le capacità esistenti piuttosto che imporre schemi esterni, riconoscendo gli squilibri di potere e cercando di promuovere partenariati equi. Bello, no? Peccato che, come cercherò di mostrare, anche questi sforzi non portino a un cambiamento verso partenariati più equi, perché continuano a focalizzarsi su una presunta mancanza di capacità da parte degli attori locali e nazionali.
Decolonizzare gli Aiuti: Un Imperativo (e un po’ di autobiografia metodologica)
Prima di addentrarci, una premessa. Questo articolo si inserisce nel dibattito sulla decolonizzazione dell’agenda degli aiuti, perché sono convinta, come altri (Fellow e Paige, 2021b; Peace Direct, 2022), che la chiave per un cambiamento sistemico stia proprio nella decolonizzazione. Decolonizzare significa apportare cambiamenti strutturali, sistemici e istituzionali a processi nati in epoca coloniale, comprese le relazioni intersoggettive tra popoli di società precedentemente colonizzate e colonizzatrici (Ndlovu-Gatsheni, 2015). E io, come chiunque altro, ho un ruolo da giocare in queste relazioni. Per questo, la mia metodologia è stata l’auto-etnografia, supportata da voci raccolte attraverso ascolto e conversazione.
Alcune intuizioni sono nate da un progetto di ricerca-azione che stavo pianificando con ex colleghi, dopo il mio recente passaggio dal settore ONG a un’università. L’idea era di indagare le barriere a partenariati equi tra INGO danesi e controparti locali. Un’opportunità si è presentata nel novembre 2022, quando sono stata invitata a partecipare come ricercatrice indipendente a un “Women in Humanitarian Leadership Summit in Uganda”, organizzato dal Charter4Change working Group Uganda. Le voci che sentirete sono quindi rappresentative di una particolare prospettiva ugandese, un amalgama complesso di esperienze coloniali e post-coloniali diverse. Ho usato l’osservazione partecipante, ho avuto innumerevoli colloqui informali, oltre ad aver condotto tre interviste semi-strutturate con sei operatrici umanitarie. A questo si aggiunge la mia esperienza personale nel settore ONG (in Danimarca e in un’ONG ugandese) e le continue conversazioni con ex colleghi e amici. E, cosa forse non convenzionale per un accademico, ho tratto enorme ispirazione dalla narrativa di autori provenienti da società ex-colonizzate. È stato “Black and Female” di Tsitsi Dangarembga (2020) a instradarmi sulla via della decolonizzazione come chiave di lettura per la decolonizzazione degli aiuti umanitari. Sono una donna bianca, cis-etero, di mezza età, istruita, non conformista, di un paese ricco (anche se cresciuta in una famiglia monogenitoriale non abbiente), e sono in un continuo processo di riflessione sul mio ruolo in tutto questo. Sto cercando di esplorare tutti i modi in cui sono privilegiata e so che ci sono modi in cui non lo sono. Sono grata a Tsitsi Dangarembga per avermi avviato su questo sentiero.
Il vantaggio della mia posizione è che so quanto sia immensamente difficile quello che sto suggerendo: cambiare la propria percezione e riconoscere la propria responsabilità. Non so esattamente cosa non so, cosa non vedo, non sento e non capisco, e questa consapevolezza mi rende umile. Ho sperimentato come il riconoscimento di questa posizione di privilegio possa portare a pensieri di inazione, e quanto sia delicato l’equilibrio per fare qualcosa senza, ancora una volta, oltrepassare i limiti e rubare la storia di qualcun altro. Per esempio, spesso ci si presenta come “amplificatori” delle voci di chi ha meno spazio. Ho abbracciato anch’io questa idea, quando una delle donne ugandesi con cui ho parlato me l’ha graziosamente offerta. Ma scrivendo questo articolo, mi sono resa conto che il ruolo di amplificatore mi stava stretto. Non sono le mie capacità oratorie o le mie possibilità che servono. Ciò che serve è ascoltare ed essere ricettivi a Tsitsi Dangarembga e ad altri che condividono le loro storie, prospettive ed esperienze. Fortunatamente, oggi le condizioni sono più favorevoli perché queste voci si alzino e vengano ascoltate, anche se la strada è ancora lunga.
Un “Hack” Teorico per Cambiare Prospettiva: Ingold e la “Minor Key”
Il discorso sulla decolonizzazione degli aiuti è diventato sempre più frequente negli ultimi anni. Quando ho lasciato il mio lavoro nel settore ONG nel 2022, il concetto stava guadagnando terreno. Oggi, parlando con ex colleghi, la decolonizzazione è all’ordine del giorno. Questo non significa che le riflessioni sugli squilibri di potere siano una novità. Tuttavia, l’obiettivo di questo articolo non è aggiungere altro al corpus accademico sulla decolonizzazione, ma portarlo a un livello pratico. Il rapporto “Time to Decolonise Aid” (Fellow e Paige, 2021b) evidenzia che l’enfasi sulla localizzazione emersa dal Grand Bargain, pur essendo un passo nella giusta direzione, è inadeguata se non si inserisce in una conversazione più profonda sul potere e sul razzismo strutturale, una conversazione che l’agenda della decolonizzazione ha contribuito a far emergere. La decolonizzazione si concentra sul cambiamento delle relazioni e delle dinamiche intersoggettive per creare partenariati equi; al contrario, l’agenda della localizzazione mantiene l’idea binaria delle INGO che “trasmettono” qualcosa agli attori locali e nazionali.
Questo articolo si rivolge agli operatori programmatici, incoraggiandoli a usare lo spazio di manovra che hanno. Le INGO sono spesso i principali destinatari dei finanziamenti dei donatori, e molto spesso gli attori locali e nazionali hanno un ruolo di subappalto. Ciò significa che anche le INGO detengono potere, e qui c’è spazio per agire diversamente su come vengono concordati i contratti di partenariato. Ma per farlo, le percezioni devono cambiare. La letteratura sulla decolonizzazione sostiene che un enorme ostacolo al cambiamento risiede nel modo in cui gli attori umanitari internazionali percepiscono il lavoro, i bisogni, i rischi, le migliori pratiche, le capacità e le risorse (Aloudat e Khan, 2022; Barbelet et al., 2021; Fellow e Paige, 2021b). Il sistema degli aiuti umanitari è informato da idee eurocentriche su conoscenze superiori e inferiori, capacità, sviluppo e benessere, e le pratiche e i partenariati sono radicati nel “paternalismo bianco” o nello “sguardo bianco”. Il problema è che per un operatore programmatico con il mio stesso background – bianco ed europeo – cosa comporti uno “sguardo bianco” è invisibile, come tutti gli altri privilegi, finché non ne divento consapevole e mi impegno attivamente per rendermene conto.
Per aiutarci in questo, traggo ispirazione dall’antropologo Tim Ingold e dalla sua opera “Anthropology and/as Education” (2018). Lo considero un “hack teorico” perché credo che i suoi concetti abbiano il potenziale per scardinare le nostre mentalità e farci pensare diversamente alle dinamiche tra attori in relazioni di potere diseguali. Ingold propone un approccio che mette gli attori su un piano di parità nelle interazioni dove alcuni sono tradizionalmente visti come più potenti (nel suo caso, l’educatore e gli studenti). L’obiettivo è passare dalla “trasmissione di conoscenza” (un certo tipo di conoscenza da una persona più potente ad altre) a una conoscenza che emerge dagli impegni tra le persone. È nella corrispondenza tra persone e cose, persone e i loro vari ambienti, e persone e persone, che risiede la promessa dell’educazione: la capacità di rispondere e di ricevere risposta. Ingold paragona questo approccio all’osservazione partecipante antropologica, che, e concordo, è veramente antropologica solo se cambia la prospettiva di tutti i partecipanti. Questo sfida l’idea normativa che la conoscenza prodotta, riprodotta e trasferita nel sistema tradizionale sia l’unica conoscenza reale. “È accettabile dire di persone che non sono andate a scuola che non sono istruite (…)? Tali persone sanno moltissimo che noi, come persone istruite, non sappiamo” (Ingold, 2018: 1). Questo risuona con un pensiero che ho avuto alla discussione di dottorato di una cara conoscente, attrice nel settore umanitario e studiosa di antropologia. Ci ha parlato delle popolazioni del Sud Sudan che vivono in contesti e situazioni umanitarie non solo da tutta la vita, ma da generazioni. Le sue intuizioni mi hanno lasciato una domanda: “Come possiamo, dalla nostra parte del mondo, continuare a sostenere l’idea che ne sappiamo più di loro sull’umanitarismo?”.
Quindi, una cosa che dobbiamo fare è cambiare la nostra percezione di quale sia il tipo di conoscenza “giusta” e accettare altri tipi di conoscenza come paritari. Inoltre, dobbiamo fare il passo ancora più difficile e accettare chi sono i detentori e i non detentori di conoscenza, accettando quindi chi sono gli attori che dovrebbero parlare e chi quelli che dovrebbero ascoltare. Sostengo che, per quanto riguarda i vari modi in cui la conoscenza viaggia, come operatori programmatici dobbiamo costruire la nostra response-ability, cioè la nostra capacità di rispondere: dobbiamo iniziare a rispondere alle persone e alla loro conoscenza condivisa invece di aspettarci una risposta. Ingold (2018) usa un’analogia musicale per dimostrare il cambiamento che vorrebbe attuare: spostare le nostre interazioni dall’essere suonate in “chiave maggiore” (major key) alla “chiave minore” (minor key). In musica, “il maggiore è fiducioso, assertivo e affermativo, il minore è ansioso, destabilizzante e inquisitivo” (ibid: 37). La chiave minore ha il potenziale per scardinare le dottrine egemoniche del maggiore. Suggerisco un “umanitarismo in chiave minore”, che implica praticare il lavoro umanitario in modi che scardinino la dottrina dall’interno, destabilizzandoci dalla zona di comfort delle solite dottrine e indagando altri tipi di conoscenza, esperienza e modi di fare le cose.

Le Trappole del “Rafforzamento delle Capacità” (o presunte tali)
L’ideale del Grand Bargain è: “L’aiuto umanitario deve essere il più locale possibile e internazionale quanto necessario”. Una ragione spesso citata per cui abbiamo ancora bisogno delle ONG internazionali è che queste avrebbero ancora capacità da trasferire alle ONG locali e nazionali prima che queste siano “pronte” (ALNAP, 2022). Tuttavia, in pratica, si vede ben poco impatto (Barbelet, 2019). Perché? Barbelet sostiene che non c’è una comprensione reciproca di cosa significhi “capacity building”, non c’è stato un approccio sistematico e allineato, né un monitoraggio ed una valutazione sistematici delle iniziative.
Una volta, l’aiuto umanitario era più “facile” da implementare, perché regnava l’idea che “noi ne sappiamo di più”. Ci sono stati molti sforzi di “capacity building” per trasferire conoscenza dagli attori internazionali a quelli locali su come fare e cosa fare in una risposta umanitaria. Negli anni ’90, questo ha iniziato a cambiare con la trasformazione del settore verso un approccio centrato sulle persone. Da allora, ci sono state molte prove di come la capacità delle persone locali alla crisi umanitaria fornisca effettivamente una risposta molto migliore (Barbelet, 2019; Barbelet et al., 2021; Boyce, 2023; Mulder, 2023; Piquard, 2022). Quindi, la vera questione rimasta è scoprire cosa sia “necessario dal sistema internazionale” (Dawes, 2022). Nonostante ciò, il settore discute ancora principalmente della mancanza di capacità degli attori locali e nazionali.
Vi racconto una storia. La coordinatrice del Segretariato di Charter4Change in Uganda mi ha spiegato come è entrata nel lavoro umanitario all’inizio di un enorme afflusso di rifugiati dal Sud Sudan nel 2016: “Avevamo una conoscenza limitata della risposta umanitaria in termini di requisiti standardizzati. Sai che devi aiutare, e stavamo aiutando, ma non conoscevamo i tecnicismi.” Se aiutare è lo scopo, la capacità c’era già. Ma una volta che “aiutare” deve essere inserito in un sistema, rispettando standard specifici e certi tecnicismi, allora la capacità è stata considerata carente. Il problema è che la capacità che manca non riguarda necessariamente il contenuto dell'”aiuto”, ma le misure burocratiche per adattarsi al sistema. Questi tecnicismi e requisiti, è stato dimostrato, non migliorano necessariamente le attività per le persone in difficoltà (Mulder, 2023).
C’è poi un altro significato di “capacità”: quello di ricoprire un ruolo. Questo è ancora più insidioso, perché si lega alle nostre mentalità. Un’operatrice umanitaria ugandese mi ha detto: “A volte non sanno che abbiamo personale con titoli di studio persino superiori ai loro nelle INGO. Qualcuno arriva e dice: ‘Vogliamo costruire capacità’… [Vorrei dire loro]: Vuoi costruire la capacità di qualcuno che ha un Master? E tu non ce l’hai. Ti sei formato sul campo. L’altra persona [nell’ONG nazionale] è persino più qualificata per costruire capacità. Ma non ne parliamo mai”. Il problema del razzismo strutturale sfida continuamente il trasferimento del potere decisionale. Affrontare il razzismo strutturale può essere visto come l’atto più decolonizzante che un’organizzazione possa intraprendere (Fellow e Paige, 2021b, p. 17). Le persone che lavorano nel settore umanitario potrebbero non essere razziste o percepirsi come tali, ma il razzismo strutturale è incorporato nel sistema.
Dobbiamo continuare ad essere umanitari, ma riconoscere che altri possono esserlo altrettanto bene, e dobbiamo iniziare a sradicare il sistema degli aiuti umanitari e cambiare il modo in cui facciamo le cose. Questo ci porta al processo di trasferimento delle capacità. “Il potenziamento delle capacità non dovrebbero essere corsi di formazione in aula. Dovresti avere un tutoraggio significativo”, mi ha detto la stessa operatrice. Ingold (2018) sostiene che la formazione, nella sua essenza, è pensata per sopprimere le differenze e allineare le conoscenze, trasmettendo la cosiddetta “giusta” conoscenza dal più potente al meno potente. Le iniziative di “capacity” sono attualmente inserite nei progetti come corsi di formazione, e i corsi sono interazioni giocate in “chiave maggiore”. Le esperienze positive, invece, si sono verificate quando una INGO ha inviato personale a lavorare fianco a fianco con gli attori locali e nazionali per imparare insieme cosa funzionava. Questi processi dovranno andare oltre per realizzare un cambiamento sistemico. È solo quando la condivisione delle capacità comporterà interazioni e impegno in “chiave minore”, permettendo alla differenza e alle sfumature della conoscenza di esistere su un piano di parità tra tutti i soggetti coinvolti, che avverrà la trasformazione (Ingold, 2018).
La Falsa Promessa della “Partecipazione”
“Niente su di noi senza di noi” era uno slogan sviluppato dai rappresentanti delle persone con disabilità, poi ripreso dagli attori locali e nazionali per significare la loro ambizione di una migliore partecipazione. Insieme a “locale quanto possibile e internazionale quanto necessario”, ricorda ai detentori del potere firmatari del Grand Bargain 2016 il loro impegno per la “rivoluzione della partecipazione”. Questa rivoluzione doveva includere non solo gli attori locali e nazionali nelle strutture di coordinamento umanitario, ma garantire che anche le persone colpite dalle circostanze umanitarie (le cosiddette Popolazioni Colpite nel gergo umanitario) facessero parte del processo decisionale. L’idea di una maggiore partecipazione risale a ben prima del 2016, ma la firma ha significato un impegno. Eppure, nel 2021, si è ammesso che la “rivoluzione della partecipazione” non era avvenuta (Dawes, 2022).
Le misure “partecipative” spesso diventano un palliativo per pratiche di “spunta la casella” da parte delle INGO, senza una reale partecipazione allo stesso livello. L’operatore ugandese di cui sopra ha condiviso un punto interessante: “A causa della pressione di alcuni donatori, stanno chiamando [i partner] a sviluppare proposte congiuntamente fin dall’inizio. Quindi questo significa che almeno partecipi allo sviluppo della proposta. Che le tue idee vengano prese in considerazione o meno, questa è un’altra storia, ma almeno quello che abbiamo visto per ora è che la nuova tendenza è che sempre più organizzazioni locali partecipano allo sviluppo delle proposte”. In quella frase buttata lì, “Che le tue idee vengano prese in considerazione o meno, questa è un’altra storia”, c’è il nocciolo della questione. Spesso i partner locali e nazionali non sanno cosa succede al progetto tra il workshop di progettazione e l’inizio del progetto. A volte, non hanno la visione completa per tutta la durata del progetto e fino alla fine. Al Summit in Uganda, una delle leader donne di Charter4Change ha chiesto: “Quanti qui hanno implementato un progetto triennale senza mai vedere un documento di progetto completo?” Risate esplosero in tutta la stanza, e io risi insieme a loro, perché riconoscevo questa situazione dal mio punto di osservazione nella sede centrale dell’INGO. L’ho fatto anch’io, tagliando sezioni di domande, modelli di rendicontazione e contratti da inviare agli attori locali in base a ciò che ritenevo rilevante per loro, piuttosto che inviare l’intero documento. Mai con cattiva intenzione, ma sotto l’egida dell’efficienza e della gestione serrata dei progetti. Tuttavia, la mancanza di trasparenza del ciclo di progetto sulla carta è una sfida enorme.

Il partner locale, che spesso implementa gran parte delle attività e ha il contatto più stretto con le persone colpite dalla crisi, lavora spesso letteralmente alla cieca. Questa è una misura di potere di cui l’attore dell’INGO che detiene il potere potrebbe non essere nemmeno consapevole. La partecipazione e i partenariati realizzati in questo modo sono ancora legati a rigide strutture di autorità e potere, dove le regole del gioco sono decise completamente da una sola parte. Gli attori programmatici possono rimediare a queste dinamiche, se sono seri riguardo ai loro obblighi. Ispirandomi a Ingold, se la partecipazione deve avere un potenziale trasformativo, deve essere impostata in modo da “trasformare la prospettiva di tutti i partecipanti” (2018, p. 64). Parafrasando Ingold, “i Risultati Finali predefiniti segnano la morte delle interazioni in chiave minore” (ibid: p. 65). C’è un livello politico in questo, perché le linee guida dei donatori decidono che i progetti devono avere Quadri Logici, e l’unica cosa che si può fare è fare pressione sui donatori perché li abbandonino. Tuttavia, ci sono anche modi in cui gli operatori programmatici nelle INGO possono apportare cambiamenti quando agiscono come mediatori tra il donatore e il partner locale o nazionale.
Una giovane operatrice umanitaria che lavorava e viveva nel contesto di crisi mi ha raccontato: “L’altro giorno abbiamo avuto discussioni di focus group con i leader locali. Hanno chiesto di cambiare alcune cose (…). Hanno chiesto ai partner di coinvolgerli mentre facciamo la nostra programmazione. Sì, sentono di avere voce in capitolo, sai. Hanno chiesto se ci fosse un modo per coinvolgere le stesse Persone di Interesse [POC] nella nostra programmazione. E questo è possibile, ma solo per l’ONG locale. Scopri che le ONG internazionali hanno uno standard e non sono flessibili. Diranno: ‘No, no, no, il donatore ha detto che stiamo dando questo e non si cambia’. E tuttavia, letteralmente, per quanto vorremmo fornire i migliori servizi ai nostri POC, scopri che non funziona per loro, e quindi ostacola la nostra collaborazione ma anche il nostro lavoro come soldati semplici sul campo. Quindi, se ci fosse un modo per avere a volte programmi flessibili.” Le persone colpite da una crisi avevano chiesto agli attori locali di essere coinvolte. L’attore locale si sentiva in grado di acconsentire, ma l’INGO che deteneva il contratto con il donatore ha rifiutato, sostenendo che il donatore non avrebbe ottenuto ciò che era stato promesso. Potrebbe essere corretto, o potrebbe essere un modo per scaricare il barile. Tuttavia, in un articolo in cui i ricercatori hanno chiesto a diversi rappresentanti di donatori progressisti sulla flessibilità, è stato detto loro che i donatori erano aperti a una programmazione più flessibile, e persino a finanziamenti più flessibili, ma spesso scoprivano che l’INGO intermediaria non trasmetteva questa flessibilità (Hagelsteen et al., 2022). Ho sperimentato questa mancanza di flessibilità e ho accettato la narrazione nei miei luoghi di lavoro secondo cui, poiché l’INGO è quella con i maggiori rischi legali, finanziari, reputazionali, ecc., l’INGO deve mantenere il controllo. In questo senso, ho visto leader di INGO che sono incumbent del sistema. Quindi, in questo articolo, imploro l’operatore programmatico di essere l’insurgent e di spingere su questi confini.
Abbracciare la Zona di Disagio per un Cambiamento Reale
Questo articolo si inserisce in un contesto di enormi cambiamenti sistematici pianificati per il sistema umanitario, che hanno effettivamente apportato miglioramenti. Tuttavia, gli sforzi verso una maggiore partecipazione e la cosiddetta localizzazione sono ancora legati alle vecchie strutture di potere. Ho suggerito che la via da seguire è l’agenda della Decolonizzazione degli Aiuti. Invece di concentrarmi sui detentori di potere chiari e visibili, mi sono concentrata su attori che detengono un potere più invisibile: noi operatori programmatici nelle INGO, che potremmo non essere nemmeno consapevoli del potere che esercitiamo. Non riusciamo a riconoscere il nostro ruolo e la nostra responsabilità nel cambiare queste dinamiche perché continuiamo a scaricare il barile. Il rapporto “Time to decolonise aid” assegna compiti diversi agli attori umanitari a seconda che provengano da un contesto ex colonizzato o ex colonizzatore. Il compito assegnato agli attori delle società ex colonizzatrici è cambiare le nostre mentalità e percezioni e rompere con i modelli di dominio. Ho sostenuto che gli operatori programmatici hanno una posizione unica come mediatori in questo, se si assumono la responsabilità di apportare i cambiamenti che rientrano nelle loro possibilità di azione.
Cercare di realizzare il cambiamento riconoscendo il proprio ruolo e la propria responsabilità nella dinamica globale è scomodo. È entrare in una zona di disagio. Il cambiamento di percezione è però ciò che serve, se vogliamo iniziare a lavorare in corrispondenza con i partner locali e nazionali, e rompere con l’idea che non abbiano la capacità di essere come noi. Ho quindi cercato di presentare un quadro teorico per “hackerare la mente” e per costruire la nostra capacità di rispondere, perché le relazioni intersoggettive paritarie possono funzionare solo in corrispondenza. Non può essere una partecipazione alla cieca o legata a Risultati Finali prestabiliti. Gli operatori programmatici hanno la posizione per lavorare in piena partecipazione aperta con gli attori locali e nazionali, garantendo piena visibilità, un posto nei processi decisionali e una programmazione il più flessibile possibile. Suggerisco di praticare l’umanitarismo in “chiave minore” per cambiare le logiche e i valori del sistema. È immensamente difficile, ma fortunatamente i vulnerabili, i soggiogati, le persone “là fuori”, sono lì per aiutare. Butler, Gambetti e Sabsay (2016) reinterpretano il quadro della vulnerabilità per liberare i vulnerabili dal bisogno automatico di “protezione”, vedendo la vulnerabilità come una delle condizioni della possibilità di resistenza. Se un sistema deve cambiare, le esperienze, le capacità, le conoscenze delle persone vulnerabili al sistema devono essere la forza trainante di quel cambiamento. Riconosco che è una zona di disagio in cui entrare, ma l’incertezza, è stato sostenuto, è un’altra forza abilitante al cambiamento (Cooper e Pratten, 2014; Whyte, 2009).
Le relazioni di potere diseguali negli aiuti umanitari sono altrove definite come “dominazione terapeutica” (Collinson, 2016, p. 17). L’idea di essere liberi ed uguali e di aiutare gli altri a raggiungere lo stesso obiettivo è una forza motivazionale pervasiva. Tuttavia, questi attori potrebbero confondere le loro posizioni di potere nel sistema con l’essere liberi ed uguali. Ingold scrive lo stesso degli insegnanti nell’educazione, e ripeterò il suo punto nel contesto del lavoro umanitario: solo una pratica umanitaria “che ammette variazioni in chiave minore può permettersi una libertà che sia reale piuttosto che illusoria, e condurci fuori da strutture di autorità che sono manifestamente insostenibili” (2018, p. 37). Il cambiamento, ovviamente, non avverrà mai quando il risultato finale di libertà e uguaglianza è cercato in pratiche di disuguaglianza e basato su idee di libertà che sono, nel migliore dei casi, illusorie.

Fonte: Springer