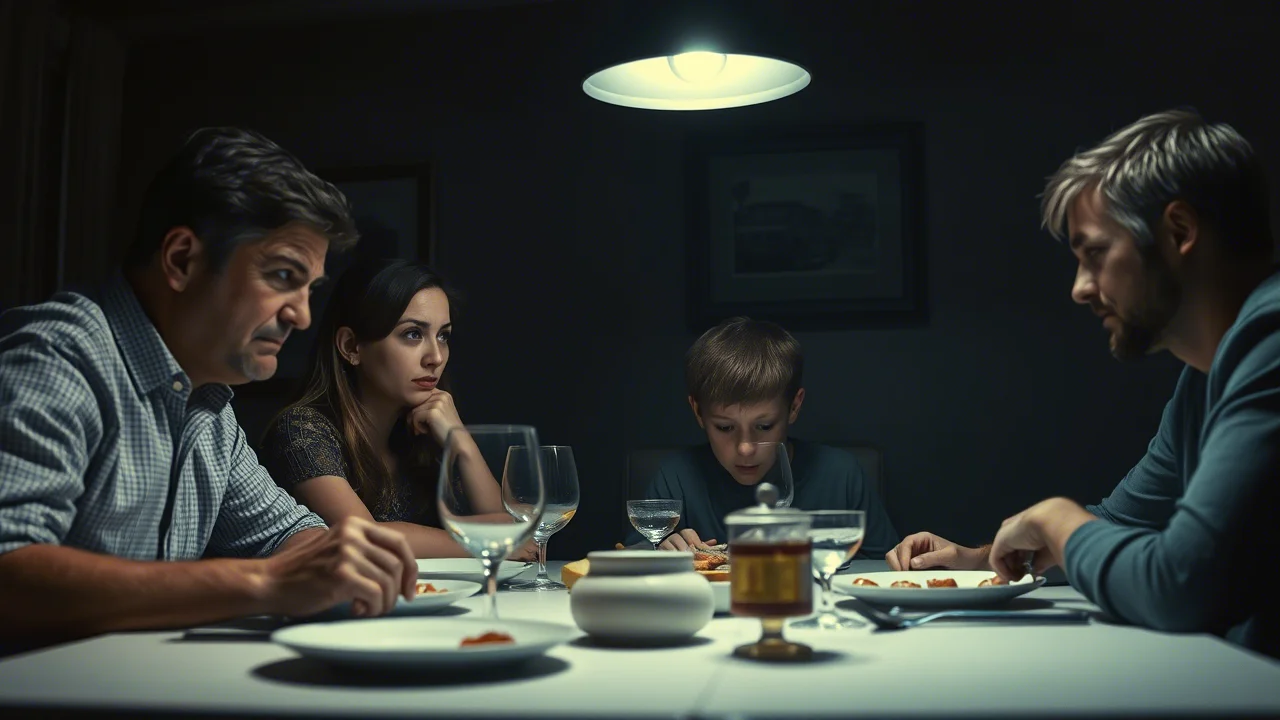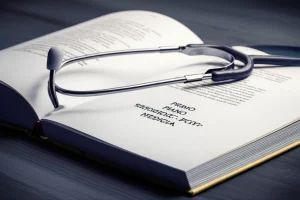Dopo il Lockdown: Come Stanno Davvero le Famiglie con Ragazzi con Disturbi Alimentari?
Ciao a tutti! Ricordate il periodo del lockdown da Covid-19? Sembra un’era fa, eppure le sue onde lunghe si fanno sentire ancora oggi, specialmente sulla salute mentale di bambini e adolescenti. Oggi voglio parlarvi di un aspetto particolare e delicato: come quel periodo ha inciso sui ragazzi con disturbi alimentari restrittivi e sulle loro famiglie. Mi sono imbattuto in uno studio recente che ha cercato di fare luce proprio su questo, confrontando la situazione prima, durante e dopo la pandemia, e i risultati, ve lo dico subito, fanno riflettere parecchio.
L’Ombra Lunga della Pandemia sulla Mente dei Giovani
Non è un segreto che la pandemia e i lockdown abbiano messo a dura prova la psiche di molti, ma i giovani, soprattutto quelli con fragilità preesistenti come i disturbi alimentari (DA), sono stati particolarmente vulnerabili. Immaginate: routine stravolte, niente scuola in presenza, meno contatti sociali, accesso limitato alle cure e ai controlli medici. Uno scenario che, come hanno confermato diverse ricerche, ha spesso portato a un peggioramento o a una ricomparsa dei sintomi dei DA in tantissimi pazienti. L’incertezza generale, poi, è stata come benzina sul fuoco per chi già lottava con questi disturbi, spesso legati proprio alla difficoltà di tollerare l’imprevedibilità. E attenzione, non è finita con la fine delle restrizioni: gli effetti negativi sembrano persistere.
La Famiglia: Scudo o Fattore di Rischio?
Quando si parla di disturbi alimentari, la famiglia gioca un ruolo cruciale. Può essere una risorsa fondamentale nel percorso di guarigione, ma a volte, involontariamente, può contribuire al mantenimento del problema. Cosa è successo durante il lockdown, quando si è stati costretti a una convivenza forzata 24/7? Le testimonianze sono contrastanti. Alcuni studi dicono che i legami si sono rafforzati, altri riportano un aumento dei conflitti, specialmente con gli adolescenti. Pensate allo stress dei genitori, magari preoccupati per il lavoro o per la salute, sommato alla difficoltà di gestire un figlio o una figlia con un DA in un contesto così anomalo e con meno supporti esterni. Insomma, un bel pasticcio.
Lo Studio: Bambini vs Adolescenti, Anoressia vs ARFID
Lo studio che ha attirato la mia attenzione (condotto presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma) ha fatto qualcosa di specifico: ha messo a confronto bambini (6-12 anni) e adolescenti (13-18 anni) con due tipi di disturbi alimentari restrittivi: l’Anoressia Nervosa (AN, nelle sue forme restrittiva e atipica) e il Disturbo Evitante/Restrittivo dell’Assunzione di Cibo (ARFID). L’ARFID è meno conosciuto dell’anoressia, ma è altrettanto serio: chi ne soffre evita o restringe l’assunzione di cibo non per paura di ingrassare, ma per scarso interesse, per le caratteristiche sensoriali del cibo o per paura di conseguenze negative come soffocare o vomitare. I ricercatori hanno analizzato i dati di 640 pazienti visitati tra il 2018 e il 2022, dividendoli in tre gruppi: pre-Covid, durante-Covid e post-Covid. Hanno valutato sia la “psicopatologia alimentare” (cioè la gravità dei sintomi del disturbo) sia il “funzionamento familiare” percepito dai ragazzi e dai loro genitori, usando questionari specifici come il FAD (Family Assessment Device), l’EDI-3 e l’EDQ-C.
Cosa Abbiamo Scoperto? Focus sui Bambini (6-12 anni)
Qui le cose si fanno interessanti. In generale, sia i bambini con AN che quelli con ARFID hanno mostrato, secondo i loro genitori, un peggioramento nel funzionamento familiare nel periodo post-Covid rispetto ai periodi precedenti. Le aree più critiche? Comunicazione, capacità di rispondere emotivamente ai bisogni degli altri (responsività emotiva), coinvolgimento affettivo e controllo dei comportamenti. Sembra che la capacità di risolvere i problemi, invece, sia rimasta più o meno stabile. C’è una differenza però: i genitori di bambini con AN hanno segnalato maggiori difficoltà anche nella gestione dei ruoli familiari nel post-Covid, cosa non emersa per i genitori di bambini con ARFID.
E i bambini stessi? Per quelli con ARFID, non sono emerse differenze significative nella psicopatologia alimentare tra i tre periodi. Ma per i bambini con Anoressia Nervosa, il gruppo valutato durante il Covid ha mostrato punteggi più alti (quindi peggiori) in aree come disturbi affettivi e dell’umore, disturbo ossessivo-compulsivo, pica (ingestione di sostanze non alimentari) e alimentazione selettiva. Sembra quasi che il picco delle difficoltà per i più piccoli con AN sia coinciso proprio con il periodo più intenso della pandemia.

E gli Adolescenti (13-18 anni)? Uno Scenario Diverso
Passando agli adolescenti, il quadro cambia ancora. Per i ragazzi con Anoressia Nervosa, sia loro che i loro genitori concordano nel percepire un funzionamento familiare più problematico nel periodo post-Covid rispetto a prima. Le aree critiche sono simili a quelle dei bambini (comunicazione, ruoli, coinvolgimento affettivo, controllo dei comportamenti), suggerendo che le difficoltà familiari si siano accentuate dopo la fase acuta della pandemia. E la psicopatologia? Qui il picco non è durante, ma dopo il Covid: gli adolescenti con AN valutati nel 2022 hanno riportato sintomi peggiori in quasi tutte le scale psicopatologiche rispetto ai gruppi precedenti (tranne che per perfezionismo e alienazione personale). Sembra che per loro la “riapertura” sia stata più destabilizzante del lockdown stesso.
E gli adolescenti con ARFID? Qui la situazione è quasi spiazzante. I loro genitori segnalano sì qualche difficoltà in più nel post-Covid (in comunicazione, controllo dei comportamenti e funzionamento generale), ma i ragazzi stessi non riportano differenze significative nel funzionamento familiare tra i tre periodi. E nemmeno nella loro psicopatologia alimentare. È come se, dal loro punto di vista, la pandemia non avesse inciso più di tanto, o almeno non in modo misurabile con questi strumenti. Una differenza notevole rispetto ai coetanei con AN.
Mettere Insieme i Pezzi: Cosa Ci Dice Tutto Questo?
Insomma, tirando le somme, questo studio ci dice alcune cose importanti:
- I ragazzi con Anoressia Nervosa sembrano aver sofferto di più, sia a livello di sintomi che di dinamiche familiari, rispetto a quelli con ARFID.
- Il funzionamento familiare, in generale, sembra essere peggiorato nel periodo post-pandemico, suggerendo che lo stress accumulato abbia avuto effetti a lungo termine o che le difficoltà siano emerse con il ritorno a una “nuova normalità”.
- L’età conta: i bambini con AN hanno mostrato il picco di difficoltà psicopatologiche durante il Covid, mentre gli adolescenti con AN lo hanno mostrato dopo.
- L’ARFID sembra avere dinamiche diverse, con un impatto percepito minore sulla famiglia (specialmente dagli adolescenti stessi) e nessuna variazione significativa della psicopatologia nei tre periodi (anche se qui, ammettono i ricercatori, il numero di pazienti con ARFID era minore, quindi serve cautela).
Questi risultati sottolineano quanto sia fondamentale non fare di tutta l’erba un fascio. Parlare genericamente di “disturbi alimentari” o di “impatto del Covid” rischia di farci perdere di vista le specificità legate alla diagnosi e all’età.

Guardare Avanti: Interventi su Misura e Qualche Limite
Cosa ce ne facciamo di queste informazioni? Beh, ci dicono che gli interventi terapeutici devono essere sempre più personalizzati. Per i ragazzi con AN, soprattutto adolescenti, coinvolgere la famiglia sembra cruciale, lavorando su comunicazione, emozioni e strategie di controllo genitoriale. Spesso, purtroppo, si arriva a terapie familiari tardi, e questo può ritardare la guarigione. Per chi soffre di ARFID, servono approcci specifici che tengano conto delle diverse percezioni familiari e delle peculiarità di questo disturbo, che sono diverse da quelle dell’anoressia.
Certo, lo studio ha i suoi limiti, come ammettono gli stessi autori. Non è uno studio longitudinale (non ha seguito gli stessi pazienti nel tempo), ma trasversale (ha confrontato gruppi diversi in momenti diversi). Inoltre, il campione proveniva da un servizio specifico (Day Hospital), il che potrebbe non rappresentare tutti i casi. E, come detto, il gruppo ARFID era più piccolo. Nonostante questo, ci offre spunti preziosi.
La pandemia ha lasciato un segno, non c’è dubbio. E lo ha fatto in modo più profondo su chi era già fragile. Capire come ha inciso sulle diverse forme di disagio e sulle dinamiche familiari è il primo passo per poter offrire un aiuto davvero efficace. Perché ogni storia, ogni diagnosi, ogni famiglia, merita un approccio dedicato.
Fonte: Springer