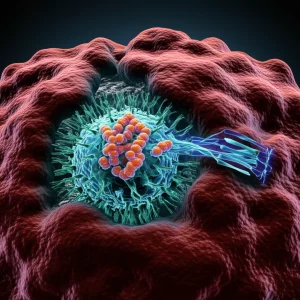COVID nei Campi Profughi Palestinesi: Quando la Comunità Fa la Differenza (e Ci Insegna Qualcosa)
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio un po’ diverso, un viaggio nel cuore di una crisi dentro la crisi: la pandemia di COVID-19 nei campi profughi palestinesi della Cisgiordania. So che abbiamo sentito parlare tanto del COVID, forse troppo, ma questa storia ha qualcosa di speciale, qualcosa che ci tocca da vicino anche se sembra lontana. Parla di resilienza, di solidarietà e del potere incredibile della comunità quando le istituzioni faticano.
Ricordate l’inizio della pandemia? Il panico globale, l’impreparazione che ha colto tutti di sorpresa, persino i paesi più ricchi con i loro sistemi sanitari avanzati. Ora, immaginatevi cosa possa aver significato affrontare tutto questo in un contesto già fragile come quello dei Territori Palestinesi Occupati (OPT), e in particolare nei campi profughi. Qui, il COVID non è stato solo un’emergenza sanitaria, ma un peso che si è aggiunto a livelli multipli di difficoltà preesistenti.
Un Contesto Difficile Già Prima del Virus
Prima di tuffarci nella risposta al COVID, fermiamoci un attimo a capire cosa significa vivere in un campo profughi palestinese in Cisgiordania. Parliamo di circa un quarto degli oltre 870.000 rifugiati palestinesi registrati dall’UNRWA (l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente) che vive in 19 campi.
Cosa significa questo in pratica?
- Sovraffollamento estremo: Case ammassate, pochissima privacy, spazi pubblici quasi inesistenti e aree verdi un miraggio.
- Infrastrutture precarie: Strade strette, sistemi fognari e idrici spesso inadeguati (pensate a quanto sia cruciale l’igiene durante una pandemia!), elettricità a singhiozzo.
- Vulnerabilità socio-economica: Alti tassi di disoccupazione, povertà diffusa, accesso limitato a servizi avanzati.
In un ambiente del genere, capite bene che misure come il “distanziamento fisico” diventano quasi una barzelletta amara. La trasmissione del virus trova terreno fertile, e la vulnerabilità delle persone schizza alle stelle. Aggiungeteci le complicazioni dovute all’occupazione israeliana – frammentazione politica e geografica, difficoltà nel tracciare i casi in certe aree, ostacoli all’arrivo degli aiuti medici – e avrete un quadro della tempesta perfetta.
La Risposta Ufficiale e le Sue Fatiche
Come nel resto del mondo, anche qui si è cercato di rispondere con le misure standard: lockdown, test, tracciamento dei contatti, campagne di vaccinazione (quando i vaccini sono arrivati, con tutte le difficoltà del caso). Il Ministero della Salute Palestinese (MOH), l’OMS, l’UNRWA e diverse ONG locali e internazionali si sono mobilitate.
Però, diciamocelo chiaramente: il sistema sanitario palestinese era già “overstretched”, al limite delle sue capacità, anche prima del COVID. Mancanza di attrezzature, personale insufficiente, risorse limitate. L’UNRWA, fondamentale per l’assistenza sanitaria primaria nei campi, stava già affrontando tagli drastici ai finanziamenti. La pandemia ha messo a nudo tutte queste fragilità.
I servizi sanitari non essenziali, come quelli dentistici o fisioterapici, sono stati sospesi. Si è cercato di garantire le cure per le malattie croniche (consegnando farmaci per tre mesi anziché uno) e le vaccinazioni di routine, ma con mille difficoltà. I centri di quarantena allestiti spesso rimanevano vuoti, perché la gente preferiva restare a casa, tra i propri cari, nonostante i rischi. Le misure imposte dall’alto, come i lockdown totali, erano insostenibili per chi vive alla giornata e ha bisogno di lavorare per sfamare la famiglia.

Il Cuore della Storia: L’Incredibile Mobilitazione della Comunità
Ed è qui che la storia prende una piega affascinante. Di fronte alle difficoltà del sistema ufficiale, è emersa con forza la straordinaria capacità di reazione della comunità locale. Questo è l’elemento che più mi ha colpito leggendo le testimonianze raccolte sul campo: l’impegno comunitario non è stato un contorno, ma un pilastro fondamentale della risposta.
Come si è manifestato?
- Comitati Popolari in prima linea: In ogni campo, i comitati popolari (organismi rappresentativi locali) hanno formato comitati di emergenza multidisciplinari. Pensate a gruppi di volontari – membri dei comitati, giovani dei centri locali, medici del campo, semplici cittadini – che si sono organizzati in sottocomitati: salute, sicurezza, sociale, persino finanziario!
- Azioni concrete e capillari: Questi volontari hanno fatto di tutto: disinfettato strade e case, distribuito medicine, pacchi alimentari e kit igienici (spesso ricevuti come donazioni), aiutato a gestire la logistica per trasferire i malati, chiuso aree pubbliche per limitare gli assembramenti. Hanno persino chiuso gli ingressi dei campi, di loro iniziativa, per cercare di contenere il virus.
- Un ponte tra dentro e fuori: I comitati di emergenza sono diventati il punto di contatto tra il campo e le autorità esterne (governatorati, MOH), comunicando regolarmente la situazione.
- Supporto sanitario “dal basso”: Visto che non c’erano centri test nei campi, all’inizio bisognava andare fuori. Ma poi, grazie alla collaborazione tra comitati, MOH e volontari, si è riusciti a portare i test direttamente nei campi. Medici e infermieri volontari, spesso abitanti del campo stesso, hanno effettuato visite a domicilio, fornito consulenze, seguito i pazienti in isolamento domiciliare.
- Solidarietà diffusa: La gente si aiutava a vicenda. Chi stava meglio economicamente donava, chi aveva competenze mediche si metteva a disposizione. I centri locali (come i centri giovanili o femminili) hanno messo a disposizione i loro spazi, trasformandoli prima in centri di quarantena, poi addirittura in piccoli centri di trattamento improvvisati per chi non poteva uscire dal campo, equipaggiati grazie alle donazioni della comunità stessa (concentratori d’ossigeno, farmaci, strumenti di misurazione).
- Comunicazione e supporto psicologico: Si usavano i social media (soprattutto Facebook) e gli altoparlanti delle moschee per dare informazioni e aggiornamenti. Medici locali creavano video per spiegare come comportarsi e ridurre il panico. Si è cercato di offrire supporto psicologico, anche tramite hotline, per contrastare la paura e l’ansia generate dalla pandemia e dalle fake news.

Le Sfide Non Sono Mancate
Ovviamente, non è stato tutto rose e fiori. Le difficoltà erano enormi:
- Mancanza di piani di emergenza: All’inizio c’era molta confusione, si navigava a vista. Non esisteva un piano strutturato per affrontare una simile catastrofe.
- Carenza cronica di risorse: Mancavano medicine, mascherine, disinfettanti, personale sanitario, posti letto negli ospedali fuori dai campi, ambulanze tempestive. Le donazioni aiutavano, ma spesso non bastavano a coprire i bisogni crescenti.
- Difficoltà a rispettare le misure: Come accennato, il distanziamento sociale in un campo è quasi impossibile. La struttura sociale molto unita, se da un lato favoriva la solidarietà, dall’altro rendeva difficile l’isolamento.
- Sostenibilità a lungo termine: Con il passare del tempo e l’aumento dei casi, anche i volontari iniziavano a infettarsi o a esitare per paura del contagio. Mantenere lo stesso livello di intervento diventava sempre più difficile con risorse limitate e personale che si riduceva.
- Problemi di governance: Chi era responsabile dei centri sanitari improvvisati nei campi? Né il MOH né l’UNRWA ufficialmente. I comitati popolari si sono dovuti far carico di molto, colmando un vuoto istituzionale.

Cosa Ha Funzionato Davvero? I Fattori Chiave
Nonostante tutto, la risposta comunitaria ha avuto un impatto significativo. Cosa l’ha resa possibile ed efficace?
- Consapevolezza e Cooperazione: I residenti, pur tra mille difficoltà, hanno capito la gravità della situazione e, spinti anche dalla paura, hanno cercato di collaborare.
- Fiducia nei Comitati Popolari: Questo è un punto cruciale. Esisteva un rapporto di fiducia preesistente tra la popolazione e i comitati locali. La gente si fidava perché i membri dei comitati erano “uno di loro”, conoscevano la realtà del campo, le sue dinamiche, i bisogni reali. Questa fiducia ha reso le persone più propense a seguire le indicazioni.
- Conoscenza del Contesto: Le iniziative nate dal basso funzionavano perché erano pensate per quel contesto specifico, tenendo conto delle condizioni di vita, delle relazioni sociali, delle risorse disponibili. Sapevano chi aveva più bisogno e come raggiungerlo.
- Reti Sociali e Professionali: Le relazioni personali e professionali dei membri dei comitati (ad esempio, avere un ex capo comitato che ora lavora ai vertici infermieristici) hanno facilitato la comunicazione e l’accesso alle risorse esterne.
- Solidarietà Intracomunitaria: Il tessuto sociale stretto, pur essendo un ostacolo per il distanziamento, è stato una risorsa potentissima per l’aiuto reciproco e l’identificazione delle persone più vulnerabili.
- Adattabilità: La comunità ha dimostrato una grande capacità di adattarsi alla situazione in continua evoluzione, mobilitando le risorse disponibili in modo flessibile ed efficace.
L’esempio del campo di al-Fawwar, dove un centro è stato trasformato in clinica gestita da volontari del campo stesso fuori dagli orari dell’UNRWA, è emblematico di questa incredibile capacità di auto-organizzazione.

Lezioni Apprese: Cosa Ci Portiamo a Casa?
Questa esperienza drammatica, ma anche ricca di umanità, ci lascia delle lezioni preziose, non solo per i campi profughi, ma per la gestione delle emergenze sanitarie ovunque.
1. L’importanza cruciale dell’approccio centrato sulla comunità: Le risposte funzionano meglio quando coinvolgono attivamente le persone, tengono conto dei loro bisogni reali, del loro contesto di vita e si basano sulla fiducia. Non si possono calare soluzioni standard dall’alto senza considerare le specificità locali. Coinvolgere la comunità nei processi decisionali non è un optional, ma una necessità per l’efficacia e l’equità.
2. La necessità di piani di emergenza contestualizzati: Bisogna prepararsi prima, non improvvisare durante la crisi. Ma i piani devono essere flessibili e adattati alle condizioni locali, alle risorse disponibili e alle vulnerabilità specifiche di ogni comunità.
3. Rafforzare le strutture locali: I comitati popolari, i centri comunitari, le reti di volontariato si sono dimostrati attori fondamentali. Bisogna supportarli, rafforzarli, integrarli nei piani di risposta ufficiali, perché sono loro ad avere il polso della situazione sul territorio.
4. Costruire fiducia e comunicazione: La fiducia tra istituzioni e cittadini, e all’interno della comunità stessa, è un capitale sociale inestimabile in tempi di crisi. Va coltivata costantemente attraverso la trasparenza, la comunicazione aperta e il coinvolgimento.
5. Affrontare le disuguaglianze strutturali: La pandemia ha esacerbato vulnerabilità preesistenti legate a povertà, condizioni abitative, accesso all’acqua e ai servizi. Una vera preparazione alle crisi future richiede di affrontare queste disuguaglianze alla radice.
In conclusione, la risposta al COVID-19 nei campi profughi della Cisgiordania ci mostra che, anche nelle condizioni più difficili, la solidarietà e l’organizzazione comunitaria possono fare un’enorme differenza. Il sistema sanitario palestinese, purtroppo, non è riuscito a rispondere adeguatamente ai bisogni, ma la resilienza dimostrata dalle comunità dei campi è un faro di speranza e un modello da cui imparare. Costruire sistemi sanitari più resilienti per il futuro significa anche, e forse soprattutto, costruire sistemi più umani, più vicini alle persone e capaci di valorizzare la forza che viene dal basso.
Fonte: Springer