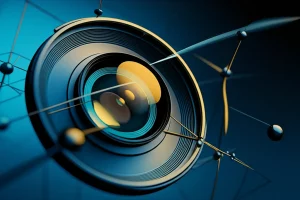Curve, Superfici e i “Modelli Strani”: Una Correzione Che Rivela Nuova Complessità (e Bellezza!)
Amici appassionati di matematica (e non solo!), oggi voglio parlarvi di una cosa che capita anche nelle migliori famiglie, pardon, nelle migliori pubblicazioni scientifiche: le correzioni! Sì, perché la scienza, e la matematica in particolare, è un processo continuo di scoperta, affinamento e, a volte, di ammissione di piccole (o grandi) sviste. E non c’è nulla di male, anzi, è proprio così che si progredisce.
Recentemente, mi sono trovato a dover pubblicare una “corrigenda”, un termine un po’ formale per dire “errata corrige”, riguardo a un mio precedente lavoro intitolato “Curves on surfaces of mixed characteristic”. Il titolo originale potrebbe suonare un po’ ostico, lo capisco, ma cercherò di portarvi con me in questo piccolo viaggio nel cuore della geometria algebrica.
L’Omissione Chiave: I “Modèles Étranges”
Il nocciolo della questione, il “peccato originale” del mio precedente articolo, è stata l’omissione, o meglio, una descrizione non completa, di certi oggetti matematici chiamati “modèles étranges”, che potremmo tradurre simpaticamente come “modelli strani”. Questi modelli, introdotti dal grande matematico Pierre Deligne, giocano un ruolo più sottile e intrigante di quanto avessi inizialmente considerato.
La buona notizia è che la geometria delle curve che stavo studiando rimane sostanzialmente la stessa descritta nel lavoro originale. Quello che cambia, e si arricchisce, è la sua relazione con l’aritmetica sottostante. È come scoprire che un paesaggio che credevi di conoscere a menadito nasconde in realtà sentieri segreti e prospettive inaspettate.
Cosa Sono Questi “Modelli Strani”?
Per farla breve (molto breve, perché la faccenda è complessa!), quando studiamo certi tipi di superfici matematiche, note come quozienti di bi-disco, ci imbattiamo in strutture definite da campi numerici totalmente reali e algebre di quaternioni. Ora, se il campo numerico di base non è quadratico (cioè, in termini tecnici, se la sua dimensione su eQ; è maggiore di 2, diciamo d+2 con d>0), allora entriamo nel reame dei “modèles étranges”.
Questi “modelli strani” hanno la particolarità di rendere più complessa l’interazione tra la geometria e l’aritmetica, specialmente quando passiamo a lavorare in caratteristica p (dove p è un numero primo sufficientemente grande). La decomposizione dei numeri primi in questo campo numerico K continua a creare una dicotomia: da un lato un comportamento simile a quello in caratteristica zero (iperbolicità, per esempio), dall’altro l’apparizione di curve razionali il cui grado cresce con la caratteristica p. Sui “modelli strani”, però, questo fenomeno è più sfumato.
Fogliazioni, Frobenius e le Loro Danze
Per capire meglio, dobbiamo introdurre il concetto di fogliazioni. Immaginatele come delle “direzioni” privilegiate su queste superfici, definite dalle proiezioni sui fattori del bi-disco. Chiamiamole mathcal{F}’ e mathcal{F}”. Poi c’è l’azione di Frobenius, un operatore fondamentale in caratteristica p, che agisce sugli embedding reali del campo K. Le orbite di Frobenius corrispondono ai primi di K che giacciono sopra p.
La correzione principale (Corrigendum 1.1 del testo originale) chiarisce come si comportano queste fogliazioni:
- Caso (A): Se due embedding speciali, τ’ e τ”, appartengono alla stessa orbita di Frobenius, e e+1 è il più piccolo intero tale che Fe+1(τ’) = τ”, allora la fogliazione mathcal{F}’ ha altezza e ma non e+1. In particolare, non è p-chiusa se e solo se F(τ’) = τ”.
- Caso (B): Altrimenti, entrambe le fogliazioni mathcal{F}’ e mathcal{F}” sono fogliazioni di altezza e per ogni e ≥ 0 (il che significa che sono p-chiuse, una proprietà di “buona” integrabilità).
Una fogliazione di altezza 1 è detta p-chiusa. È interessante notare che la probabilità che si verifichi il caso (A) diminuisce all’aumentare di d (la “stranezza” del modello).

Curve Razionali e la Loro Complessità
Quando ci troviamo nel caso (A), la correzione (Corrigendum 1.2) ci dice che esistono curve razionali tangenti alla fogliazione mathcal{F}’, e il loro grado canonico è limitato inferiormente da pe+1/2 e superiormente da un valore che coinvolge la seconda classe di Chern della superficie. Questo è un dettaglio tecnico, ma ci fa capire come la “stranezza” del modello influenzi la presenza e la natura di queste curve.
La Sorpresa delle Curve Invarianti
Forse il fenomeno più interessante legato ai “modelli strani” emerge nel caso (B). Qui (Corrigendum 1.3), scopriamo che esistono dei divisori (curve speciali) lisci e irriducibili, chiamiamoli Δ’ e Δ”, che sono invarianti rispettivamente per mathcal{F}” e mathcal{F}’ e trasversali all’altra fogliazione. Sorprendentemente, queste sono le uniche curve con tali proprietà di invarianza.
E qui c’è il “mea culpa” più specifico: nel lavoro originale (in particolare, un’equazione indicata come (73)), avevo erroneamente concluso che non esistessero tali curve invarianti. L’errore era sottile, una confusione tra l’ordine di annullamento e l’annullamento del termine principale applicando l’operatore di Cartier. Vedete? Il diavolo, anche in matematica, sta nei dettagli! Queste fogliazioni, nel caso (B), hanno dimensione di Kodaira 0, un’altra proprietà importante.
Modelli Strani e Varietà Abeliane “Non Ordinarie”
Un problema di fondo con i “modèles étranges” è che un punto generico su di essi non è rappresentato da una varietà abeliana “ordinaria” (un tipo particolarmente ben comportato di varietà abeliana in caratteristica p). Già in caratteristica zero, la struttura di Hodge associata non è razionale se e solo se abbiamo un modello strano.
Deligne mostra che, dopo una scelta opportuna di un’estensione quadratica immaginaria Z di K, avviene un “miracolo” e si trova una descrizione modulare. Tuttavia, questa descrizione dipende da ulteriori scelte, e queste scelte influenzano la relazione tra la struttura di Hodge e l’azione di Frobenius.
Questo porta a situazioni in cui il punto generico del problema dei moduli associato a un modello strano non è mai ordinario, a meno di condizioni molto specifiche. Per fortuna, esiste un sostituto, il concetto di varietà µ-ordinaria, che è “tanto ordinaria quanto l’azione di Frobenius sulla coomologia cristallina lo permette”. Gran parte di questa nota di correzione serve a tener traccia delle scelte nel problema dei moduli per i “modèles étranges” e a descrivere il risultante luogo µ-ordinario.
Implicazioni sulla Dimensione di Kodaira e Oltre
Le affermazioni sulla dimensione di Kodaira (Corrigendum 1.3 e Remark 4.8 del testo originale) sono piuttosto delicate e richiedono una variante della dimostrazione di Szpiro del teorema di Arakelov. Si scopre che, nel caso (B), la dimensione di Kodaira delle fogliazioni è zero, e i divisori Δ’ e Δ” (definiti da forme modulari di pesi specifici) sono irriducibili.
Un risultato chiave (Claim 4.6 del testo) afferma che se una fogliazione ha dimensione di Kodaira 1, allora, a meno di un “twist” di Frobenius, la fibrazione di Kodaira è iso-trivial (cioè, tutte le fibre sono isomorfe tra loro). Questo, combinato con altre argomentazioni, porta alla conclusione che la dimensione di Kodaira deve essere zero. La dimostrazione di questo fatto è piuttosto generale e ha analogie con la classificazione delle fogliazioni in caratteristica zero.

Conclusioni (Temporanee, Come Sempre in Matematica!)
Cosa ci portiamo a casa da tutta questa storia? Innanzitutto, che anche i percorsi più consolidati della matematica possono nascondere dettagli cruciali. L’introduzione e la corretta considerazione dei “modèles étranges” non stravolge il quadro generale delle curve su queste superfici, ma ne arricchisce enormemente la comprensione aritmetica.
Abbiamo visto come la loro presenza influenzi l’esistenza e le proprietà delle curve razionali, come porti alla luce curve invarianti che prima si pensavano inesistenti, e come complichi la nozione di “ordinarietà” per le varietà abeliane associate.
Questo lavoro di correzione, quindi, non è solo un atto dovuto di precisione scientifica, ma un’opportunità per approfondire e apprezzare ancora di più la bellezza e la complessità nascoste in queste strutture matematiche. E chissà quali altre “stranezze” affascinanti ci riserva il futuro della ricerca!
Fonte: Springer