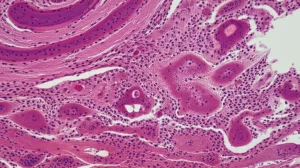Cibi Ultra-Processati e Cuore: Un Decennio Sotto la Lente Rivela Rischi Nascosti
Amici, parliamoci chiaro. Quante volte, presi dalla fretta o dalla voglia di qualcosa di sfizioso, abbiamo allungato la mano verso quella merendina confezionata, quella bibita zuccherina o quel pasto pronto che prometteva di risolvere la cena in cinque minuti? Ecco, questi sono i cosiddetti cibi ultra-processati (UPF), e oggi voglio raccontarvi cosa ho scoperto su di loro, basandomi su una ricerca scientifica che mi ha fatto davvero riflettere. Si tratta dello studio “Ten-year trajectories of ultra-processed food intake and prospective associations with cardiovascular diseases and all-cause mortality: findings from the Whitehall II cohort study”. Un titolone, lo so, ma il succo è importantissimo per la nostra salute.
Cosa sono esattamente questi UPF?
Prima di addentrarci nello studio, capiamo meglio di cosa stiamo parlando. I cibi ultra-processati, secondo la classificazione NOVA (che è un po’ la Bibbia in questo campo), sono formulazioni industriali. Pensate a prodotti realizzati con ingredienti estratti da altri alimenti (come zuccheri, oli, proteine isolate) o sintetizzati in laboratorio. Spesso contengono additivi come coloranti, conservanti, esaltatori di sapidità, dolcificanti artificiali. Esempi? Cereali per la colazione zuccherati, carni processate (würstel, salumi confezionati), bevande dolcificate o light, sostituti della carne a base vegetale super elaborati, e molti piatti pronti. Attenzione, anche alcuni prodotti “plant-based” o cereali che sembrano sani possono rientrare qui se sono molto lavorati e pieni di sodio, zuccheri aggiunti o grassi saturi. Nel Regno Unito, pensate, questi cibi costituiscono oltre il 56% dell’apporto energetico totale degli adulti! Sono spesso poveri di proteine e micronutrienti, ma ricchi di zuccheri aggiunti, sodio, grassi saturi e trans. Insomma, un cocktail non proprio ideale per il nostro organismo.
Lo studio Whitehall II: un’indagine lunga una vita (o quasi)
Lo studio che ho analizzato si è basato sui dati del Whitehall II cohort study, un’indagine britannica che ha coinvolto ben 7.138 partecipanti, per lo più uomini (68.3%), con un’età media iniziale di circa 60 anni. La cosa affascinante è che questi partecipanti sono stati seguiti per un periodo lunghissimo! L’assunzione di cibo è stata valutata in tre momenti diversi nell’arco di un decennio (tra il 1991 e il 2004), usando un questionario dettagliatissimo su 127 alimenti. Poi, i ricercatori hanno monitorato la loro salute cardiovascolare e la mortalità fino al 2019/2021. Parliamo di un follow-up mediano di 16 anni per i nuovi casi di malattie cardiovascolari e 19 anni per la mortalità. Un lavoro immenso!
Utilizzando modelli statistici sofisticati (il “group-based trajectory modelling”, per i più curiosi), hanno identificato tre distinti gruppi basati sul consumo di UPF nel tempo:
- Basso consumo di UPF (circa il 21% dei partecipanti)
- Consumo moderato di UPF (circa il 53% dei partecipanti, la maggioranza)
- Alto consumo di UPF (circa il 26% dei partecipanti)
Un dato interessante è che tutti i gruppi hanno mostrato un leggero aumento nel consumo di UPF nel corso del decennio osservato. Sembra quasi che, col tempo, sia difficile sfuggire a questi prodotti.

I risultati che fanno riflettere: cuore a rischio (ma non solo)
E qui arriviamo al dunque. Cosa è emerso da questo lungo pedinamento alimentare? Preparatevi, perché i dati sono eloquenti.
Il gruppo con il più alto consumo di UPF, rispetto a quello con il consumo più basso, ha mostrato:
- Un rischio maggiore del 23% di sviluppare malattie cardiovascolari (CVD) non fatali.
- Un rischio maggiore del 32% di sviluppare malattie coronariche (CHD) non fatali.
Questi numeri sono già di per sé preoccupanti, ma lo diventano ancora di più se pensiamo che i ricercatori hanno tenuto conto di un sacco di altri fattori: età, sesso, etnia, status socio-economico, educazione, attività fisica, fumo, consumo di alcol, storia familiare di malattie, apporto calorico totale, qualità generale della dieta (zuccheri, sodio, grassi totali) e persino fattori clinici come indice di massa corporea, ipertensione, diabete di tipo II e dislipidemia. Nonostante tutti questi “aggiustamenti”, l’associazione tra alto consumo di UPF e aumento del rischio di queste patologie è rimasta significativa. Questo suggerisce che c’è qualcosa di specifico negli UPF che va oltre il loro semplice profilo nutrizionale.
E la mortalità? Una sorpresa (forse)
Qui la storia si fa un po’ diversa. Sorprendentemente, lo studio non ha trovato associazioni significative tra i diversi livelli di consumo di UPF e il rischio di mortalità per cause cardiovascolari, per malattie coronariche o per tutte le cause. Questo potrebbe sembrare contraddittorio, ma ci sono diverse possibili spiegazioni. Ad esempio, in questa coorte, chi consumava molti UPF tendeva a bere meno alcolici pesanti, e questo potrebbe aver bilanciato in parte i rischi. Inoltre, le differenze metodologiche tra studi, la potenza statistica (magari il numero di decessi non era sufficiente per evidenziare un legame) e le caratteristiche specifiche della popolazione studiata possono influenzare questi risultati. È un campo in cui la ricerca deve ancora scavare a fondo.
Perché gli UPF fanno così male al nostro sistema cardiovascolare?
Le ipotesi sono diverse. Come dicevamo, la scarsa qualità nutrizionale è un primo indiziato: troppi zuccheri, sale, grassi “cattivi”. Ma lo studio suggerisce che non è solo questo. Gli UPF sono spesso iper-energetici, il che può portare a mangiare di più e più velocemente, favorendo l’obesità. E poi c’è l’aspetto del processo di lavorazione stesso: la degradazione della matrice alimentare, la presenza di additivi, le sostanze chimiche rilasciate dagli imballaggi. Tutti questi elementi potrebbero contribuire a infiammazione, disturbi metabolici e, alla fine, a un maggior rischio cardiovascolare. Il fatto che l’associazione rimanesse anche dopo aver considerato l’apporto calorico e i fattori di rischio metabolici preesistenti è un forte indizio che questi “altri fattori” giochino un ruolo cruciale.

Cosa ci portiamo a casa da tutto questo?
Beh, per me il messaggio è forte e chiaro: un consumo elevato e prolungato di cibi ultra-processati sembra essere un fattore di rischio modificabile per le malattie cardiovascolari non fatali. Non si tratta di demonizzare il singolo snack mangiato una volta ogni tanto, ma di riflettere sulle nostre abitudini alimentari nel lungo periodo. Se la nostra dieta è costantemente ricca di questi prodotti, il nostro cuore potrebbe risentirne.
Questo studio, con i suoi punti di forza (come l’uso di misurazioni ripetute dell’assunzione di UPF nel tempo e un lungo follow-up) e le sue inevitabili limitazioni (è uno studio osservazionale, quindi non può stabilire un nesso di causalità diretta, e i dati sull’alimentazione sono auto-riferiti), aggiunge un tassello importante al puzzle. Ci ricorda che la scelta di cosa mettiamo nel piatto ha un impatto profondo e duraturo sulla nostra salute.
Le implicazioni per le politiche sanitarie sono evidenti: servono misure per ridurre il consumo di UPF, come etichette più chiare, restrizioni sul marketing (specialmente verso i bambini) e l’aggiornamento delle linee guida alimentari per tenere conto del grado di processamento degli alimenti.
Certo, la ricerca deve continuare per capire ancora meglio i meccanismi precisi e per confermare questi risultati in popolazioni diverse. Ma nel frattempo, credo che una maggiore consapevolezza e un occhio più critico verso gli scaffali del supermercato possano solo farci bene. Magari, la prossima volta che avremo voglia di uno spuntino, opteremo per qualcosa di meno processato. Il nostro cuore, a lungo termine, potrebbe ringraziarci.
Fonte: Springer