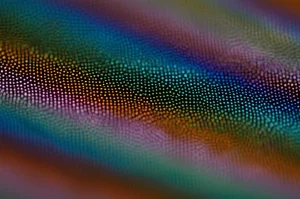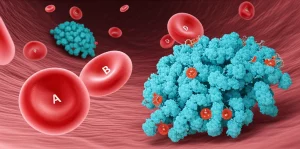Chirurgia Maxillo-Facciale per Classe III: Dormiremo Sonni Tranquilli? Facciamo Chiarezza!
Ciao a tutti! Mettetevi comodi perché oggi affrontiamo un argomento che tocca da vicino chi si occupa di sorrisi e… di sonno! Parliamo di malocclusione scheletrica di Classe III. Detta così suona complicata, ma in parole povere è quando la mandibola è troppo avanti rispetto alla mascella. Una bella sfida per noi ortodontisti, ve lo assicuro, specialmente nelle popolazioni del Sud-Est asiatico dove è più comune.
La Chirurgia Ortognatica: Una Soluzione, Ma Con Quali Effetti Collaterali?
Per correggere questa situazione, spesso la strada maestra è la chirurgia ortognatica. Una volta si faceva quasi solo l’arretramento mandibolare isolato (lo chiameremo MS, da Mandibular Setback). Oggi, però, va molto di moda la chirurgia bimascellare (BS, da Bimaxillary Surgery), che combina l’avanzamento della mascella con l’arretramento della mandibola.
Ora, la domanda che molti si pongono (e che mi sono posto anch’io!) è: cosa succede alle nostre vie aeree quando spostiamo le ossa della faccia? Vecchi studi, basati su radiografie, mostravano una riduzione dello spazio aereo faringeo dopo entrambi i tipi di intervento. Addirittura, uno studio a lungo termine suggeriva che chi faceva solo l’arretramento mandibolare (MS) potesse essere più a rischio di sviluppare apnea ostruttiva del sonno (OSA), perché questo restringimento persisteva nel tempo. Al contrario, con la chirurgia bimascellare (BS), lo spazio sembrava recuperare meglio.
Ma diciamocelo chiaro: una radiografia da svegli e in piedi non ci dice come funzionano davvero le vie aeree mentre dormiamo! Non può diagnosticare l’OSA. L’OSA è una brutta bestia: pause respiratorie o respiro molto ridotto durante il sonno, meno ossigeno che arriva agli organi vitali… insomma, un problema serio che può portare a ipertensione, problemi cardiaci, e altro ancora.
Apnea del Sonno: Un Nemico Silenzioso
L’incidenza dell’OSA varia, e curiosamente, gli asiatici, pur essendo mediamente meno obesi, sembrano soffrirne in forme più severe rispetto ai caucasici. Forse c’entra la conformazione del viso, come una mandibola più indietro (anche se qui parliamo di Classe III, quindi mandibola avanti… un bel paradosso!). Fattori di rischio classici sono l’età, il peso e il sesso (gli uomini sono più colpiti).
Per diagnosticare l’OSA seriamente serve la polisonnografia (PSG), l’esame “gold standard”. Ma è scomoda e costosa. Per fortuna esistono alternative più agili, come gli studi del sonno di Tipo III, fatti a casa (li chiamiamo HST, Home Sleep Test). Sono affidabili? Pare di sì, con buona sensibilità e specificità rispetto alla PSG completa. Questi test misurano parametri come l’indice di eventi respiratori (REI), le desaturazioni di ossigeno (ODI), i livelli medi e minimi di ossigeno nel sangue (SpO2) e la percentuale di russamento.
Cosa Dice la Ricerca Recente? Lo Studio Che Vi Racconto Oggi
Una recente revisione sistematica aveva già suggerito che, in media, questi parametri respiratori nel sonno non cambiavano significativamente dopo chirurgia per Classe III (MS o BS). Però, un piccolo campanello d’allarme c’era: circa il 6% dei pazienti sviluppava OSA post-operatoria, specialmente quelli con grandi arretramenti mandibolari.
Molti studi precedenti erano retrospettivi (guardavano dati passati, con possibili bias) o analizzavano solo un tipo di chirurgia (MS o BS), oppure avevano campioni piccoli senza un calcolo preciso della numerosità necessaria. Insomma, c’era un po’ di incertezza.
Ecco perché mi ha appassionato questo studio prospettico di coorte (seguivano i pazienti nel tempo, da prima a dopo l’intervento) che ha messo a confronto diretto MS e BS, valutando proprio i parametri respiratori nel sonno. L’obiettivo primario era vedere se c’erano differenze significative prima e 6 mesi dopo l’intervento. In più, hanno cercato correlazioni tra questi cambiamenti e le caratteristiche pre-operatorie dei pazienti e hanno confrontato chi aveva avuto miglioramenti, peggioramenti o cambiamenti minimi.

Chi Ha Partecipato e Cosa Hanno Misurato?
Lo studio, condotto alla Mahidol University, ha reclutato 30 pazienti adulti (età media 25 anni, BMI medio normale di 21.9) con malocclusione di Classe III candidati alla chirurgia. Hanno escluso persone con altre deformità, malattie specifiche, o forte obesità. Undici pazienti hanno fatto l’intervento MS (solo arretramento mandibolare, in media di 5.8 mm) e diciannove la BS (avanzamento mascellare medio di 3.2 mm e arretramento mandibolare medio di 7.7 mm).
Prima dell’intervento (T0) e 6 mesi dopo (T1), hanno raccolto:
- Dati demografici
- Punteggio alla Scala di Sonnolenza di Epworth (ESS): misura quanto è probabile addormentarsi in varie situazioni quotidiane.
- Parametri respiratori nel sonno tramite HST (Nox-T3): REI, 3% ODI, SpO2 media, SpO2 minima, percentuale di russamento.
Hanno anche misurato gli spostamenti chirurgici pianificati virtualmente.
I Risultati: Sorprese? Non Proprio, Ma Dettagli Interessanti!
Ebbene, tenetevi forte: non sono state trovate differenze significative nei parametri respiratori del sonno (REI, ODI, SpO2, russamento) né nel punteggio ESS tra prima e dopo l’intervento! Questo sia considerando tutti i pazienti insieme, sia separando i gruppi MS e BS.
Questo risultato è in linea con altre ricerche, suggerendo che forse il corpo si adatta, o che i cambiamenti rientrano in una variabilità fisiologica normale. Certo, contrasta con un paio di studi che invece avevano visto un peggioramento, ma questi riguardavano casi con arretramenti mandibolari molto marcati e avanzamenti mascellari minimi.
Un dato curioso: dopo l’intervento, i pazienti (soprattutto nel gruppo BS) hanno mostrato una riduzione significativa di BMI, circonferenza del collo e della vita. Sappiamo che il peso è un fattore di rischio per l’OSA. Quindi, questa perdita di peso post-operatoria (forse dovuta a cambiamenti nelle abitudini alimentari o al recupero stesso) potrebbe aver “mascherato” o compensato eventuali effetti negativi della chirurgia sulle vie aeree. Una sorta di effetto protettivo inaspettato!
Correlazioni e Differenze: Cosa Ci Dice l’ESS?
Qui arriva una parte secondo me molto intrigante. Hanno scoperto che il punteggio ESS pre-operatorio (cioè quanto sonnolenti si sentivano i pazienti *prima* dell’intervento) era correlato con i cambiamenti *dopo* l’intervento:
- Correlazione positiva con la variazione del REI: chi era più sonnolento prima, tendeva ad avere un aumento (o minor diminuzione) del REI dopo.
- Correlazione negativa con la variazione della SpO2 media: chi era più sonnolento prima, tendeva ad avere una riduzione maggiore dei livelli medi di ossigeno dopo.
- Correlazione positiva con la variazione del russamento: chi era più sonnolento prima, tendeva a russare di più (o a diminuire meno il russamento) dopo.
Questa è una novità! Suggerisce che la sonnolenza diurna pre-operatoria potrebbe essere un campanello d’allarme per identificare chi rischia di più un peggioramento respiratorio nel sonno dopo la chirurgia. Un motivo in più per usare sempre la scala ESS e magari approfondire con una polisonnografia chi ha punteggi alti!

Altra cosa: nessuna differenza significativa tra uomini e donne nei cambiamenti dei parametri respiratori post-chirurgia. Sappiamo che l’OSA è più comune negli uomini, ma questo risultato ci ricorda di non abbassare la guardia con le pazienti donne.
Miglioramenti, Peggioramenti e Stabilità: Chi Cambia Davvero?
Hanno poi diviso i pazienti in tre gruppi in base alla variazione del REI: miglioramento significativo (ΔREI ≤ -2.5 eventi/ora), peggioramento significativo (ΔREI ≥ 2.5) e cambiamento non significativo. L’unica differenza trovata tra questi gruppi era il REI pre-operatorio: chi aveva un REI iniziale più alto tendeva ad avere una riduzione maggiore dopo l’intervento (il gruppo con miglioramento significativo aveva un REI medio pre-op di 6.2, contro 2.6 del gruppo stabile). Questo ha senso: chi parte da una situazione peggiore ha più “margine” per migliorare. Potrebbe anche entrarci la variabilità notte-per-notte dell’apnea, che è un fattore noto.
Non hanno invece trovato differenze significative tra i gruppi per quanto riguarda l’entità degli spostamenti chirurgici o altri parametri pre-operatori, né quando hanno fatto la stessa analisi basandosi sulle variazioni dell’ODI.
Perché Questi Risultati? Limiti e Prospettive Future
Come mai, in generale, non si vedono grandi cambiamenti? Le ipotesi sono diverse:
- I pazienti con Classe III potrebbero avere inizialmente vie aeree più ampie.
- Ci potrebbero essere adattamenti biologici post-operatori (es. spostamento dell’osso ioide, cambiamento della postura della testa) che compensano la riduzione dello spazio.
- L’effetto benefico della perdita di peso osservata.
Ovviamente, questo studio ha i suoi limiti:
- Campione giovane e non obeso: i risultati potrebbero non valere per persone più anziane o in sovrappeso.
- Uso dell’HST (Tipo III) invece della PSG (Tipo I): potrebbe sottostimare leggermente gli eventi.
- Misurazioni basate su piani chirurgici virtuali, non sugli esiti reali (anche se studi precedenti dicono che sono simili).
- Follow-up a 6 mesi: cosa succede a lungo termine?
Servono quindi studi futuri su popolazioni diverse (altre etnie, età, BMI), magari usando la PSG completa e con follow-up più lunghi.
In Conclusione: Cosa Mi Porto a Casa da Questo Studio?
La faccio breve: per pazienti giovani, non obesi, con malocclusione di Classe III, sembra che la chirurgia ortognatica (sia MS che BS, almeno con gli spostamenti medi visti qui) non abbia un impatto negativo significativo sui parametri respiratori legati al sonno a 6 mesi. Anzi, la perdita di peso associata potrebbe addirittura aiutare.
Il dato chiave, però, è la correlazione con la sonnolenza pre-operatoria (ESS). Questo ci dà uno strumento semplice per individuare i pazienti potenzialmente più a rischio di peggioramenti e che meritano forse un monitoraggio più attento. E ricordiamoci che chi parte da un REI più alto, ha più probabilità di vedere un miglioramento.
Insomma, la chirurgia rimane un’opzione valida, ma come sempre, va valutato caso per caso, tenendo d’occhio anche… come dormiamo!
Fonte: Springer