Il Segreto Nascosto tra Vista ed Emozioni: Nuove Luci sull’Autismo in Età Scolare
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cervello umano, un universo complesso e ancora pieno di misteri. In particolare, ci tufferemo nel mondo dell’autismo (ASD), una condizione dello sviluppo neurologico che si manifesta in modi incredibilmente diversi da persona a persona. Questa grande variabilità è una delle sfide più grandi, sia per la ricerca che per trovare interventi efficaci.
Ecco perché mi sono appassionato a cercare dei “marcatori” nel cervello, delle specie di firme neurali, che possano aiutarci a capire meglio cosa c’è dietro le diverse sfumature dell’autismo. L’idea è che se capiamo meglio i circuiti cerebrali coinvolti, potremmo un giorno sviluppare approcci più personalizzati.
Cosa abbiamo cercato esattamente?
Nel nostro studio, ci siamo concentrati sui bambini in età scolare (tra gli 8 e i 12 anni). Abbiamo coinvolto un gruppo speciale: bambini con una storia familiare di autismo (li chiamiamo ad “alto rischio familiare” o HL), perché sappiamo che l’autismo ha una forte componente ereditaria, e un gruppo di controllo senza questa familiarità (a “basso rischio” o LL). In totale, abbiamo lavorato con 97 bambini fantastici.
Il nostro obiettivo era esplorare le connessioni funzionali nel cervello a riposo. Immaginate le diverse aree del cervello come città e le connessioni funzionali come le autostrade che le collegano. Volevamo vedere se l’efficienza e la “forza” di queste autostrade fossero collegate a specifici comportamenti. Non solo i sintomi principali dell’autismo, come le difficoltà nell’interazione sociale (che chiamiamo “social affect” o SA) e i comportamenti ristretti e ripetitivi (RRB), ma anche altri aspetti spesso associati, come:
- Ansia generalizzata
- Difficoltà di attenzione
- Coordinazione motoria
- Capacità di ragionamento logico (matrix reasoning)
Perché considerare anche questi altri comportamenti? Perché l’autismo è complesso e queste caratteristiche contribuiscono alla grande eterogeneità che osserviamo. Volevamo isolare le connessioni cerebrali specificamente legate ai sintomi nucleari dell’autismo, tenendo conto di tutto il resto.
Come abbiamo fatto?
Abbiamo usato una tecnica chiamata risonanza magnetica funzionale a riposo (resting-state fMRI). In pratica, mentre i bambini erano tranquilli nello scanner (abbiamo fatto un training specifico per aiutarli a stare fermi!), abbiamo “fotografato” l’attività spontanea del loro cervello. Questo ci permette di vedere quali aree cerebrali tendono ad attivarsi insieme, formando delle reti funzionali.
Per analizzare questa enorme quantità di dati (parliamo di migliaia di connessioni tra piccole regioni cerebrali!), abbiamo usato un metodo statistico avanzato chiamato Enrichment Analysis (EA). È un approccio “data-driven”, cioè guidato dai dati stessi, che ci aiuta a identificare quali *reti* cerebrali (insiemi di aree che lavorano insieme) mostrano connessioni associate ai comportamenti che ci interessano, senza dover testare ogni singola connessione una per una, rischiando di trovare risultati casuali. Abbiamo cercato associazioni robuste, confermate da diverse varianti di questo metodo statistico.
La Grande Rivelazione: Rete Visiva e Rete di Salienza Protagoniste
E qui arriva la parte più emozionante! Dopo aver analizzato tutti i dati e tenuto conto di tutti i comportamenti associati, è emerso un risultato chiaro e significativo: la connettività funzionale tra la rete visiva (VIS) e la rete di salienza (SAL) era associata in modo specifico ai punteggi di social affect (SA).

Ma cosa significa esattamente? Abbiamo scoperto che una connettività più forte tra queste due reti era associata a maggiori difficoltà nell’area socio-affettiva (punteggi SA più alti all’ADOS-2, uno strumento diagnostico standard). In altre parole, più queste due reti “parlavano” tra loro, più emergevano tratti legati alle difficoltà sociali tipiche dell’autismo.
Questo risultato è stato robusto: è rimasto valido anche dopo aver escluso i pochi bambini che sembravano assonnati durante la scansione (sappiamo che sonno e veglia modificano le connessioni cerebrali). È interessante notare che, a livello di gruppo, la connessione tra VIS e SAL è generalmente debole. Tuttavia, nei bambini del nostro campione con punteggi SA da moderati ad alti, questa connessione sembrava essere particolarmente “rinforzata”, suggerendo un funzionamento peculiare in presenza di difficoltà sociali, anche al di là di una diagnosi formale di ASD.
Cosa significa questa connessione?
Questa scoperta non arriva dal nulla. Già studi precedenti, anche nel nostro stesso gruppo di bambini seguiti fin da piccolissimi (nell’ambito del progetto Infant Brain Imaging Study – IBIS), avevano puntato i riflettori sul sistema visivo. Avevamo visto differenze nello sviluppo della corteccia [7] e delle fibre nervose [59, 60] nelle aree visive nei neonati che poi ricevevano una diagnosi di ASD. Queste differenze erano collegate a come i bambini orientavano lo sguardo [37] e alla familiarità per l’autismo [17].
L’ipotesi che sta prendendo forma è affascinante: differenze precoci nello sviluppo del sistema visivo, legate a una maggiore predisposizione genetica all’autismo, potrebbero innescare una sorta di “cascata” nello sviluppo cervello-comportamento fin dai primi mesi di vita, portando poi all’emergere dei tratti autistici [17, 63]. I nostri nuovi risultati che legano la connessione tra vista (VIS) ed “emozioni/rilevanza” (SAL) ai comportamenti sociali si inseriscono perfettamente in questo quadro. Suggeriscono che le difficoltà sociali nell’autismo potrebbero avere radici in un modo atipico di processare le informazioni sensoriali, in particolare quelle visive, fin dall’inizio [63, 64, 65].
Altri ricercatori [22, 27] hanno trovato risultati simili in campioni che includevano adolescenti e adulti, suggerendo che questa connessione VIS-SAL potrebbe essere importante per le difficoltà sociali autistiche lungo tutto l’arco della vita. In particolare, uno studio recente [27] ha riportato proprio che una connettività VIS-SAL più forte era correlata a maggiori difficoltà sociali misurate con l’ADOS, un risultato incredibilmente simile al nostro, nonostante piccole differenze nei metodi di analisi.
E gli altri comportamenti e reti?
Ci siamo chiesti se questa connessione VIS-SAL fosse legata anche ai comportamenti ristretti e ripetitivi (RRB). Abbiamo trovato qualche indizio (un “trend”), ma l’associazione non era così forte e chiara come quella con i tratti sociali, specialmente dopo aver escluso i bambini assonnati. Forse i RRB hanno un legame più complesso o diverso con questa connessione, magari una relazione inversa (più RRB, connessione più debole)? Serviranno studi più ampi per capirlo meglio.
Per quanto riguarda gli altri comportamenti che abbiamo misurato (ansia, attenzione, motricità, ragionamento), non abbiamo trovato associazioni robuste con nessuna rete cerebrale specifica, una volta considerati tutti i fattori.

Un’altra sorpresa (o forse no?) è stata l’assenza di un legame forte tra la famosa Default Mode Network (DMN) e i comportamenti misurati in questa fase scolare. La DMN è spesso chiamata in causa negli studi sull’autismo, e anche noi l’avevamo trovata associata a comportamenti sociali precoci [29] e tratti familiari [17] negli stessi bambini quando erano neonati. Perché questa differenza? Le spiegazioni possono essere tante:
- Cambiamenti evolutivi: Forse l’importanza della DMN per certi comportamenti cambia con l’età.
- Stato durante la scansione: Da neonati, i bambini dormivano durante la fMRI, mentre a 8-12 anni erano svegli e fissavano una croce. Sappiamo che lo stato di veglia/sonno e l’avere gli occhi aperti o chiusi influenza molto le connessioni, specialmente quelle che coinvolgono la rete visiva [67]. Questo potrebbe spiegare perché da neonati (dormendo) emergeva di più il legame DMN-VIS, e da svegli (occhi aperti) emerge il legame SAL-VIS.
- Metodologia: Il nostro approccio focalizzato sulle dimensioni comportamentali piuttosto che sulla diagnosi categoriale potrebbe portare a risultati diversi da altri studi.
Guardando Avanti: Cosa ci dice tutto questo?
Il nostro studio, pur con i suoi limiti (campione non enorme, poca diversità etnica, tempo di scansione relativamente breve), aggiunge un tassello importante al puzzle. Ci dice che la connessione tra come vediamo il mondo (VIS) e come ne valutiamo la rilevanza emotiva e comportamentale (SAL) sembra giocare un ruolo chiave nelle differenze individuali nei comportamenti sociali, non solo nei bambini con diagnosi di ASD, ma anche in quelli a rischio familiare che magari mostrano solo alcuni tratti.
Questo approccio, che considera più comportamenti insieme e guarda alle differenze individuali lungo un continuum, sembra potente per scovare queste firme cerebrali. La connessione VIS-SAL potrebbe essere un marcatore interessante, dove una connessione più forte indica maggior rischio di difficoltà sociali, e una più debole (più vicina alla norma) potrebbe rappresentare un fattore di resilienza.
La strada è ancora lunga. Vogliamo continuare a seguire questi bambini, e stiamo già raccogliendo dati su una nuova coorte di neonati a rischio, per tracciare lo sviluppo di queste connessioni fin dall’inizio e capire meglio come le prime esperienze visive e il modo in cui il cervello le elabora possano plasmare lo sviluppo sociale. Capire meglio la rete di salienza stessa, i suoi confini e le sue funzioni precise nell’autismo sarà un altro passo fondamentale.
Insomma, esplorare queste connessioni cerebrali è come decifrare un codice complesso, ma ogni nuova scoperta ci avvicina un po’ di più a comprendere l’unicità di ogni individuo nello spettro autistico e, speriamo, a trovare modi sempre migliori per supportare ciascuno nel suo percorso.
Fonte: Springer
]] SCRIPT>
https://scienzachiara.it/wp-content/uploads/2025/04/230/122_immagine-astratta-fotorealistica-del-cervello-umano-che-mostra-connessioni-luminose-tra-le-aree-visive-nella-parte-posteriore.webp
Immagine astratta fotorealistica del cervello umano che mostra connessioni luminose tra le aree visive nella parte posteriore (lobo occipitale) e le aree della rete di salienza (come l’insula e la corteccia cingolata anteriore). Illuminazione controllata d’effetto, stile fotorealistico high-detail, colori vibranti per le connessioni su sfondo scuro.
Neuroscienze
Scopri come la connettività funzionale tra rete visiva e di salienza nel cervello si lega ai tratti sociali dell’autismo in età scolare. Nuova ricerca.
connettività funzionale, autismo, rete visiva, rete di salienza, cervello, bambini, età scolare, tratti sociali, fMRI, neuroscienze
connessione-visiva-salienza-autismo-bambini
Connettività Visiva-Salienza: Svela i Segreti dell’Autismo
connettività
<
Risultati Sorprendenti: Celastrol Fa la Differenza!
E qui arrivano le notizie entusiasmanti! Il trattamento con Celastrol ha mostrato effetti notevoli:
- Azione Antiossidante e Antinfiammatoria: Il CLS ha aumentato i livelli di glutatione (GSH), una molecola che ci protegge dallo stress ossidativo, e ha ridotto i livelli di malondialdeide (MDA, un indicatore di danno cellulare), interleuchina 6 (IL-6) e interleuchina 1β (IL-1β), che sono molecole infiammatorie. Questo è importantissimo, perché lo stress ossidativo e l’infiammazione cronica possono favorire la crescita del cancro. Al contrario, la Dox da sola ha peggiorato lo stress ossidativo e l’infiammazione!
- Blocco dell’Angiogenesi: Il Celastrol ha inibito la formazione di nuovi vasi sanguigni nel tumore, riducendo l’espressione del gene VEGF (fattore di crescita dell’endotelio vascolare). In pratica, ha cercato di “tagliare i rifornimenti” al tumore. Anche qui, la Dox da sola sembrava addirittura favorire leggermente questo processo, un effetto collaterale indesiderato.
- Colpo al Cuore del Problema (Wnt/β-catenina): Ecco il punto cruciale! Il Celastrol ha significativamente ridotto l’espressione del gene della β-catenina e dei suoi geni bersaglio a valle, come cyclin-D1 (che regola il ciclo cellulare) e survivin (che blocca l’apoptosi). Questo significa che il CLS ha effettivamente interferito con quel percorso di segnalazione impazzito, frenando la proliferazione delle cellule tumorali. Ancora una volta, la Dox da sola non è riuscita a fare altrettanto su questi specifici geni, anzi, sembrava aumentarne l’espressione.
- Induzione dell’Apoptosi: Coerentemente con il blocco della survivina, il CLS ha aumentato l’espressione di proteine pro-apoptotiche come p53 (il famoso “guardiano del genoma”) e la caspasi-3 (un esecutore chiave della morte cellulare). In pratica, ha spinto le cellule tumorali verso l’autodistruzione. Anche la Dox ha mostrato questo effetto, ma la combinazione è stata ancora più potente.
La Combinazione Vincente: CLS + Dox
I risultati più impressionanti sono arrivati dal gruppo che ha ricevuto sia Celastrol che Doxorubicina. Questa combinazione ha mostrato:
- Una riduzione significativamente maggiore del volume e del peso del tumore rispetto ai trattamenti singoli (una regressione dell’82.5% contro il 54.1% del CLS da solo e il 62.5% della Dox da sola).
- Un effetto pro-apoptotico potenziato, con livelli ancora più alti di p53 e caspasi-3.
- La capacità del Celastrol di contrastare gli effetti negativi della Dox, riducendo lo stress ossidativo e l’infiammazione indotti dalla chemioterapia.
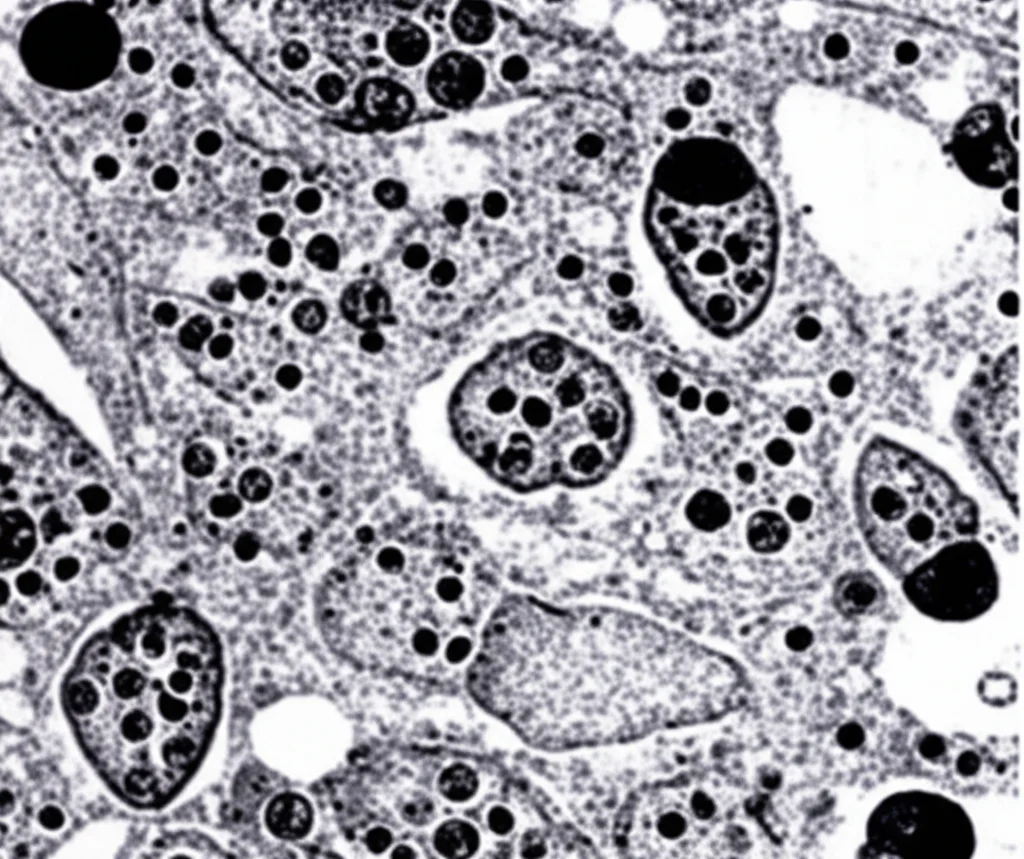
Cosa Significa Tutto Questo?
Beh, per me è una notizia incredibile! Questo studio ci dice che il Celastrol non è solo un composto naturale con generiche proprietà antitumorali, ma agisce colpendo un meccanismo molecolare specifico e cruciale per la crescita di molti tumori: la via di segnalazione Wnt/β-catenina. È come se avessimo scoperto uno degli interruttori che il CLS è in grado di spegnere.
Ma non solo. La scoperta che il Celastrol può lavorare insieme alla Doxorubicina, potenziandone l’efficacia e mitigandone gli effetti collaterali, apre scenari davvero promettenti. Potremmo immaginare, in futuro, terapie combinate che siano più potenti contro il cancro e, allo stesso tempo, più tollerabili per i pazienti.
Ovviamente, siamo ancora nel campo della ricerca pre-clinica (sui topi), e la strada per arrivare a terapie per l’uomo è ancora lunga e richiede ulteriori studi approfonditi. Ma i risultati sono incoraggianti e ci spingono a continuare a esplorare il potenziale nascosto nel cuore della natura. Il Celastrol ci ricorda che, a volte, le soluzioni più innovative possono arrivare da fonti antiche e inaspettate. Continuiamo a seguire questa pista, perché la lotta contro il cancro merita ogni nostro sforzo!
Fonte: Springer







