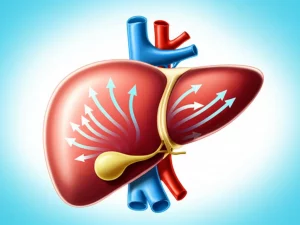Svelati i Segreti della Mortalità Aviaria in Colombia: Un Viaggio di 19 Anni e Uno Sguardo al Futuro
Amici appassionati di natura e scienza, oggi voglio portarvi con me in un’indagine affascinante, quasi un giallo naturalistico, che ci porta dritti nel cuore pulsante della biodiversità mondiale: la Colombia. Immaginate un paese che è un vero e proprio scrigno di tesori alati, con il maggior numero di specie di uccelli al mondo. Un paradiso, vero? Eppure, anche in paradiso, ci sono ombre. E noi, un team di ricercatori appassionati, abbiamo deciso di accendere una luce su una di queste ombre: la mortalità degli uccelli selvatici.
Perché studiare la morte degli uccelli? Sembra macabro, ma è fondamentale!
Vi chiederete: perché dedicare tempo ed energie a capire perché muoiono gli uccelli selvatici? Beh, la risposta è più complessa e importante di quanto sembri. Questi splendidi animali non sono solo belli da vedere e da ascoltare; svolgono ruoli cruciali nei nostri ecosistemi. Pensate alla dispersione dei semi, all’impollinazione, al controllo degli insetti e persino alla “pulizia” dell’ambiente decomponendo le carcasse. La loro salute è, in un certo senso, la salute del pianeta.
Inoltre, l’interazione tra uccelli selvatici ed esseri umani è diventata un tema caldo, soprattutto con l’emergere di malattie zoonotiche (quelle che passano dagli animali all’uomo, come l’influenza aviaria o, per fare un esempio più recente che tutti conosciamo, il SARS-CoV-2). Attività umane come l’urbanizzazione selvaggia e il tristemente noto commercio illegale di animali stanno stravolgendo gli equilibri naturali, costringendo molti uccelli a vivere e riprodursi in condizioni tutt’altro che ideali, rendendoli più vulnerabili alle malattie.
Ecco perché capire le cause di mortalità, le dinamiche temporali e magari riuscire a prevedere futuri focolai è essenziale. È come avere un sistema di allerta precoce per la conservazione delle specie e, indirettamente, per la nostra stessa salute.
La nostra “scena del crimine”: il Laboratorio di Patologia Aviaria (LPA)
Per quasi due decenni, dal 2004 al 2023, il Laboratorio di Patologia Aviaria (LPA) dell’Universidad Nacional de Colombia è stato il nostro quartier generale. Immaginatelo come un centro di investigazione scientifica dove arrivano “casi” da tutto il paese, soprattutto dalla Savana di Bogotà, un’area ecologicamente strategica e ricca di biodiversità aviaria, ma anche, purtroppo, epicentro del traffico di uccelli.
Abbiamo analizzato ben 726 uccelli selvatici, appartenenti a 100 generi diversi e 20 ordini. Un campione davvero significativo! Tra i più “frequenti” nei nostri registri, ahimè, ci sono stati i Psittaciformi (i pappagalli, per intenderci), che costituivano il 27.5% dei casi, e gli Strigiformi (gufi e civette) con il 19.8%.
Un dato che ci ha colpito è che gli adulti sono risultati i più colpiti (70.6%), con una probabilità di morte quasi doppia rispetto ai giovani. E i pulli (i piccolissimi appena usciti dall’uovo)? Anche loro, se confrontati con i giovani un po’ più cresciuti, hanno mostrato una vulnerabilità maggiore alle infezioni.

Il “killer” principale: le malattie infettive
E qui arriviamo al nocciolo della questione: cosa uccide questi splendidi animali? Nel nostro studio, la stragrande maggioranza dei casi (il 63.2%) è stata diagnosticata con malattie infettive. Tra queste, le infezioni batteriche hanno fatto la parte del leone (35.6%), seguite da coinfezioni (batteri più parassiti, o funghi, o virus), infezioni parassitarie, virali e fungine. Pensate che in molti casi di infezione batterica, l’agente eziologico specifico non è stato determinato, ma il quadro generale mostrava un coinvolgimento sistemico, cioè di tutto l’organismo.
Tra i virus, il vaiolo aviario è stato uno dei protagonisti, mentre tra i funghi, lesioni compatibili con Aspergillus e Candida sono state riscontrate in quasi la metà dei casi fungini, causando spesso gravi polmoniti croniche o problemi all’apparato digerente superiore.
Le malattie non infettive, invece, rappresentavano il 22.0% dei casi e includevano problemi metabolico-nutrizionali (carenze vitaminiche, disidratazione, fegato grasso – spesso riscontrate nei Psittaciformi), traumi con emorragie multiorgano (frequenti in Strigiformi e Accipitriformi, come i falchi), intossicazioni e, in rari casi, neoplasie (tumori).
Un aspetto interessante è che non abbiamo trovato differenze significative tra maschi e femmine riguardo alla suscettibilità generale a malattie infettive o non infettive, anche se, come vedremo, delle dinamiche specifiche per sesso emergono analizzando i trend temporali.
Questione di tempo: stagionalità e tendenze della mortalità
Analizzando i dati nel corso dei 19 anni, abbiamo notato dei pattern temporali, delle vere e proprie “stagioni calde” per la mortalità. I mesi di febbraio e marzo hanno mostrato un picco significativo, così come settembre, che è risultato il mese con la mortalità più alta in assoluto. Questo andamento si rifletteva anche nelle malattie infettive, particolarmente alte a settembre. Anche le malattie non infettive mostravano una stagionalità, con picchi a giugno e settembre. Dicembre, invece, sembrava essere un mese di “tregua”, con un calo drastico dei decessi.
E se guardiamo ai sessi? Le femmine mostravano un aumento dei decessi a febbraio, mentre i maschi a marzo e settembre. Entrambi i sessi, poi, tendevano ad avere più casi a novembre nel corso degli anni.
La stagionalità variava anche a seconda dell’ordine tassonomico:
- Psittaciformi (pappagalli) e Gruiformi (gru, gallinelle d’acqua): picco a febbraio.
- Columbiformi (piccioni e tortore): picchi a marzo e settembre.
- Passeriformi (i piccoli uccelli canori) e Strigiformi (gufi): picco a settembre.
Questi periodi, non a caso, spesso coincidono con le stagioni migratorie. La Colombia è un crocevia fondamentale per gli uccelli migratori neotropicali, e la migrazione è un periodo stressante che può aumentare la vulnerabilità a malattie, predazione e carenza di cibo. Aggiungiamoci l’impatto umano crescente in queste aree, come l’urbanizzazione e il traffico illegale, e il quadro si fa più chiaro.
Ma c’è un altro dato che ci ha fatto riflettere: analizzando l’andamento generale dei casi, abbiamo osservato un trend di aumento significativo della mortalità a partire dal 2016, con un incremento annuale del 26.8%. Questo potrebbe essere dovuto, in parte, a una maggiore collaborazione con le autorità ambientali e i centri di recupero, che ha portato a un maggior numero di segnalazioni e conferimenti al nostro laboratorio. Prima, molti casi potevano semplicemente passare inosservati. Questo dimostra quanto sia cruciale la cooperazione interistituzionale!

Uno sguardo al futuro: cosa ci dicono i modelli predittivi?
Non ci siamo fermati al passato e al presente. Abbiamo voluto provare a “guardare nella sfera di cristallo” utilizzando modelli statistici chiamati SARIMA. Questi modelli, analizzando le serie storiche dei dati, ci hanno permesso di fare delle previsioni per il 2024. E cosa ci dicono?
Il modello generale prevede un aumento della mortalità complessiva a marzo, luglio e novembre 2024. Nello specifico, si prevede un incremento della mortalità dovuta a malattie infettive a luglio, e un aumento dei casi tra i maschi a settembre. Gli adulti, purtroppo, sembrano essere a rischio per tutto l’anno.
Queste previsioni sono importantissime perché possono aiutare i servizi di sorveglianza e i centri di recupero a prepararsi, a concentrare le risorse e magari a implementare misure preventive mirate nei periodi di maggior rischio.
Cosa c’è dietro questi numeri? Il ruolo dell’uomo e le sfide
È chiaro che la mortalità aviaria è un fenomeno complesso, multifattoriale. Le malattie infettive dominano, e questo è spesso un segnale di allarme legato a condizioni di stress e cattiva gestione, tipiche del traffico illegale di animali: sovraffollamento, scarsa igiene, alimentazione inadeguata. Queste condizioni compromettono il sistema immunitario degli uccelli, rendendoli facili prede per batteri, virus e parassiti.
È interessante notare che i nostri risultati, con una predominanza di malattie infettive, differiscono da studi condotti in Nord America ed Europa, dove traumi (come impatti o ferite da arma da fuoco), intossicazioni o malattie metaboliche hanno un peso maggiore. Questo potrebbe riflettere le diverse pressioni ambientali e antropiche nelle diverse regioni.
Gli ordini più colpiti (Psittaciformi, Strigiformi, Passeriformi) sono anche quelli più diffusi e, purtroppo, più ambiti nel commercio illegale per la loro bellezza o particolarità. Il fatto che la loro mortalità rimanga stazionaria durante i periodi migratori suggerisce che il rischio aumenti a causa di fattori antropici, come le condizioni socio-culturali ed economiche che impattano il loro benessere.
Abbiamo anche osservato che i maschi sembrano essere più colpiti, forse perché le loro dimensioni, il piumaggio colorato e i canti li rendono più attraenti e quindi più vulnerabili alla cattura. Tuttavia, questa è un’interpretazione da prendere con cautela, poiché la suscettibilità alle malattie è influenzata da una miriade di fattori genetici, ambientali ed ecologici.
Limiti e Prospettive: la strada è ancora lunga, ma abbiamo una mappa
Certo, il nostro studio ha dei limiti. Identificare l’esatta causa di ogni singola morte infettiva è difficile senza un supporto finanziario adeguato per test diagnostici avanzati. Inoltre, i dati potrebbero sovrarappresentare malattie croniche, mentre casi acuti con morte immediata potrebbero sfuggirci. E non tutti gli animali morti in natura arrivano a un laboratorio per la diagnosi.
Nonostante ciò, questa ricerca è, a mio avviso, un passo avanti fondamentale. Per la prima volta, abbiamo dati così completi per una regione neotropicale, un vero hotspot di biodiversità. Abbiamo dimostrato che metodi analitici rigorosi, come l’analisi delle serie temporali e i modelli predittivi, possono fornire informazioni cruciali per monitorare la mortalità e sviluppare strategie di sorveglianza e controllo più efficaci.
Cosa proponiamo, quindi?
- Migliorare la raccolta dati: registri medici dettagliati e test diagnostici di routine nei centri di recupero e durante le autopsie.
- Condividere le informazioni: i risultati delle analisi dovrebbero essere condivisi annualmente con le autorità ambientali, la polizia e i ministeri per controlli sul campo più mirati.
- Proposte di mitigazione: sviluppare azioni concrete per affrontare gli impatti antropici significativi, tenendo conto di età, sesso e categorie di malattie.
In conclusione, amici, il nostro viaggio nel mondo della mortalità aviaria in Colombia ci ha insegnato molto. Ci ha mostrato la fragilità di questi esseri meravigliosi, ma anche la potenza della scienza nel fornire strumenti per la loro protezione. La collaborazione tra enti di ricerca, autorità e centri di recupero è la chiave. Solo lavorando insieme potremo sperare di ridurre i rischi e garantire un futuro più sicuro per gli uccelli selvatici, custodi silenziosi della salute del nostro pianeta.
Fonte: Springer