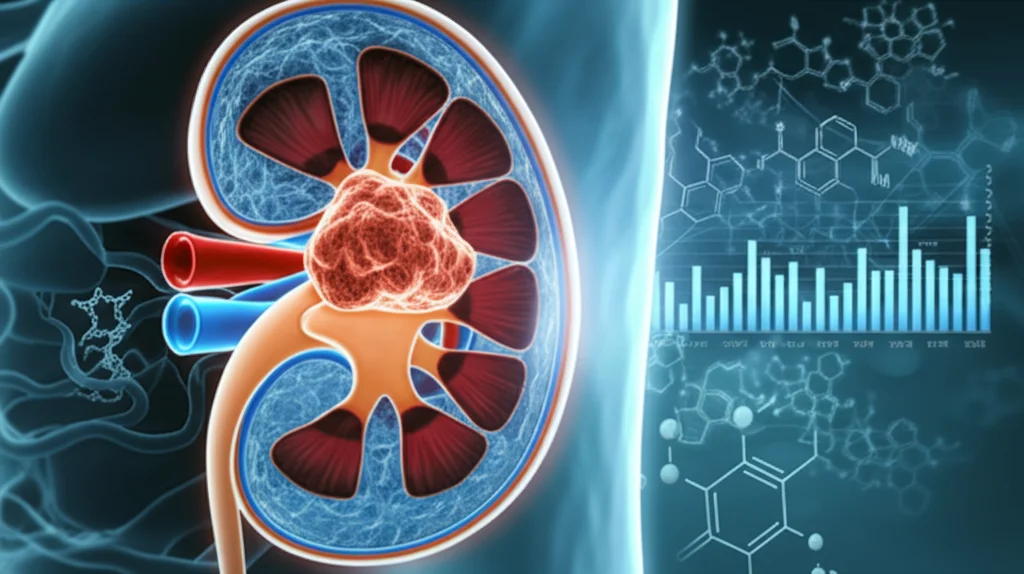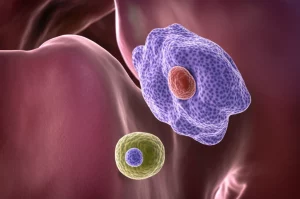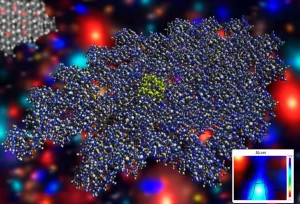Carcinoma Renale con Trombo Venoso: Svelati i Segreti della Risposta all’Axitinib!
Ciao a tutti, appassionati di scienza e progressi medici! Oggi voglio parlarvi di una sfida clinica non da poco nel mondo dell’oncologia: il carcinoma renale a cellule chiare (ccRCC) che sviluppa un trombo tumorale venoso (VTT). Sembra complicato, vero? In pratica, significa che il tumore primario al rene non se ne sta buono buono al suo posto, ma decide di invadere la vena renale e persino la vena cava inferiore, il grosso vaso che riporta il sangue al cuore. Questa situazione riguarda circa il 10-15% dei pazienti con tumore al rene e, capite bene, rende l’intervento chirurgico per rimuovere tutto molto complesso e rischioso.
La Sfida del Trombo Tumorale Venoso (VTT)
Pensate che senza trattamento, la sopravvivenza media per questi pazienti è di soli 5 mesi. L’intervento chirurgico, pur essendo potenzialmente curativo, è un’operazione massiccia, che richiede team multidisciplinari e a volte persino la circolazione extracorporea. La mortalità e le complicanze non sono trascurabili (5-15%), e aumentano con l’estensione del trombo nella vena. Insomma, una bella gatta da pelare.
Per migliorare la situazione, si è pensato: e se provassimo a ridurre le dimensioni del tumore e del trombo *prima* dell’intervento? È qui che entra in gioco la terapia neoadiuvante, cioè un trattamento farmacologico fatto prima della chirurgia.
Lo Studio NAXIVA e l’Axitinib
Uno studio clinico importante in questo campo è stato il NAXIVA (NCT03494816). Si tratta di uno studio di fase II, multicentrico, che ha valutato l’uso dell’axitinib come terapia neoadiuvante. L’axitinib è un farmaco che appartiene alla classe degli inibitori della tirosin-chinasi (TKI) diretti contro il recettore del VEGF (VEGFR). Il VEGF è un fattore di crescita fondamentale per l’angiogenesi, cioè la formazione di nuovi vasi sanguigni che nutrono il tumore. Nel ccRCC, spesso c’è una perdita del gene VHL, che porta a un’iperattivazione della via dell’ipossia e quindi a una maggiore produzione di VEGF. Bloccare questa via con farmaci come l’axitinib è una strategia chiave nel trattamento del tumore al rene avanzato.
Nello studio NAXIVA, dopo 8 settimane di trattamento con axitinib, circa il 35% dei pazienti ha mostrato una riduzione significativa (>30%) della lunghezza del trombo tumorale venoso. Un risultato incoraggiante, perché può portare a interventi chirurgici meno invasivi! Ma… c’è un “ma”. Il restante 65% dei pazienti non ha avuto questo beneficio. E qui sorge la domanda cruciale: perché alcuni pazienti rispondono all’axitinib e altri no? Capirlo è fondamentale per personalizzare le cure e offrire a ciascun paziente il trattamento più efficace.
Alla Ricerca dei Predittori di Risposta: Un’Indagine Approfondita
Ed è proprio qui che entra in gioco la ricerca di cui vi parlo oggi, basata sui dati e sui campioni raccolti durante lo studio NAXIVA. Abbiamo intrapreso un’indagine multiparametrica, un vero lavoro da detective scientifici! Abbiamo analizzato i campioni di tessuto (biopsie prima del trattamento e pezzi chirurgici dopo) e i campioni di sangue raccolti serialmente durante lo studio, usando un arsenale di tecniche:
- Patologia digitale (per analizzare immagini ad alta risoluzione dei tessuti)
- Citometria a flusso (per contare e caratterizzare le cellule immunitarie nel sangue)
- Profilazione delle citochine plasmatiche (per misurare le molecole segnale dell’infiammazione e dell’angiogenesi nel sangue)
- Sequenziamento dell’RNA (RNA-seq) (per vedere quali geni erano attivi nel tumore)
L’obiettivo? Trovare delle caratteristiche, dei biomarcatori, che potessero predire chi avrebbe risposto bene all’axitinib.
Angiogenesi Sotto i Riflettori: Vasi e Fattori di Crescita
Una delle prime cose che abbiamo notato riguardava proprio l’angiogenesi, il bersaglio dell’axitinib. Analizzando i tessuti con la patologia digitale, abbiamo scoperto che i pazienti responder (quelli che hanno risposto bene al farmaco) avevano una densità microvascolare (MVD) di base, cioè prima del trattamento, significativamente più alta rispetto ai non-responder. In pratica, i loro tumori sembravano avere più “tubature” sanguigne all’inizio. E dopo il trattamento con axitinib? Nei responder, questa densità si riduceva significativamente, come ci si aspetterebbe da un farmaco anti-angiogenico efficace. Nei non-responder, invece, la MVD rimaneva bassa e stabile.

Ma non è tutto. Abbiamo guardato anche i livelli dei fattori angiogenici nel sangue. I livelli assoluti di VEGF-A non erano molto diversi tra i gruppi. Tuttavia, guardando la variazione rispetto al basale di ogni paziente, abbiamo visto che nei responder i livelli di VEGF-A aumentavano significativamente verso la fine del trattamento. Ancora più sorprendente è stato il comportamento del PlGF (Placental Growth Factor), un altro fattore angiogenico. I livelli basali erano bassi in tutti, ma nei responder, dopo 3 settimane di axitinib, i livelli di PlGF schizzavano alle stelle (un aumento di circa 7 volte!), per poi tornare bassi dopo l’intervento. Nei non-responder, questo picco non c’era. Analizzando dati di sequenziamento a singola cellula da altri studi, abbiamo visto che mentre il VEGF-A è prodotto principalmente dalle cellule tumorali, il PlGF sembra derivare dalle cellule dello stroma tumorale (miofibroblasti e periciti). Questo suggerisce che una buona risposta all’axitinib è associata a un tumore inizialmente molto vascolarizzato e a una forte “reazione” stromale (aumento di PlGF) durante il trattamento.
Il Ruolo del Sistema Immunitario
Sappiamo che l’immunità gioca un ruolo nel tumore al rene, specialmente con le nuove terapie combinate (immunoterapia + TKI). Quindi, abbiamo esaminato anche le componenti immunitarie. Qui le cose si sono fatte interessanti, quasi al contrario di quanto visto per l’angiogenesi. I non-responder sembravano avere un profilo più “immune-attivo” già al basale. Avevano livelli significativamente più alti nel sangue di una citochina chiamata IL-12p70 prima del trattamento, e di IL-7 dopo il trattamento. L’IL-12 è importante per attivare i linfociti T citotossici, mentre l’IL-7 supporta la proliferazione dei linfociti. Inoltre, c’era una tendenza (anche se non statisticamente significativa) ad avere più linfociti T CD8+ circolanti e più linfociti T CD8+ che esprimevano PD-1 (un marcatore di attivazione/esaurimento) nel tessuto tumorale dei non-responder.
I responder, al contrario, sembravano avere un fenotipo più “immune-basso”. È importante notare che, in questo studio con solo axitinib, non abbiamo osservato cambiamenti significativi nel profilo immunitario indotti dal trattamento stesso. L’axitinib, che ha un bersaglio abbastanza specifico sui recettori VEGF, non sembra di per sé “risvegliare” o modificare in modo massiccio la risposta immunitaria nel microambiente tumorale, almeno non in modo evidente come potrebbero fare altri TKI con un profilo di bersagli più ampio o le immunoterapie.
Leggere i Geni: L’RNA-Seq Rivela Altri Indizi
Ma non ci siamo fermati qui! Siamo andati a “leggere” quali geni erano più o meno attivi nelle biopsie tumorali prima del trattamento, usando l’RNA-seq. Anche qui, abbiamo visto differenze tra responder e non-responder. Curiosamente, molte delle differenze più significative riguardavano geni coinvolti in vie metaboliche e nel trasporto di molecole attraverso le membrane cellulari, in particolare diversi membri della famiglia dei geni SLC (Solute Carrier). Ad esempio, geni come ALDOB, SLC6A19, SLC22A12 e SLCO2A1 erano più espressi nei responder. Alcuni di questi geni, secondo dati pubblici come quelli del Cancer Genome Atlas (TCGA), sono associati a una prognosi migliore nel ccRCC. Questo potrebbe indicare che i tumori che rispondono meglio all’axitinib sono forse biologicamente diversi, magari più differenziati o con un metabolismo particolare che li rende più dipendenti dall’angiogenesi bloccata dal farmaco.
Abbiamo anche confrontato i nostri profili genetici con quelli identificati in grandi studi clinici precedenti su pazienti con tumore renale avanzato (come IMmotion151 e Javelin Renal 101). Ebbene, i risultati “parlano” tra loro! I geni più espressi nei nostri responder NAXIVA erano anche più espressi nei sottogruppi di pazienti definiti “angiogenici” in quegli studi, mentre i geni più espressi nei nostri non-responder si ritrovavano nei sottogruppi “immuno-attivi” o “proliferativi”. Questo rafforza l’idea che esistano davvero dei profili biologici distinti che influenzano la risposta ai diversi tipi di trattamento.

Mettere Tutto Insieme: La Potenza del Machine Learning
A questo punto, avevamo una montagna di dati: misure sui vasi sanguigni, livelli di citochine nel sangue, profili di cellule immunitarie, espressione genica… Come dare un senso a tutto questo e trovare i predittori più potenti? Qui entra in gioco la magia… o meglio, l’intelligenza artificiale! Abbiamo usato un approccio di machine learning (ML). Abbiamo “addestrato” un modello computerizzato a riconoscere i pattern associati alla risposta all’axitinib, usando tutte le caratteristiche misurate *prima* dell’inizio della terapia (modello basale).
Il modello ha funzionato piuttosto bene, raggiungendo un’area sotto la curva (AUC) di 0.868 (un valore vicino a 1 indica un’ottima capacità predittiva). E quali sono state le caratteristiche più importanti selezionate dal modello? Tre in particolare:
- I livelli plasmatici di IL-12p70 (più bassi nei responder)
- I livelli plasmatici di CCL17 (una chemochina, anch’essa più bassa nei responder)
- La densità microvascolare (MVD) nella biopsia (più alta nei responder)
È interessante notare che CCL17 non era emerso chiaramente dalle analisi univariate, ma il modello ML gli ha assegnato un peso elevato, dimostrando l’utilità di questi approcci integrati. I responder tendevano ad avere bassi livelli di IL-12 e CCL17 nel sangue e alta MVD nel tumore.
Ancora più interessante: abbiamo provato a includere nel modello anche i dati raccolti *durante* il trattamento, in particolare le variazioni dei fattori angiogenici nel sangue alla settimana 3 (modello dinamico). Ebbene, la performance predittiva è migliorata ulteriormente, raggiungendo un AUC di 0.945! Oltre a IL-12 e CCL17, il modello dinamico ha dato importanza anche all’aumento precoce (settimana 3) di PlGF e di sTie-2 (un altro fattore legato all’angiogenesi).
Cosa Significa Tutto Questo per i Pazienti?
Tirando le somme, questa ricerca ci dice che la risposta all’axitinib neoadiuvante nel contesto difficile del VTT sembra essere legata a un profilo biologico specifico: un tumore altamente angiogenico (alta MVD basale, forte induzione di PlGF/VEGF-A in trattamento) e relativamente “freddo” dal punto di vista immunitario (bassi livelli di IL-12, CCL17). I non-responder, invece, sembrano avere un profilo più immune-attivo e meno dipendente dall’angiogenesi guidata da VEGF.
Queste scoperte sono importanti? Io credo di sì! Potrebbero aprire la strada a un approccio più personalizzato. Immaginate di poter misurare alcuni di questi marcatori (come MVD sulla biopsia, o IL-12, CCL17 e PlGF nel sangue) prima o subito dopo l’inizio della terapia per prevedere se un paziente beneficerà dell’axitinib (o di farmaci simili). Questo aiuterebbe a decidere se continuare la terapia neoadiuvante, magari guadagnando tempo per un intervento meno rischioso, oppure se procedere direttamente alla chirurgia o considerare altre opzioni terapeutiche (magari combinazioni con immunoterapia, che potrebbero essere più adatte ai pazienti con profilo “immune-caldo”).
Certo, siamo ancora nel campo della ricerca. Questi risultati derivano da uno studio con un numero relativamente piccolo di pazienti (20) e dovranno essere validati in studi più ampi. Inoltre, le terapie stanno evolvendo rapidamente, con l’arrivo di combinazioni TKI+immunoterapia anche in setting neoadiuvanti. Sarà cruciale vedere se questi stessi biomarcatori rimarranno predittivi anche con le nuove terapie, o se ne emergeranno altri.
Ma la strada è tracciata. Capire la biologia alla base della risposta e della resistenza ai farmaci, usando approcci multi-omici e strumenti potenti come il machine learning, è la chiave per migliorare davvero la gestione di condizioni complesse come il carcinoma renale con trombo tumorale venoso. Ogni passo avanti nella comprensione ci avvicina a offrire cure sempre più mirate ed efficaci ai nostri pazienti.
Fonte: Nature Communications