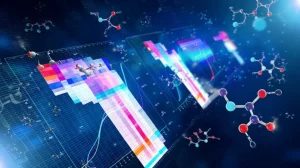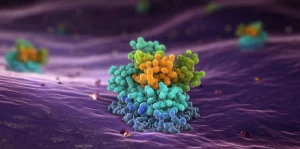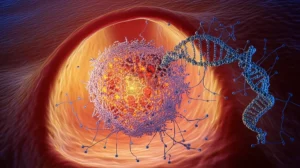Cancro Cervicale a Iquitos: Voci dal Campo per Cambiare Rotta nella Prevenzione
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio un po’ particolare, nel cuore dell’Amazzonia peruviana, precisamente a Iquitos. Parleremo di una sfida sanitaria enorme che affligge questa regione (e non solo): il cancro al collo dell’utero. Pensate che in Perù è una delle principali cause di morte per cancro tra le donne, e nella regione di Loreto, dove si trova Iquitos, la situazione è ancora più critica, con tassi di mortalità 2,6 volte superiori alla media nazionale. Numeri che fanno riflettere, vero?
Ma come si combatte un nemico così insidioso in un contesto complesso come quello di Iquitos, una città raggiungibile solo via fiume o aereo? Per decenni, il Perù si è affidato principalmente al Pap test e all’ispezione visiva con acido acetico (VIA) per lo screening. Tuttavia, questo sistema ha mostrato parecchie crepe, soprattutto in aree remote.
Proprio per capire cosa non funzionava e cosa invece andava bene nel vecchio sistema, è nato uno studio affascinante, parte del più ampio “Proyecto Precáncer”. L’obiettivo? Raccogliere le testimonianze dirette degli operatori sanitari – ostetriche, medici, tecnici di laboratorio – che erano in prima linea nella lotta contro il cancro cervicale con il vecchio metodo Pap/VIA. Volevamo capire le loro difficoltà quotidiane, le barriere incontrate, ma anche le strategie vincenti che mettevano in campo, spesso con poche risorse. Tutto questo per preparare al meglio il terreno per un nuovo approccio, basato sul test molecolare per l’HPV (il papillomavirus umano), molto più efficace e moderno.
Le Sfide del Vecchio Sistema: Cosa ci Hanno Raccontato gli Operatori
Ascoltando le voci di 19 professionisti (12 ostetriche, 4 medici e 3 tecnici di laboratorio), è emerso un quadro chiaro, fatto di luci e ombre. Abbiamo usato un approccio chiamato CFIR (Consolidated Framework for Implementation Research), che ci aiuta a capire tutti i fattori interni a un’organizzazione che possono facilitare o ostacolare un cambiamento. E ragazzi, di cose ne sono emerse!
Mancanza Cronica di Risorse
Una delle lamentele più comuni? La mancanza di materiali e attrezzature basilari. Non parliamo solo di macchinari complessi come quelli per la crioterapia o le pinze da biopsia, che mancavano negli ospedali. A livello primario, negli ambulatori più piccoli e periferici (spesso senza acqua corrente o elettricità costante!), mancavano lettini, lampade per l’esame, tamponi, aceto per la VIA, persino gli speculum della misura giusta! A volte, erano le pazienti stesse a dover portare guanti, antidolorifici o lo speculum. Immaginate la difficoltà di lavorare così.
“A volte la vagina è più larga, più lunga, e lo speculum non ci arriva, e a volte non abbiamo i materiali necessari. Ci danno solo speculum di misura media… Devo chiamare il personale tecnico perché mi facciano luce e io possa raggiungere la cervice.” (Ostetrica di livello primario)
Un Sistema Frammentato: Quando i Dati si Perdono per Strada
Un altro grosso problema era il sistema di registrazione dei dati. Molti centri usavano ancora registri cartacei, per mancanza di computer o internet. Le ostetriche, oberate di moduli da compilare, tenevano spesso registri personali su quaderni per non perdere traccia delle pazienti da richiamare. I dati cartacei venivano poi inviati a un centro per l’inserimento elettronico, ma spesso questo sistema non rifletteva il lavoro svolto, causando frustrazione e demotivazione tra gli operatori, che si vedevano rimproverati per non aver raggiunto gli obiettivi di screening.

Inoltre, i sistemi elettronici esistenti erano descritti come difficili da usare, in continuo cambiamento e non integrati tra loro. Mancava un registro unico e funzionale per sapere chi doveva fare il Pap test, chi richiamare, chi aveva ricevuto un trattamento. Il follow-up si basava sulla memoria e sulla consultazione manuale delle storie cliniche.
“Non abbiamo un registro specifico che mostri chi deve fare il Pap test questo mese, chi dobbiamo seguire. Quello che facciamo è seguire le storie cliniche.” (Ostetrica di livello primario)
Muri Invisibili: La Difficile Comunicazione tra Livelli di Cura
Forse la barriera più sentita era la mancanza di comunicazione tra il livello primario (dove si fa lo screening) e il livello ospedaliero (dove si fa diagnosi e trattamento). Il sistema prevedeva un invio all’ospedale (referral) e un contro-invio (counter-referral) al centro primario con l’esito, ma questo secondo passaggio quasi mai avveniva. Le ostetriche si sentivano responsabili del follow-up, ma non sapevano cosa succedeva alle loro pazienti una volta inviate all’ospedale, se non chiamando direttamente o chiedendo alle pazienti stesse (che non sempre capivano o ricordavano tutto). Lo stesso accadeva tra reparti diversi dello stesso ospedale o quando una paziente veniva inviata a Lima per cure più complesse.
“Una volta che [la paziente] viene inviata [all’ospedale per il trattamento], non vengo informata su cosa sia successo… Ora è una paziente dell’ospedale, ma devo seguirla io per vedere cosa le sta succedendo.” (Ostetrica di livello primario)
Questa mancanza di flusso informativo portava inevitabilmente alla perdita di pazienti lungo il percorso (loss to follow-up).
Personale e Formazione: Una Corsa a Ostacoli
Gli operatori hanno evidenziato la carenza di personale formato, specialmente fuori Lima e in particolare a Loreto. Mancavano patologi per leggere i Pap test (con un solo patologo che leggeva 80 campioni al giorno contro i 120-130 raccolti, l’arretrato si accumulava!), medici formati per eseguire trattamenti specifici come la conizzazione o la LEEP. Se l’unico medico capace andava via, quel servizio si interrompeva. Inoltre, non c’erano risorse (tempo e personale) dedicate formalmente al follow-up delle pazienti inviate altrove.
Cultura Organizzativa e Gerarchie: Ognuno nel Suo “Orto”
È emersa anche una cultura organizzativa piuttosto rigida e gerarchica, dove ogni professionista tendeva a concentrarsi strettamente sui propri compiti specifici, senza una visione d’insieme del percorso della paziente. C’era resistenza, ad esempio, all’idea che le ostetriche, se adeguatamente formate, potessero eseguire procedure come la crioterapia o la colposcopia, viste come esclusiva competenza medica. Questa mentalità “a silos” contribuiva alla frammentazione delle cure.
“Chi dovrebbe essere formato per fare la crioterapia, solo i medici o anche le ostetriche? Non siate sciocchi, solo i medici! Le ostetriche fanno altre cose… Attenetevi a ciò che sapete…” (Medico di livello ospedaliero)
La Forza della Dedizione: Come gli Operatori Aggiravano gli Ostacoli
Nonostante tutte queste difficoltà, quello che mi ha colpito è stata la dedizione e l’ingegnosità di molti operatori. Per superare le barriere comunicative, avevano creato canali informali: telefonate dirette, messaggi su WhatsApp tra colleghi per passarsi informazioni sulle pazienti ed evitare che si perdessero.
“Per facilitare un po’ le cose, abbiamo creato un gruppo WhatsApp… così quando hanno un invio, mi chiamano e dicono: ‘Ti mando una paziente!'” (Ostetrica di livello ospedaliero)
Alcuni si facevano in quattro per accomodare le pazienti, eseguendo Pap test anche fuori dagli orari dedicati, pur di non perdere l’occasione di screening per una donna che magari lavorava e aveva solo quel momento libero. Questa passione e questo impegno sono stati un facilitatore importantissimo!

Da Ascolto a Azione: La Risposta di Proyecto Precáncer
Forte di tutte queste informazioni preziose, Proyecto Precáncer non è rimasto a guardare. Abbiamo usato questi spunti in due modi principali:
- Durante workshop partecipativi (chiamati “group model building”), abbiamo lavorato con tutti gli stakeholder (operatori, autorità sanitarie, ricercatori) per mappare visivamente il vecchio sistema, far capire a tutti come ogni pezzo fosse interconnesso e come la diagnosi precoce fosse inutile senza un trattamento tempestivo. Bisognava vedere il sistema nel suo insieme!
- Abbiamo co-progettato il nuovo intervento basato sul test HPV tenendo conto delle criticità emerse. La novità principale? Spostare gran parte del trattamento (la termoablazione per le lesioni idonee) direttamente al livello primario, spesso nella stessa visita in cui si faceva la valutazione visiva post-test HPV positivo. Questo ha ridotto drasticamente la necessità di invii, contro-invii e il rischio di perdere le pazienti.
Inoltre, per affrontare il caos dei dati, è stato sviluppato un sistema ibrido carta-elettronico, con moduli a triplice copia che soddisfacevano le esigenze burocratiche ma permettevano anche un tracciamento efficace delle pazienti.
Abbiamo anche lavorato per scardinare la cultura gerarchica, coinvolgendo continuamente stakeholder a tutti i livelli, dal nazionale al locale, e identificando “campioni” locali che potessero guidare il cambiamento, assicurando così che l’intervento fosse sentito come proprio e avesse più chance di essere sostenibile.
Primi Successi e Sfide Future
E i risultati? Sono stati incoraggianti! Nei primi 6 mesi, il nuovo programma HPV ha superato l’obiettivo dell’OMS di raggiungere il 70% delle donne eleggibili per lo screening, arrivando a un picco del 128% dell’obiettivo! E, cosa fondamentale, il tasso di perdita al follow-up è crollato dal 66,6% con la VIA al 30,2% con il nuovo sistema HPV. Un passo da gigante!
Certo, le sfide non sono finite. La tecnologia HPV ha i suoi costi (macchinari, materiali di consumo come tamponi e cartucce) e garantirne l’approvvigionamento costante in un contesto come Iquitos non è semplice. Rimane cruciale continuare a lavorare sul rafforzamento del sistema sanitario nel suo complesso, sulla formazione continua del personale e sulla sostenibilità a lungo termine.
Questo studio ci insegna una lezione fondamentale: per implementare con successo interventi sanitari, soprattutto in contesti difficili e con risorse limitate, è imprescindibile ascoltare attentamente chi lavora sul campo ogni giorno. Le loro prospettive, le loro sfide, le loro idee sono la chiave per progettare soluzioni che siano davvero efficaci, appropriate al contesto e sostenibili nel tempo. La strada per eliminare il cancro cervicale è ancora lunga, ma partendo dall’ascolto, abbiamo fatto un bel passo nella giusta direzione a Iquitos.
Fonte: Springer