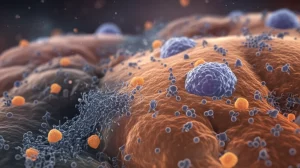Camellia Oleifera: Viaggio nel DNA di un Tesoro Cinese tra Ghiacciai e Montagne
Ciao a tutti, appassionati di natura e misteri evolutivi! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel tempo, alla scoperta di una pianta davvero speciale: la Camellia oleifera. Magari il nome non vi dice molto, ma è una parente stretta della pianta del tè e, soprattutto, è una delle quattro principali colture al mondo per la produzione di olio vegetale, insieme alla palma da olio, all’olivo e al cocco. In Cina, dove è diffusa soprattutto a sud del fiume Yangtze, la sua storia si intreccia con quella dell’uomo da oltre 2300 anni! Pensate, un olio pregiatissimo, ricco di acidi grassi insaturi (oltre il 90%!) e acido oleico (più del 75%), un vero toccasana per la salute.
Ma al di là delle sue incredibili proprietà, c’è una storia ancora più avvincente nascosta nel suo DNA. Come ha fatto questa pianta a diffondersi così tanto? Come ha affrontato i cambiamenti climatici del passato, come le ere glaciali? Quali segreti custodisce il suo patrimonio genetico? Sono domande che mi hanno sempre incuriosito e, finalmente, grazie a studi recenti, iniziamo ad avere delle risposte.
Detective Genetici al Lavoro: SSR e cpDNA
Per svelare questi misteri, noi scienziati abbiamo indossato i panni dei detective genetici. Abbiamo analizzato il DNA di ben 389 esemplari selvatici di Camellia oleifera, raccolti da 33 popolazioni diverse sparse in un’area vastissima della Cina. Come strumenti d’indagine, abbiamo usato due tipi di marcatori genetici:
- Marcatori Microsatelliti (SSR): Immaginateli come delle impronte digitali specifiche presenti nel DNA nucleare (quello che si trova nel nucleo della cellula). Sono ereditati da entrambi i genitori (tramite polline e semi) e tendono a mutare abbastanza velocemente, quindi sono perfetti per studiare le relazioni più recenti tra le popolazioni e la loro struttura genetica attuale. Ne abbiamo usati 20 diversi, sparsi su 15 cromosomi.
- Frammenti di DNA Cloroplastico (cpDNA): I cloroplasti sono gli organelli dove avviene la fotosintesi. Hanno un loro piccolo DNA, che nelle piante come la Camellia viene ereditato quasi esclusivamente per via materna (tramite i semi). Questo DNA muta più lentamente degli SSR ed è quindi ideale per ricostruire la storia evolutiva più antica della specie e le grandi linee di discendenza (aplotipi). Abbiamo analizzato due specifici frammenti (rbcL e psbA–trnH).
Una piccola complicazione: la Camellia oleifera selvatica è spesso esaploide (ha sei copie di ogni cromosoma invece delle solite due!). Questo rende l’analisi genetica, specialmente degli SSR, un po’ più complessa, ma grazie a nuovi metodi statistici (come il modello a doppia riduzione e software specifici come POLYGENE) siamo riusciti a ottenere dati affidabili.
Un Tesoro di Diversità e Due Storie Evolutive
La prima cosa che è saltata all’occhio è stata l’incredibile diversità genetica a livello di specie, sia guardando gli SSR che il cpDNA. Questo non sorprende del tutto: le specie con un areale di distribuzione ampio come la Camellia oleifera tendono ad avere una maggiore variabilità genetica, che è fondamentale per adattarsi a condizioni ambientali diverse e resistere nel tempo. Pensate che abbiamo trovato ben 346 alleli diversi solo nei 20 marcatori SSR e 47 aplotipi distinti nel cpDNA!
Ma qui le cose si fanno davvero intriganti. I due tipi di marcatori ci hanno raccontato storie leggermente diverse, quasi come leggere due capitoli differenti dello stesso libro di storia evolutiva.

La Storia Recente (SSR): Due Grandi Gruppi e l’Ombra dei Ghiacciai
L’analisi degli SSR ha rivelato una struttura geografica abbastanza definita. Le 33 popolazioni si dividono nettamente in due grandi gruppi (o cladi):
- Un gruppo localizzato principalmente nella regione delle montagne Hengduan (HMR) e nel sud-ovest della Cina (Yunnan, Sichuan, Guangxi).
- Un secondo gruppo che occupa le regioni della Cina centrale e orientale (Guizhou, Hunan, Zhejiang).
C’è un certo mescolamento, segno di flusso genico tra le aree, ma la divisione è chiara. Utilizzando sofisticate analisi bayesiane (ABC – Approximate Bayesian Computation), abbiamo stimato che la separazione tra questi due gruppi sia avvenuta circa 17.400 anni fa. Questo periodo coincide quasi perfettamente con l’Ultimo Massimo Glaciale (LGM), il picco dell’ultima era glaciale! Sembra quindi che i cambiamenti climatici glaciali abbiano giocato un ruolo chiave nel plasmare la struttura genetica attuale della specie, forse isolando temporaneamente le popolazioni in diverse aree rifugio.
La Storia Antica (cpDNA): Echi di Sollevamenti Montuosi
Il DNA cloroplastico, invece, ci porta molto più indietro nel tempo e racconta una storia diversa a livello di struttura geografica attuale. Non abbiamo trovato una chiara divisione geografica degli aplotipi (i lignaggi materni). Gli aplotipi più comuni, come H1 e H11, sono diffusi un po’ ovunque! Questo suggerisce che, nel lungo periodo, la dispersione dei semi ha rimescolato abbastanza le carte, oppure che la struttura più antica è stata mascherata da eventi successivi.
Tuttavia, ricostruendo l’albero genealogico degli aplotipi e stimando i tempi di divergenza (usando metodi chiamati BEAST), abbiamo scoperto che le origini più profonde della diversificazione della Camellia oleifera risalgono addirittura al Tardo Miocene (circa 8 milioni di anni fa), con le principali linee (Pool I, II, III) che si sono separate tra i 6 e i 4 milioni di anni fa (Pliocene). Questo periodo coincide in modo impressionante con le fasi più intense del sollevamento delle Montagne Hengduan (HMR) e delle regioni adiacenti! È affascinante pensare che questi imponenti eventi geologici, creando nuove catene montuose, valli e climi, abbiano agito da motore per la diversificazione di questa specie, creando nuove nicchie e forse isolando popolazioni.

Rifugi Glaciali e Autostrade Naturali
Combinando i dati genetici con la modellazione delle nicchie ecologiche (ENM) – una tecnica che predice dove una specie potrebbe vivere in base alle condizioni climatiche – abbiamo potuto ricostruire le aree potenzialmente idonee per la Camellia oleifera durante l’LGM. I risultati confermano l’ipotesi dei rifugi glaciali: durante il picco del freddo, le aree più adatte si concentravano in due zone principali:
- La parte orientale delle Montagne Hengduan (HMR).
- La Cina sud-orientale.
Queste aree hanno agito come “culle” dove la specie ha potuto sopravvivere al freddo glaciale, conservando gran parte della sua diversità genetica. Infatti, alcune delle popolazioni con la maggiore diversità genetica si trovano proprio in queste antiche aree rifugio (come TQYS nelle HMR).
Ma come hanno fatto le popolazioni di questi due rifugi a rimanere in contatto o a ricolonizzare le aree intermedie dopo i ghiacci? Qui entra in gioco un’altra caratteristica geografica chiave: la catena montuosa del Nanling. Estendendosi da ovest a est per oltre 1000 km vicino al Tropico del Cancro, queste montagne sembrano aver funzionato come un corridoio naturale, facilitando il flusso genico (lo scambio di geni tramite polline e semi) tra i rifugi occidentali e orientali. Questo spiegherebbe perché, nonostante la separazione glaciale suggerita dagli SSR, non vediamo una struttura geografica così marcata nel cpDNA (ereditato solo dai semi, che magari viaggiavano meno lontano del polline) e perché la specie nel suo complesso non mostra segni di drastici colli di bottiglia genetici recenti. Sembra aver mantenuto una popolazione complessivamente stabile nel tempo.
Perché Tutto Questo è Importante? Conservazione e Futuro
Capire la storia evolutiva e la struttura genetica della Camellia oleifera non è solo un esercizio accademico affascinante. È fondamentale per la sua conservazione e per il suo miglioramento genetico.
Identificare le popolazioni con la maggiore diversità genetica (come quelle nelle HMR e in alcune aree del sud-ovest) ci dice dove concentrare gli sforzi di conservazione in situ (proteggendo gli habitat naturali) ed ex situ (raccogliendo semi per le banche del germoplasma). Allo stesso tempo, popolazioni magari meno diverse ma presenti ai margini dell’areale (come quelle orientali QT e QL) potrebbero possedere adattamenti unici a condizioni specifiche e meritano anch’esse attenzione.
Questa conoscenza è oro colato per i programmi di breeding: possiamo attingere a questo vasto serbatoio di diversità selvatica per selezionare varietà più resistenti alle malattie, più produttive o con profili di acidi grassi ancora migliori, assicurando un futuro a questa preziosa risorsa.

Il viaggio nel passato della Camellia oleifera ci ha svelato una storia complessa e dinamica, scritta nel suo DNA da montagne che si sollevano, ghiacciai che avanzano e si ritirano, e da un’incessante danza di geni trasportati dal vento e dagli animali. Una storia che continua ancora oggi e che ci insegna quanto sia preziosa la biodiversità e quanto sia importante comprenderla per poterla proteggere.
Fonte: Springer