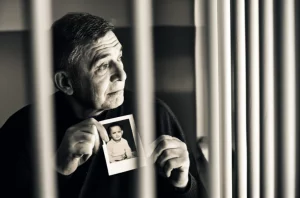Città Verdi o Giungle d’Asfalto? Viaggio nella Biodiversità Urbana tra Italia e Germania
Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore delle nostre città, un luogo che spesso immaginiamo come dominato dal cemento e dall’asfalto, ma che in realtà brulica di vita: la biodiversità urbana. Sì, avete capito bene. Anche tra palazzi e strade, la natura trova il suo spazio, e capire come gestirla, comunicarla e immaginarla per il futuro è diventata una sfida cruciale, soprattutto in Europa.
L’Unione Europea, con la sua strategia per la biodiversità 2030, ha messo nero su bianco un obiettivo ambizioso: chiede a tutte le città con più di 20.000 abitanti di sviluppare dei Piani di Inverdimento Urbano (UGP, Urban Greening Plans, ora chiamati Piani per la Natura Urbana, UNP). L’idea è bellissima: riportare la natura nelle nostre vite, migliorare il nostro benessere fisico e mentale, e contrastare la perdita di spazi verdi. Ma, come spesso accade, tra il dire e il fare… c’è di mezzo un bel po’ di complessità.
Mi sono immerso in uno studio comparativo che ha messo a confronto quattro città, due tedesche (Heidelberg e Hannover) e due italiane (Cesena e Firenze), per capire come se la cavano con questa sfida. Città diverse per dimensioni, ma tutte considerate “impegnate” sul fronte del verde urbano. La domanda che mi ronzava in testa era: come fanno gli attori urbani – amministratori, cittadini, associazioni, imprese – a discutere, costruire e tradurre in progetti concreti gli immaginari futuri legati alla biodiversità urbana? E, spoiler alert, ho scoperto che le dimensioni della città contano meno di quanto si pensi. I veri nodi da sciogliere sono spesso culturali e comunicativi.
Capire la Biodiversità: Non Solo Alberi e Prati
Partiamo dalle basi: cosa intendiamo per biodiversità urbana? Non è solo la varietà di piante e animali, ma anche la diversità degli habitat e, fondamentale, la percezione che noi esseri umani abbiamo di questa relazione con la natura in città. Ed è qui che le cose si complicano.
Analizzando documenti politici e parlando con gli attori locali, è emerso un quadro variegato. C’è chi la vede in modo molto pratico: più alberi, tetti verdi, facciate rinverdite (un approccio quasi “soluzionista”). Altri hanno una visione più ampia, parlando di reti ecologiche, di servizi ecosistemici (l’aria pulita, la regolazione del clima…). Altri ancora la considerano uno strumento di pianificazione per trasformare la città.
Le differenze culturali e i sistemi di pianificazione nazionali giocano un ruolo enorme. In Germania, ad esempio, Heidelberg e Hannover beneficiano di strategie regionali e federali più strutturate e di lunga data. C’è una sensibilità diffusa, supportata da leggi specifiche (come la Legge sul Rafforzamento della Biodiversità nel Baden-Württemberg) e da un concetto radicato come quello della “città compatta” che cerca di bilanciare qualità della vita e natura. Hannover, addirittura “Capitale Federale della Biodiversità” nel 2011, ha una tradizione storica di giardini e parchi (pensate all’Eilenriede, una delle foreste urbane più grandi d’Europa!).
In Italia, la situazione appare più frammentata. A Cesena e Firenze, le strategie regionali menzionano l’inverdimento più in ottica di qualità dell’aria o lotta al cambiamento climatico, ma la biodiversità “pura” è spesso relegata alle aree esterne al tessuto urbano consolidato. A livello locale, si cerca di fare il possibile. Cesena, ad esempio, ha aderito al Green City Accord europeo per cercare fondi, scambiare esperienze e avere indicatori concreti, sentendo un supporto regionale limitato se non per l’aspetto economico. Firenze, pur con una certa sensibilità (il piano urbanistico considera verde pubblico e privato insieme), si scontra con il conservatorismo legato al patrimonio storico (“non roviniamo i giardini storici con nuove specie!”) e con la pressione del turismo di massa che rende difficile trovare spazio per la natura, soprattutto in centro.

Un punto comune, però, è la crescente sensibilità generale verso questi temi, confermata da tutti gli intervistati. Tuttavia, questa sensibilità non sempre si traduce in un impegno politico forte, e la biodiversità finisce spesso per essere messa in secondo piano rispetto ad altre urgenze, come la casa o l’economia. E poi c’è il problema dei dati: raccoglierli è costoso e complesso, soprattutto per le città più piccole, rendendo difficile pianificare azioni basate su evidenze solide.
Comunicare la Biodiversità: Tra Coalizioni e Conflitti
Come si parla di biodiversità urbana nel dibattito pubblico? Qui le differenze tra i due paesi emergono nette. Nelle città italiane, Cesena e Firenze, il dibattito (almeno quello tracciato analizzando i giornali locali) sembra ruotare molto attorno ai processi: ‘partecipazione’, ‘collaborazione intersettoriale’. Nelle città tedesche, Heidelberg e Hannover, si tende a focalizzarsi più sulla sostanza: ‘inverdimento per la biodiversità’, ‘cambiamento climatico’.
In tutti i casi, l’amministrazione pubblica gioca un ruolo centrale nell’abilitare e guidare la discussione. Dopotutto, gran parte degli interventi avviene su suolo pubblico e l’ente locale rappresenta l’interesse collettivo. Questo dà un potenziale enorme per mettere la biodiversità in agenda. Ma emergono anche le criticità.
Spesso, all’interno delle stesse amministrazioni, si soffre dell'”effetto silo”: uffici diversi (urbanistica, ambiente, lavori pubblici) faticano a comunicare e coordinarsi. Lo abbiamo visto a Firenze dall’analisi dei discorsi e lo hanno confermato le interviste a Heidelberg. E così, la biodiversità perde contro questioni percepite come più urgenti: la casa a Heidelberg, la mobilità a Firenze. Temi, diciamocelo, più “facili” da capire e discutere per tutti, cittadini inclusi.
Poi ci sono i conflitti “culturali”: la conservazione del patrimonio storico che frena interventi innovativi (Hannover, Firenze) o la tendenza a vedere il verde solo come misura di adattamento climatico, un “valore aggiunto” a progetti edilizi o infrastrutturali, piuttosto che un valore intrinseco.
E la partecipazione? Nota dolente. L’analisi ha rivelato reazioni conflittuali da parte dei cittadini, spesso riconducibili a sindromi NIMBY (“Not In My Back Yard”). Questo accade soprattutto quando la comunicazione è percepita come top-down e poco trasparente (Heidelberg, Firenze) o quando c’è una scarsa consapevolezza generale sui temi (Cesena). Hannover, con la sua “Alleanza per gli Insetti”, mostra un approccio interessante: comunicazione chiara, un logo comune, un’unione volontaria di attori diversi che diffonde conoscenza e cerca di prevenire i conflitti. Ma anche il conflitto può essere utile: la Consulta per l’Ambiente di Cesena è un esempio di come coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione dei piani.

Insomma, comunicare la biodiversità non è facile. Richiede trasparenza, capacità di ascolto, volontà di superare le barriere interne ed esterne e, forse, anche di accettare e gestire il conflitto come parte del processo.
Immaginare il Futuro: Dai Piani alla Realtà (Spesso Curata)
E alla fine, come si traducono tutte queste discussioni e comprensioni in immaginari futuri e, soprattutto, in piani concreti (gli UGP) e interventi sul territorio? Qui la ricerca ha mostrato che molti piani, pur ambiziosi sulla carta, restano a livello strategico, senza definire chiaramente responsabilità, tempi e risorse.
Le città più piccole faticano a trovare le risorse economiche e umane per redigere piani dettagliati come quelli richiesti dalle linee guida UE. Le città più grandi, pur avendo più mezzi, lottano per integrare questi piani nel quadro urbanistico generale e subiscono la pressione di dover agire “urgentemente”, spesso a scapito di una pianificazione più ponderata e partecipata.
Il concetto stesso di “verde” rischia di diventare vago, quasi un contenitore vuoto buono per ogni narrazione. Spesso, gli immaginari proposti sono idealizzati, non contemplano conflitti o incertezze. E questo rende difficile costruire storyline convincenti per tutti, soprattutto quando i risultati non sono immediati (la natura ha i suoi tempi!).
La comunicazione torna ad essere cruciale. Approcci top-down (Heidelberg) o consultazioni a piano già fatto (come sembra prospettarsi a Firenze) non aiutano a creare quel senso di appartenenza e comprensione necessario. Hannover, pur comunicando molto, non prevede processi partecipativi formalizzati per i piani sul verde, anche se è aperta a idee dai cittadini.
E cosa vediamo poi sul territorio? L’analisi spaziale dei progetti discussi sui giornali e le visite sul campo hanno rivelato una tendenza generale: i progetti “promossi” e meno conflittuali sono spesso grandi aree verdi, magari in periferia, ben distribuite. I progetti “conflittuali” si concentrano invece più in centro, riguardano aree piccole, spesso legati a tagli di alberi o riqualificazioni specifiche. Non sorprende: nel centro denso, i conflitti per l’uso del suolo sono all’ordine del giorno. E, in generale, si tende a preferire forme di verde urbano piuttosto “curate”, esteticamente piacevoli, ma non sempre ottimali dal punto di vista della biodiversità “selvatica”. Ci sono pochi tentativi di gestire attivamente queste aree per incrementarla davvero.

Allora, Cosa Abbiamo Imparato?
Questo viaggio tra Germania e Italia mi ha convinto di una cosa: quando si parla di biodiversità urbana, le dimensioni della città contano meno delle dinamiche culturali e comunicative.
La comprensione del concetto è ancora troppo vaga e astratta per molti. Se da un lato la vaghezza permette ad alcuni attori di giustificare azioni rapide, dall’altro non riesce a “scaldare i cuori” e a convincere della sua necessità profonda. Servono dati migliori e un monitoraggio costante per supportare decisioni basate sull’evidenza, e questo richiede investimenti. Le Regioni, soprattutto in Italia, dovrebbero supportare i Comuni non solo con fondi, ma anche con competenze e trasparenza.
Serve una comunicazione diversa, che non abbia paura del conflitto ma lo usi come momento di confronto, che vada oltre la semplice consultazione e coinvolga davvero i cittadini fin dall’inizio. Creare organismi di mediazione, come la Consulta di Cesena o l’Alleanza di Hannover, può essere una strada. Bisogna sensibilizzare, spiegare, creare un senso di “proprietà” condivisa degli spazi verdi e della natura che ospitano.
Infine, dobbiamo superare la logica degli interventi isolati o del verde come semplice “decorazione” o “soluzione tecnica”. Serve un approccio olistico, multifunzionale, che veda la biodiversità come parte integrante della pianificazione degli spazi aperti, pubblici e privati, riconoscendone il valore intrinseco e il ruolo fondamentale per il nostro futuro.
Non si tratta solo di piantare alberi, ma di coltivare una nuova cultura urbana, un nuovo modo di immaginare e vivere le nostre città in armonia con la natura che, nonostante tutto, continua a farne parte. È una sfida complessa, certo, ma assolutamente affascinante e necessaria.
Fonte: Springer