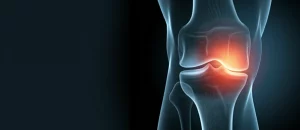Azzardo Morale in Europa: Molto Più Che un’Ossessione Tedesca!
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un concetto che sentiamo spesso nominare quando si discute di economia europea, soprattutto durante le crisi: l’azzardo morale. Sembra una roba tecnica, da economisti in giacca e cravatta, vero? Eppure, vi assicuro che ha un potere politico enorme, quasi subdolo, che influenza le nostre vite più di quanto pensiamo.
L’ombra tedesca sull’azzardo morale
Quando si parla di azzardo morale nell’Unione Europea, il pensiero corre quasi subito alla Germania. È quasi un riflesso condizionato. Si dice che la Germania, con la sua storica avversione all’inflazione e la sua cultura della stabilità (la famosa Stabilitätskultur), sia ossessionata dall’idea che aiutare troppo i paesi in difficoltà (magari quelli del Sud Europa, diciamocelo) li incentivi a comportarsi in modo irresponsabile, a spendere senza ritegno, sapendo che poi “qualcuno” (leggi: i paesi virtuosi del Nord) pagherà il conto.
Questa idea, che suona un po’ come “se ti do l’ombrello, uscirai senza impermeabile sotto il diluvio”, ha plasmato gran parte dell’architettura economica europea. Pensate alle regole ferree del Patto di Stabilità, alla clausola del “no bailout” (che poi, vabbè, è stata interpretata), al divieto di finanziamento monetario da parte della BCE. Tutto nasce, in parte, dalla paura dell’azzardo morale. E durante le crisi finanziarie e del debito sovrano, questa paura è stata usata per giustificare ritardi negli aiuti, austerità pesante, e condizioni molto severe per chi riceveva sostegno.
Ma siamo sicuri che sia *solo* una questione tedesca?
Ecco, qui le cose si fanno interessanti. L’articolo da cui prendo spunto (trovate il link alla fine) mi ha fatto riflettere parecchio. Sostiene, e io sono piuttosto d’accordo, che ridurre tutto all’ “ossessione tedesca” sia una visione parziale. Certo, la Germania ha avuto un ruolo chiave, non lo neghiamo. Ma l’azzardo morale è diventato un concetto così potente perché, in fondo, fa comodo a molti.
Pensateci: l’azzardo morale è difficile da misurare. È più un’ipotesi, un timore basato sull’idea (molto contestata) che siamo tutti attori perfettamente razionali. Eppure, le politiche per contrastarlo (meno reti di sicurezza, più vincoli) hanno costi sociali reali, spesso a svantaggio dei più deboli. Perché allora questo concetto incerto e potenzialmente costoso è così dominante?
Il potere *attraverso* le idee: l’astuzia della Commissione
L’articolo analizza il discorso della Commissione Europea tra il 2007 e il 2022. E cosa scopre? Che la Commissione, l’organo che uno si aspetterebbe più favorevole alla condivisione del rischio e quindi più propenso a *contestare* l’argomento dell’azzardo morale, in realtà lo ha usato strategicamente.
Invece di dire “Ma no, questo azzardo morale non esiste o è sovrastimato!”, la Commissione ha fatto qualcosa di più sottile. Ha detto: “Ok, l’azzardo morale è un problema serio. E sapete qual è il modo migliore per evitarlo? Più Europa! Più centralizzazione delle politiche fiscali, più sorveglianza comune, più poteri a Bruxelles”.

Avete capito il gioco? Hanno preso l’argomento forte dei “falchi” del Nord e lo hanno rigirato a loro vantaggio per spingere verso un’integrazione più profonda, un obiettivo storico della Commissione. Olli Rehn, all’epoca Commissario agli Affari Economici, è stato un maestro in questo. Ha usato la paura dell’azzardo morale per promuovere l’idea degli Eurobond (che chiamava furbescamente “Stability Bond”) e per giustificare un controllo più stretto sui bilanci nazionali da parte della Commissione stessa. In pratica, diceva ai tedeschi: “Volete evitare l’azzardo morale? Bene, allora dovete darci più potere per controllare tutti”. Geniale, no?
Un concetto dai mille volti
La cosa affascinante è che la Commissione non usava nemmeno il concetto di azzardo morale sempre nello stesso modo.
- Quando parlava di banche, l’azzardo morale era visto come un problema di incentivi sbagliati che portavano a rischi eccessivi (colpa del sistema, più che altro). La soluzione? Regole più stringenti e condizioni di “burden sharing” (far pagare anche azionisti e obbligazionisti nei salvataggi).
- Quando parlava di governi, l’azzardo morale diventava quasi un “problema morale” di “free-riding”, cioè approfittarsi della prudenza altrui (colpa degli Stati “cicala”). La soluzione? Più controllo centrale.
- Addirittura, durante la crisi migratoria, Frans Timmermans ha usato l’azzardo morale per descrivere la mancanza di fiducia reciproca tra gli Stati membri!
Questa flessibilità dimostra che l’azzardo morale non era una credenza monolitica e interiorizzata (“power in ideas”), ma uno strumento versatile (“power through ideas”), adattato al contesto e all’obiettivo politico del momento.
Poca contestazione, molta strategia
Un altro dato interessante: nei discorsi analizzati, la Commissione ha contestato apertamente l’argomento dell’azzardo morale solo una volta in 15 anni! Per il resto, lo ha accettato come un dato di fatto, usandolo come premessa per le proprie proposte. Questo non significa che ci fosse un consenso ideologico, ma piuttosto che contestarlo frontalmente era forse controproducente. Era più utile cavalcarlo.

E sapete quando la Commissione ha smesso quasi del tutto di parlare di azzardo morale nei suoi discorsi pubblici? Dopo il 2018. Forse perché, con l’arrivo della crisi COVID-19 e la necessità di risposte comuni e massicce (come il Next Generation EU), l’argomento dell’azzardo morale era diventato meno rilevante o addirittura d’intralcio? Sembra che l’azzardo morale venga tirato fuori dal cassetto quando serve a costruire consenso (o a bloccare proposte sgradite), e rimesso via quando non è più utile.
Cosa ci insegna tutto questo?
Beh, secondo me, ci dice alcune cose importanti:
- L’azzardo morale, pur sembrando un concetto economico neutro, è profondamente politico e normativo. Viene usato per dare giudizi, per distribuire colpe, per giustificare scelte che hanno vincitori e vinti.
- La sua influenza non dipende solo dalla forza dei “potenti” (come la Germania) che lo impongono, ma anche dalla mancanza di contestazione e dall’uso strumentale che ne fanno altri attori, persino quelli che sulla carta dovrebbero contrastarlo. La Commissione, usando l’azzardo morale per i propri fini (più integrazione), ha contribuito a rafforzarne la legittimità.
- Questo ci dà una visione più sfumata delle dinamiche di potere nell’UE. Non è solo una lotta tra Stati creditori e debitori, ma un gioco complesso in cui le istituzioni sovranazionali come la Commissione usano le idee come risorse per perseguire i propri obiettivi strategici.
Insomma, la prossima volta che sentite parlare di “azzardo morale” in Europa, non fermatevi alla solita storia dell’ossessione tedesca. Chiedetevi: chi sta usando questo concetto? E per quale scopo? Potreste scoprire che la realtà è molto più complessa e affascinante di quanto sembri. È una partita a scacchi giocata con le parole, e l’azzardo morale è una pedina molto, molto potente.

Fonte: Springer