Malattie Cardiovascolari: Autovalutazione vs. Dati Assicurativi – Di Chi Fidarsi?
Amici, parliamoci chiaro: quando si tratta della nostra salute, siamo sempre onesti… o meglio, siamo sempre precisi nel riportare le nostre condizioni? È una domanda che mi frulla in testa da un po’, soprattutto quando leggo studi epidemiologici che si basano proprio su quello che noi stessi dichiariamo. E se vi dicessi che c’è un modo per “controllare le carte” e vedere quanto ci azzecchiamo, specialmente quando si parla di bestiacce come le malattie cardiovascolari?
Recentemente, mi sono imbattuto in uno studio affascinante, il LIFE-Adult study, una ricerca tedesca che ha fatto proprio questo: ha messo a confronto le autovalutazioni dei partecipanti riguardo a malattie croniche cardiovascolari con i dati registrati dalle loro compagnie di assicurazione sanitaria. Una sorta di “prova del nove” per capire quanto possiamo fidarci delle informazioni auto-riferite. E credetemi, i risultati sono… illuminanti!
Perché questa fissa per l’accuratezza dei dati?
Forse vi starete chiedendo: “Ma che importanza ha se uno si ricorda o meno una diagnosi passata, o se la riporta con precisione millimetrica?” Beh, ha un’importanza enorme! Pensateci: le strategie di prevenzione, le terapie, la distribuzione delle risorse sanitarie… tutto si basa, in gran parte, su stime di prevalenza e incidenza delle malattie. Se queste stime sono “gonfiate” o “sgonfiate” da dati imprecisi, rischiamo di prendere decisioni sbagliate, con conseguenze che possono toccare tutti noi. Le malattie cardiovascolari, poi, sono la prima causa di morte a livello globale e rappresentano un costo gigantesco per i sistemi sanitari. In Germania, nel 2008, parliamo di quasi 37 miliardi di euro! Capite bene che avere dati puliti è fondamentale.
L’autovalutazione è un metodo comodo e poco costoso, certo. Non serve un medico o un ricercatore che ti interroghi per ore. Ma, come sospettavamo, può essere influenzata da un sacco di fattori:
- Fattori sociodemografici
- Quanto capiamo davvero la malattia
- Come percepiamo la sua gravità
- La voglia di apparire “socialmente desiderabili”
- Le risorse individuali (memoria, attenzione, ecc.)
Insomma, un bel pasticcio potenziale.
Lo studio LIFE-Adult: come hanno fatto?
I ricercatori dello studio LIFE-Adult hanno preso un gruppo di partecipanti (circa 1784 persone per questa analisi specifica, con un’età media di 58 anni, per il 55% donne) e hanno guardato cosa avevano dichiarato nei questionari riguardo a quattro “big” delle malattie cardiovascolari: ictus, fibrillazione atriale (FA), insufficienza cardiaca (IC) e infarto miocardico (IM). Poi, hanno chiesto i dati a due grosse compagnie di assicurazione sanitaria tedesche, che usano i codici ICD-10-GM (una classificazione internazionale delle malattie) per registrare le diagnosi. In pratica, hanno confrontato quello che la gente diceva di avere con quello che risultava ufficialmente.
Hanno usato un po’ di statistica per misurare l’accordo: sensibilità (quanto bene l’autovalutazione identifica chi ha davvero la malattia), specificità (quanto bene identifica chi NON ce l’ha), il mitico Kappa di Cohen (una misura generale di accordo), e i valori predittivi positivi e negativi. Non vi annoio con i dettagli tecnici, ma l’idea era capire se le due fonti di dati “parlassero la stessa lingua”.

I Risultati: Sorprese e Conferme
E qui viene il bello! Partiamo dalle buone notizie: la specificità era altissima per tutte e quattro le diagnosi (tra il 98% e il 99%). Questo significa che se una persona diceva di NON avere una di queste malattie, era quasi certamente vero. E ci mancherebbe, direte voi!
Ma la sensibilità… ah, la sensibilità! Qui le cose si sono fatte interessanti.
- Per l’ictus, la sensibilità era del 58%. Non male, ma nemmeno eccezionale.
- Per l’infarto miocardico, si attestava al 61%. Simile.
- Per la fibrillazione atriale, andava un po’ meglio, con il 65%.
E l’insufficienza cardiaca? Tenetevi forte: solo il 20%! Avete capito bene, solo una persona su cinque che risultava avere insufficienza cardiaca dai dati assicurativi l’aveva anche auto-dichiarata. Un vero e proprio “buco nero” dell’autovalutazione.
Il Kappa di Cohen, che ci dà una misura generale dell’accordo, confermava questo quadro: accordo “sostanziale” per ictus, FA e IM, ma “scarso” per l’insufficienza cardiaca. In generale, emergeva una tendenza all’underreporting: le persone tendevano a non riportare diagnosi che invece erano presenti nei database assicurativi. Per esempio, l’insufficienza cardiaca era auto-riferita dal 3.5% dei partecipanti, ma i dati assicurativi la indicavano nel 9.6%! Una bella differenza.
Perché queste discrepanze, soprattutto per l’insufficienza cardiaca?
Viene da chiedersi come mai l’insufficienza cardiaca sia così “dimenticata” o non riconosciuta. Gli autori dello studio avanzano qualche ipotesi, e devo dire che mi trovano d’accordo.
Innanzitutto, il termine “insufficienza cardiaca” potrebbe essere meno familiare rispetto a “ictus” o “infarto”, che sono eventi spesso più traumatici e ben impressi nella memoria. Inoltre, l’insufficienza cardiaca è più una sindrome che una singola diagnosi netta; i sintomi possono essere vari, sfumati, e la patogenesi è complessa. A volte, può essere persino asintomatica. E per confondere ulteriormente le acque, alcuni farmaci usati per l’IC sono gli stessi usati per l’ipertensione o dopo un infarto, quindi una persona potrebbe non sapere nemmeno di avere un’insufficienza cardiaca concomitante.
Pensate anche a come vengono poste le domande nei questionari. Forse il modo in cui si chiede se si ha una storia di insufficienza cardiaca andrebbe rivisto. Non è un dettaglio da poco!
Un altro aspetto cruciale emerso è che, a seconda della fonte di dati utilizzata (autovalutazione vs. dati assicurativi), anche le analisi sui fattori di rischio per una certa malattia possono dare risultati diversi! Per esempio, nello studio, l’associazione tra un BMI > 25 kg/m² e l’insufficienza cardiaca era quasi doppia se si usavano i dati auto-riferiti rispetto ai dati assicurativi. Questo ci fa capire quanto sia delicato basarsi su una sola fonte.
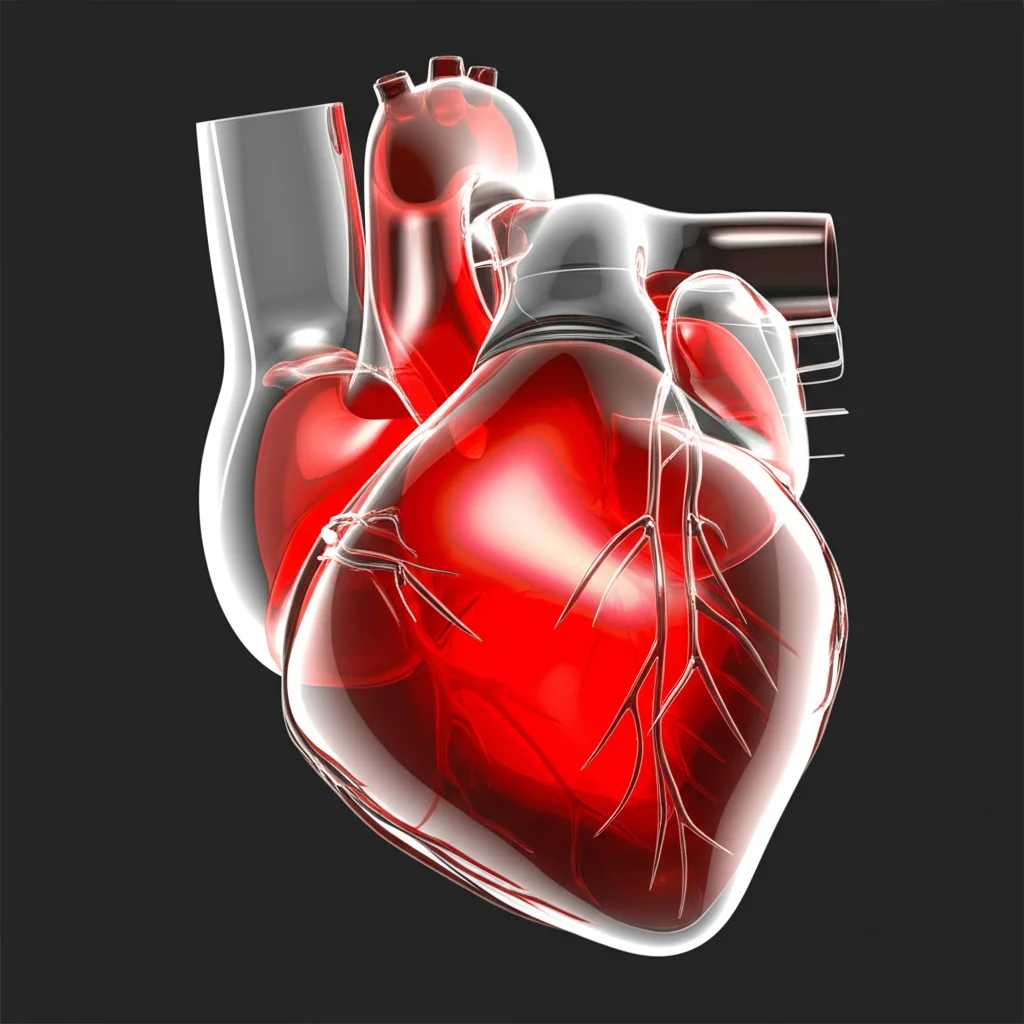
Cosa ci portiamo a casa da tutto questo?
Beh, diverse cose importanti, secondo me.
Primo: usare i dati delle assicurazioni sanitarie (almeno in Germania, con le loro normative sulla privacy) è un metodo fattibile per verificare l’accuratezza delle diagnosi auto-riferite. E questo è un gran passo avanti.
Secondo: l’accordo tra autovalutazioni e dati “ufficiali” varia parecchio a seconda della malattia. Ottimo per ictus, FA e IM, ma decisamente problematico per l’insufficienza cardiaca.
Terzo: l’underreporting è un fenomeno reale. Tendiamo a “sottostimare” le nostre condizioni.
Quarto, e forse il più importante: affidarsi a una singola fonte di dati può portare a risultati fuorvianti. L’ideale sarebbe incrociare le informazioni, specialmente per diagnosi complesse o meno “familiari” come l’insufficienza cardiaca.
Certo, anche i dati assicurativi non sono il “Vangelo”. Possono esserci errori di codifica, o informazioni su eventi molto vecchi potrebbero andare perse. Non esiste ancora un “gold standard” perfetto. Però, sono diagnosi fatte da professionisti sanitari, quindi hanno un grado di attendibilità elevato.
Questo studio, seppur con i suoi limiti (era un sottogruppo della coorte LIFE-Adult, i risultati non sono generalizzabili a tutta la Germania, ecc.), ci lancia un messaggio forte: nella ricerca epidemiologica, e forse anche nella pratica clinica, considerare più fonti di dati e essere consapevoli dei limiti dell’autovalutazione è cruciale per ridurre errori e migliorare la qualità delle nostre conoscenze.
Quindi, la prossima volta che compilate un questionario sulla vostra salute, cercate di essere il più accurati possibile! Ma per noi che lavoriamo con questi dati, la lezione è chiara: la verifica e l’integrazione delle fonti sono la strada maestra per avvicinarci un po’ di più alla verità. E voi, cosa ne pensate? Vi fidate ciecamente di quello che dichiarate sulla vostra salute? Fatemelo sapere!
Fonte: Springer







