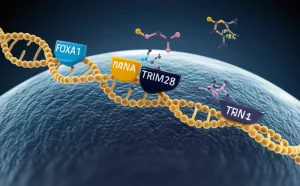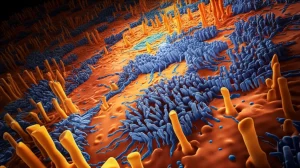Articoli Scientifici: Addio Autore Unico? Forse Non Ancora!
Siamo onesti, quando pensiamo alla ricerca scientifica oggi, ci vengono in mente team, collaborazioni internazionali, liste di autori lunghe chilometri. È vero, la scienza moderna è sempre più un gioco di squadra. La complessità delle domande che ci poniamo richiede spesso un mix di competenze, un approccio multidisciplinare che un singolo ricercatore difficilmente può padroneggiare da solo. E così, negli ultimi decenni, abbiamo assistito a un calo costante degli articoli scientifici firmati da un solo nome. Sembra quasi una specie in via d’estinzione, il “lupo solitario” della scienza.
La Forza del Gruppo: Perché Collaborare è Diventato Quasi la Norma
Ma perché questa tendenza? Beh, i motivi sono tanti. Come dicevo, i problemi scientifici sono diventati incredibilmente complessi. Pensate alle grandi sfide come il cambiamento climatico, la ricerca sul cancro o lo sviluppo di nuove tecnologie: richiedono esperti di settori diversissimi che uniscano le forze. Poi c’è la necessità di condividere risorse costose, come grandi infrastrutture di ricerca o set di dati enormi.
Aggiungiamoci la pressione accademica: il famoso detto “publish or perish” (pubblica o muori) si è quasi trasformato in “publish together or perish” (pubblica insieme o muori). Le università e i centri di ricerca spesso valutano la produttività anche in base al numero di collaborazioni, e diciamocelo, pubblicare in gruppo può far sembrare più “produttivi”, anche se il contributo individuale a volte è minimo. Non a caso, gli studi dimostrano che gli articoli frutto di collaborazioni, specialmente quelle internazionali, tendono ad avere un impatto maggiore, misurato in termini di citazioni. Insomma, collaborare conviene sotto molti punti di vista: amplia le possibilità investigative, migliora la qualità della ricerca e aiuta anche nella formazione dei nuovi scienziati.
Un Declino Esponenziale, Ma Non una Scomparsa
Di fronte a questa ondata di collaborazioni, che fine fanno gli articoli a autore unico? Beh, i dati parlano chiaro: il loro numero è in calo. Uno studio recente ha analizzato i dati dal 2000 al 2023 provenienti dal Web of Science (una delle più grandi banche dati di pubblicazioni scientifiche) e ha confermato questa tendenza. Anzi, sembra che il declino segua un modello matematico preciso, quello del decadimento esponenziale.
Cosa significa? Immaginate una curva che scende rapidamente all’inizio e poi sempre più lentamente, avvicinandosi a zero senza mai toccarlo veramente. Ecco, questa è l’idea. Gli articoli a autore unico diventano più rari, ma il modello stesso suggerisce che probabilmente non scompariranno mai del tutto. È una buona notizia per chi crede ancora nel valore del lavoro individuale!

Differenze tra Discipline: Non Siamo Tutti Uguali
Però, attenzione: questo declino non è uguale per tutti. Lo studio ha messo in luce differenze enormi tra i vari campi del sapere.
Prendiamo ad esempio l’Ingegneria Chimica o la Metallurgia: qui il calo degli autori singoli è stato rapidissimo. Sono discipline dove la ricerca applicata, i progetti su larga scala e le partnership con l’industria sono all’ordine del giorno, e la collaborazione è quasi indispensabile. Nel 2000, in Ingegneria Chimica, era comune vedere articoli con due autori; nel 2023, la norma era diventata cinque! Un andamento simile si osserva in Biologia, un campo sperimentale dove team con competenze diverse sono fondamentali.
Ma se ci spostiamo verso le Scienze Sociali o le Discipline Umanistiche, la musica cambia. In campi come la Storia o gli studi sul Teatro, il declino è stato molto più lento. Anzi, in queste aree, gli articoli a autore unico sono ancora la maggioranza! Hanno dominato per tutto il periodo 2000-2023 e continuano a superare numericamente quelli scritti a più mani. Questo riflette una tradizione di studio più individuale, magari più teorico o concettuale, meno dipendente da laboratori e grandi team. Anche in Matematica, pur classificata tra le Scienze Naturali, la tendenza è più lenta: nel 2000 dominavano gli articoli singoli, nel 2023 si è passati a una prevalenza di due autori.
Ma la Qualità? Il Lupo Solitario Colpisce Ancora
Ok, gli articoli singoli resistono, soprattutto in certi campi. Ma sono lavori “minori”? Contributi meno sostanziosi o pubblicati su riviste di secondo piano? Assolutamente no! Lo studio ha provato a rispondere anche a queste domande, analizzando due indicatori: il numero di riferimenti bibliografici (come stima indiretta della profondità e lunghezza dell’articolo) e il ranking delle riviste di pubblicazione.
Ebbene, i risultati sono sorprendenti:
- Numero di Riferimenti: Certo, negli studi sul Teatro la maggior parte degli articoli singoli aveva fino a 20 riferimenti. Ma in campi come Ingegneria Chimica, Biologia o Economia, la maggioranza degli articoli a autore unico citava tra 20 e 60 riferimenti. E non mancavano casi con oltre 100 citazioni, tipici magari di review approfondite, ma che dimostrano come un singolo ricercatore possa produrre lavori di ampio respiro.
- Qualità delle Riviste: Qui arriva il bello. Nel 2023, una fetta consistente di articoli a autore unico è stata pubblicata su riviste Q1, cioè quelle considerate nel top 25% per impatto nel loro settore. Parliamo di percentuali significative: oltre il 25% in Metallurgia (35%), Economia (29%), Biologia (30%), Immunologia (33%), Storia (33%), Legge (28%), Matematica (33%) e persino Astronomia e Astrofisica (ben 53%)! Questo dimostra che il lavoro individuale continua a trovare spazio nelle sedi più prestigiose. Certo, in media gli articoli con più autori hanno una probabilità leggermente maggiore di finire in Q1, ma la performance dei “solitari” è tutt’altro che trascurabile.

Perché Scegliere la Solitudine? Motivazioni e Vantaggi
Se la collaborazione è così vantaggiosa, perché alcuni ricercatori scelgono ancora di pubblicare da soli? Le ragioni sono diverse e molto umane.
Innanzitutto, c’è il desiderio di riconoscimento. In un articolo a autore unico, il merito è chiaro e tondo: è tutto tuo. Niente ambiguità, niente suddivisione del prestigio. Questo può essere particolarmente importante per i giovani ricercatori che cercano di “farsi un nome” e dimostrare la propria indipendenza e capacità. È un modo per costruire il proprio “capitale simbolico“, come direbbe il sociologo Bourdieu.
Poi c’è l’efficienza. Lavorare da soli può essere più rapido. Niente riunioni infinite per coordinarsi, niente attese per il feedback dei co-autori, niente compromessi sul contenuto o sullo stile. Si decide e si fa. Questo è particolarmente vero per lavori più teorici, concettuali, o per revisioni della letteratura (anche se per le revisioni sistematiche, oggi si raccomanda il lavoro di gruppo per evitare bias).
Infine, pubblicare da soli evita alcuni potenziali “lati oscuri” della collaborazione, come il fenomeno dell’honorary authorship (o guest authorship), cioè includere nomi che non hanno contribuito significativamente, o al contrario, il ghost authorship, cioè escludere chi ha dato un contributo importante (un problema più difficile da smascherare negli articoli a molti autori).
Un’ombra sulla Collaborazione?
Non dimentichiamo che la corsa alla pubblicazione e la pressione per collaborare possono portare anche a pratiche discutibili. L’iper-authorship (articoli con centinaia di autori) solleva questioni su come attribuire equamente il merito. Casi di autori “fantasma” o, al contrario, di “autori ospiti” inseriti solo per prestigio, minano l’integrità della ricerca. Pubblicare da soli, in un certo senso, è anche una dichiarazione di trasparenza sulla paternità del lavoro.
Quindi, Estinzione o Resilienza?
Tirando le somme, cosa possiamo dire? Che la previsione di una totale scomparsa degli articoli scientifici a autore unico, fatta già decenni fa, sembra essere stata prematura. Il declino è reale, misurabile e segue un andamento esponenziale, ma proprio questo modello ci dice che la “specie” è incredibilmente resiliente.
Gli articoli firmati da un solo ricercatore continuano ad essere pubblicati, mantengono una presenza forte in alcune discipline, raggiungono standard qualitativi elevati e rispondono a motivazioni profonde legate al riconoscimento individuale, all’efficienza e alla natura stessa di certi tipi di ricerca.
Certo, lo studio ha i suoi limiti (si basa su un database specifico, WoS, che potrebbe non coprire tutto, specialmente nelle scienze umane, e analizza un periodo di tempo definito), ma il messaggio è chiaro: il lupo solitario della scienza, anche se più raro, non ha ancora appeso il camice al chiodo. E forse, in un mondo scientifico sempre più orientato al team, la sua persistenza è un prezioso richiamo al valore insostituibile del pensiero e del lavoro individuale.
Fonte: Springer