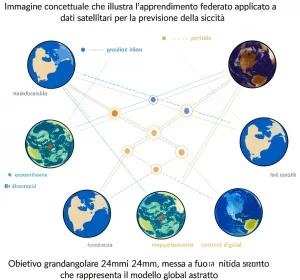Architettura Vedica: L’Antica Saggezza che Rivoluziona le Aule Moderne?
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi affascina da morire: come un sapere antico, millenario, possa trovare spazio e dare nuova linfa a un campo iper-moderno come l’architettura, specialmente nella sua formazione. Parliamo di Architettura Vedica (VA) e di come sta (o potrebbe) infiltrarsi nei curriculum universitari. Perché, diciamocelo, a volte l’educazione architettonica sembra un po’ scollegata dalla realtà, no? C’è bisogno di più sensibilità culturale, più attenzione all’ambiente, una visione più olistica del design sostenibile. E se la risposta, o almeno parte di essa, arrivasse proprio dal passato?
Recentemente mi sono imbattuto in una revisione sistematica della letteratura (SLR) davvero interessante, che ha scandagliato 25 anni di ricerche sull’integrazione dei principi vedici nell’educazione architettonica, analizzando ben 97 studi. L’obiettivo? Capire quali teorie dell’apprendimento vengono usate, dove si concentra la ricerca e, soprattutto, quali sono i “buchi” da colmare e le basi su cui costruire per il futuro.
Ma cos’è l’Architettura Vedica?
Forse vi state chiedendo cosa sia esattamente l’Architettura Vedica. Pensate a sistemi come il famoso Vastu Shastra, ma anche al Mayamata, al Manasara… sono principi che affondano le radici in testi antichissimi come i Veda, i Purana e gli Shilpa Shastra indiani. Non si tratta solo di estetica, ma di creare spazi in armonia con l’universo, con la natura, che promuovano il benessere di chi li abita. Concetti come l’orientamento dell’edificio, la disposizione delle stanze, l’uso di materiali naturali, la proporzione… tutto ha un significato profondo, legato a una visione cosmica e sostenibile. Integrare questa saggezza nell’educazione potrebbe formare architetti più consapevoli, capaci di unire tradizione e innovazione.
Le Teorie dell’Apprendimento in Gioco
La revisione ha messo in luce quattro teorie dell’apprendimento principali che dominano questo campo di studi. È interessante vedere *come* si cerca di insegnare questi principi antichi:
- Teoria dell’Apprendimento Esperienziale (ELT): È la superstar, presente nel 31% degli studi! Non mi sorprende: l’architettura è “fare”, è esperienza diretta. L’ELT, con il suo ciclo di esperienza concreta, osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta e sperimentazione attiva, si sposa benissimo con l’approccio pratico, quasi da apprendistato, tipico della trasmissione tradizionale della VA. Imparare facendo, toccando con mano.
- Teoria dell’Apprendimento Costruttivista (CLT): Segue a ruota con il 26%. Qui l’idea è che chi impara costruisce attivamente la propria conoscenza interagendo con l’ambiente e con gli altri. Perfetto per la VA, che richiede interpretazione personale e integrazione di aspetti filosofici e spirituali. Si impara collaborando, risolvendo problemi, contestualizzando.
- Teoria dell’Attività Storico-Culturale (CAT): Con il 24%, questa teoria sottolinea l’importanza del contesto sociale e culturale nell’apprendimento. Essendo la VA profondamente radicata nella cultura indiana, la CAT aiuta a capire come le interazioni sociali, gli strumenti culturali e il contesto storico modellino l’apprendimento e la pratica architettonica.
- Teoria dell’Apprendimento Trasformativo (TLT): Presente nel 19% degli studi, si concentra su come l’apprendimento possa portare a un cambiamento profondo di prospettiva. Nel contesto della VA, può significare mettere in discussione le proprie convinzioni sul design e sulla costruzione, aprendosi a nuovi modi di pensare, più olistici e spirituali.

Dove si Concentra la Ricerca (e Dove Manca)?
Analizzando i 97 paper, è emerso chiaramente che la maggior parte della ricerca (quasi il 56%!) si concentra sullo sviluppo di modelli educativi. C’è un grande sforzo nel creare framework teorici e pratici per insegnare la VA. Molto meno esplorate, invece, sono le fasi successive: il test di questi modelli (23.7%), il loro avanzamento (cioè come migliorarli, 15.5%) e, soprattutto, la loro integrazione con altre teorie o approcci (solo il 5%). Sembra che siamo bravi a ideare, un po’ meno a verificare sul campo e a far evolvere le nostre idee in modo sistematico.
Dal punto di vista del tipo di ricerca, quella empirica (basata su dati raccolti sul campo, 36.1%) è la più comune, seguita da studi basati sulla grounded theory (che genera teorie dai dati, 19.6%) e da case study (16.5%). Questo suggerisce una tendenza a voler validare gli approcci, anche se, come visto, la fase di testing dei modelli potrebbe essere potenziata.
I 6 Grandi “Buchi” nella Ricerca: Le Sfide Future
La revisione ha identificato 6 aree critiche dove la ricerca è ancora carente. Sono delle vere e proprie chiamate all’azione per ricercatori e accademici:
- Il Ponte tra Aula e Professione: Manca una chiara comprensione di come colmare efficacemente il divario tra formazione e pratica professionale reale, integrando tecnologie emergenti, sostenibilità, esigenze del settore e la saggezza della VA.
- Framework Contestualizzati: C’è bisogno di esplorare più a fondo framework educativi e approcci pedagogici specifici per i diversi contesti culturali ed educativi, per migliorare apprendimento, pensiero critico e applicazione pratica della VA.
- Impatto a Lungo Termine e Scalabilità: Non sappiamo abbastanza sugli effetti a lungo termine e sulla possibilità di applicare su larga scala l’integrazione di saperi tradizionali (come Vastu Shastra, Sulba Sutras) nei curriculum moderni, né sulle loro implicazioni sociali più ampie.
- Scambio Culturale e Influenze Coloniali: Serve un’analisi più profonda dello scambio culturale, delle influenze coloniali e del loro impatto sull’evoluzione dell’educazione architettonica, specialmente in contesti non occidentali come l’India, per creare framework più inclusivi.
- Pedagogia per l’Apprendimento Auto-Costruito (Online): C’è una carenza di ricerca sugli approcci pedagogici ottimali per favorire la conoscenza auto-costruita, il pensiero critico e l’apprendimento trasformativo, specialmente negli ambienti di apprendimento a distanza/online.
- Validazione Empirica: C’è una necessità impellente di più ricerca empirica per validare l’efficacia dei modelli e dei framework educativi proposti, specialmente in contesti educativi e con popolazioni studentesche diverse.

I Mattoni per Costruire il Futuro: 6 Fattori Chiave
Nonostante le lacune, la ricerca ha fatto emergere sei temi o fattori principali che ricorrono negli studi. Questi potrebbero essere i pilastri su cui costruire un futuro modello educativo olistico per la VA, che prepari davvero gli studenti alla professione:
- Approcci Pedagogici: Include apprendimento esperienziale, basato su problemi, su progetti, sul lavoro, costruttivista, sul campo, design-build, euristico, centrato sullo studente, trasformativo.
- Strumenti e Tecnologie Educative: Tecnologie immersive (ILT), Realtà Aumentata (AR), ICT, Ambienti CAD/CAE, Ambienti Simulati (SL), Virtual Design Studios (VDS).
- Risultati ed Impatti Educativi: Autonomia dello studente, capacità di problem-solving, pensiero critico, creatività e motivazione, abilità spaziali, consapevolezza e attitudini alla sostenibilità, orientamento alla carriera, impatti sulla pratica professionale.
- Sistemi di Conoscenza Architettonica Tradizionale: Vastu Shastra/Vidya, Mayamattam, Samarangana Sutradhar, Sulba Sutras, Principi di Architettura Vedica, design tradizionale iraniano, architettura dei templi del Kerala, case a corte (Haveli).
- Contesti ed Ambienti Educativi: Educazione architettonica formale, ambienti di apprendimento informale, studi di design, workshop ed escursioni, apprendimento online/a distanza, approcci interdisciplinari, collaborazione interculturale, coinvolgimento della comunità.
- Riforme e Sfide Educative: Sviluppo del curriculum, enti regolatori e politiche, colmare il divario educazione-pratica, adattarsi ai cambiamenti sociali, avanzamenti tecnologici, gestire i cambiamenti culturali, superare le barriere all’implementazione, scalabilità e impatti a lungo termine.
Questi sei fattori, con le loro variabili associate, offrono una mappa preziosa per chiunque voglia sviluppare un curriculum che integri l’Architettura Vedica in modo significativo e prepari gli architetti del futuro ad affrontare le sfide contemporanee con una marcia in più, quella che viene da una saggezza antica ma incredibilmente attuale.
In Conclusione
Questa immersione nella ricerca mi ha confermato una sensazione: l’Architettura Vedica non è solo un affascinante pezzo di storia, ma una potenziale fonte di innovazione per l’educazione e la pratica architettonica di oggi. Certo, la strada è ancora lunga, i “buchi” nella ricerca vanno colmati e i modelli vanno testati e affinati. Ma le basi ci sono, le teorie dell’apprendimento più adatte sono state identificate (con l’ELT e il CLT in testa) e i fattori chiave per costruire un curriculum efficace sono emersi. Integrare questi principi non significa tornare indietro, ma forse trovare un equilibrio più saggio e sostenibile tra modernità e tradizione, tra tecnologia e benessere umano. E voi, cosa ne pensate?

Fonte: Springer