COVID-19 Sotto la Lente: Segreti da 21.000 Pazienti (e l’Albumina che non ti aspetti!)
Ragazzi, parliamoci chiaro: il COVID-19 ha stravolto il mondo, causando milioni di morti e ricoveri. Anche se ormai ne sappiamo di più, restano ancora tante domande aperte sui fattori di rischio, sulla gravità della malattia e su come varianti e vaccini abbiano cambiato le carte in tavola. Ecco perché ci siamo messi sotto, analizzando una montagna di dati per capirci qualcosa di più.
Abbiamo esaminato le cartelle cliniche elettroniche di ben 21.312 pazienti che si sono presentati in pronto soccorso o sono stati ricoverati per COVID-19 in Texas Centrale, coprendo un periodo di due anni e mezzo, da marzo 2020 a settembre 2022. Un lavoro enorme, ma necessario per avere un quadro più completo.
Come abbiamo “sezionato” i dati?
Il nostro obiettivo era identificare delle “traiettorie cliniche”, cioè dei percorsi tipici che i pazienti seguivano durante la malattia. Per farlo, abbiamo usato un punteggio basato sulla scala dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), adattandola un po’. Questo punteggio teneva conto del bisogno di ossigeno e della gravità generale giorno per giorno.
Grazie a modelli statistici avanzati (roba da nerd, lo so, ma super utile!), siamo riusciti a identificare sei gruppi distinti di traiettorie (li chiameremo TG):
- TG1A: Pazienti con malattia lieve/moderata, visti in pronto soccorso ma non ricoverati o dimessi molto rapidamente. Praticamente l’82% del totale!
- TG1B: Pazienti gravi, ricoverati per un periodo medio (circa 7 giorni).
- TG1C: Pazienti gravi, ma con un ricovero più lungo (circa 11 giorni).
- TG2: Pazienti critici, dimessi entro 30 giorni (ricovero medio di 16 giorni).
- TG3: Pazienti critici, che però non venivano dimessi entro 30 giorni (ricovero medio di 39 giorni).
- TG4: Purtroppo, i pazienti che non ce l’hanno fatta entro 30 giorni (il 3,23% del totale, che sale al 7,73% tra i soli ricoverati e quasi il 18% tra i gravi/critici).
Questi gruppi si differenziavano non solo per la durata del ricovero, ma anche per il picco di gravità raggiunto e quanto tempo ci voleva per arrivarci.
Chi rischia di più? Demografia e fattori chiave
Analizzando i dati demografici, sono emerse alcune conferme e qualche spunto interessante.
L’età avanzata si conferma un fattore di rischio per l’esito fatale (TG4), mentre i più giovani tendevano a finire nel gruppo TG1A, quello più lieve. Ma attenzione: l’età non sembrava fare una grande differenza nel distinguere tra pazienti “solo” gravi (TG1B/1C) e quelli critici (TG2/TG3). Qui entravano in gioco altri fattori.
Il sesso maschile è risultato associato a esiti peggiori, con una maggiore rappresentanza nei gruppi più critici (TG3 e TG4). Anche questo dato è in linea con altri studi.
Un dato particolare riguarda l’etnia ispanica/latina: questi pazienti erano sovra-rappresentati nel gruppo TG3 (critici con lungo ricovero), ma non negli altri gruppi. Questo potrebbe essere legato a condizioni preesistenti come obesità o problemi cardiovascolari/renali, o forse a un accesso più tardivo alle cure, come suggerito da altre ricerche.
E i vaccini? Come prevedibile, la percentuale di vaccinati era significativamente più alta nel gruppo più lieve (TG1A) rispetto ai gruppi gravi/critici, confermando l’effetto protettivo contro le forme severe della malattia.

L’evoluzione nel tempo: le ondate e le varianti
Abbiamo suddiviso il periodo di studio in cinque “ondate”, basandoci sui picchi di casi segnalati nella contea, che corrispondevano grosso modo alla circolazione delle varianti Alpha/Beta, Delta e Omicron.
Cosa abbiamo notato? La percentuale di pazienti lievi (TG1A) è aumentata significativamente durante le ondate Delta e soprattutto Omicron (ondate 3, 4, 5) rispetto alle prime due. Anche se durante il picco Omicron (ondata 4) ci sono stati tantissimi casi totali, il numero assoluto di ricoveri gravi e critici (TG1B-TG4) è rimasto paragonabile a quello delle ondate precedenti. Questo suggerisce che Omicron, pur essendo molto contagiosa, causava mediamente una malattia meno severa, probabilmente grazie a una combinazione di minore virulenza intrinseca, vaccinazioni e immunità pregressa.
Di pari passo, abbiamo visto diminuire nelle ondate Omicron le diagnosi di polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), diabete di tipo 2 e ipertensione, così come le consulenze specialistiche (pneumologia, terapia intensiva, malattie infettive, nefrologia, neurologia).
Il legame inaspettato: COVID grave e problemi neuropsichiatrici
Una delle scoperte più interessanti riguarda il legame tra COVID-19 grave e problemi neurologici e psichiatrici. I pazienti nei gruppi più gravi (TG1B-TG4) avevano tassi significativamente più alti di diagnosi come:
- Malattia di Alzheimer
- Ictus cerebrale
- Epilessia, emicrania, mioclono
- Disturbi neurocognitivi (es. con corpi di Lewy)
- Emorragia intracerebrale non traumatica
- Parkinson, sindrome delle gambe senza riposo
- Disturbi dell’adattamento, da uso di sostanze
- Delirium, disturbi deliranti
- Episodi depressivi, disturbo d’ansia generalizzato, disturbo di panico, PTSD
- Disturbo schizoaffettivo, schizofrenia
Questi pazienti ricevevano anche più frequentemente TAC craniche. La cosa notevole è che, anche durante le ondate Omicron, la proporzione di pazienti gravi/critici che necessitavano di consulenze neurologiche e psichiatriche è rimasta costante. Questo suggerisce che le complicanze neuropsichiatriche sono una caratteristica persistente del COVID-19 grave, indipendentemente dalla variante circolante. Tuttavia, queste diagnosi non sembravano distinguere tra i gruppi critici (TG2 vs TG3) o tra critici e fatali (TG3 vs TG4), indicando che forse hanno un impatto minore sulla mortalità rispetto ai problemi cardiaci o respiratori, ma rimangono una preoccupazione clinica importante, potenzialmente legata anche al Long-COVID.
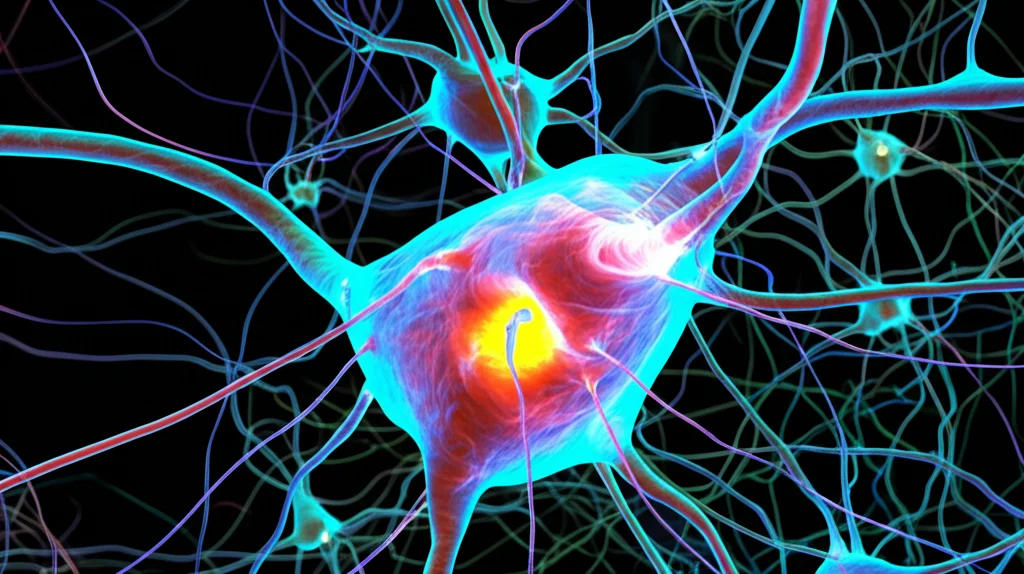
La vera star (negativa): l’Albumina bassa
Se dovessimo scegliere un singolo valore di laboratorio predittivo della gravità, questo sarebbe l’albumina. I livelli di albumina nel sangue erano uno dei migliori indicatori della traiettoria del paziente, sia all’ammissione che durante il ricovero. Più basso era il livello di albumina, più grave era il gruppo di appartenenza (TG1A aveva i livelli più alti, TG4 i più bassi).
Ora, l’albumina bassa (ipoalbuminemia) è un noto marcatore di infezione, infiammazione e malattia cronica in generale. Può essere dovuta a ridotta produzione da parte del fegato, aumentato consumo o perdita attraverso i vasi sanguigni. Ma nel contesto del COVID-19, associata a una maggiore frequenza di diagnosi di malnutrizione nei pazienti critici (specialmente TG3), punta dritta a un problema di insufficienza nutrizionale come fattore chiave negli esiti della malattia.
E qui casca l’asino: nonostante questo forte segnale, abbiamo scoperto che altri indicatori nutrizionali importanti (come Vitamina D, tiamina, vitamine del gruppo B – cruciali anche per la salute neurologica!) venivano controllati raramente. E le supplementazioni vitaminiche? Somministrate a meno del 20% dei pazienti in qualsiasi gruppo, e solo al 10% dei pazienti fatali (TG4)!
Questo solleva una domanda enorme: valutare e correggere lo stato nutrizionale (misurando albumina, pre-albumina, vitamine) fin dall’inizio potrebbe migliorare gli esiti dei pazienti con COVID-19? L’albumina ha anche effetti neuroprotettivi, antiossidanti e anticoagulanti documentati. La sua carenza potrebbe quindi contribuire anche alle complicanze neurologiche osservate. È un’area che merita sicuramente più attenzione!
Altri segnali dal sangue e non solo
Dal punto di vista immunologico, abbiamo confermato l’associazione tra malattia grave e alti livelli di neutrofili e granulociti immaturi, e bassi livelli di linfociti e monociti. Questi marcatori, però, distinguevano bene i gravi dai lievi, ma non i critici (TG3) dai fatali (TG4) al momento del ricovero, suggerendo che riflettono la gravità ma non necessariamente il rischio di morte imminente.
Abbiamo anche notato tassi più alti di sepsi, shock e immunodeficienze nei pazienti critici. Malattie autoimmuni come l’artrite reumatoide (RA) e le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) erano più rappresentate nei gruppi critici, supportando l’idea che alcune condizioni immunitarie predispongano a un COVID-19 più severo.
Infine, lo squilibrio acido-base era un’altra caratteristica dei gruppi più gravi. L’aumento dell’anion gap (una misura di questo equilibrio) era associato alla bassa albumina (che ha un ruolo tampone) e probabilmente a disfunzione renale o sepsi (che causa acidosi lattica). Anche qui, si crea un potenziale circolo vizioso: i reni non funzionano bene, l’albumina cala, l’equilibrio acido-base salta, e questo può peggiorare la funzione di molti organi, cuore in primis (infatti, i problemi cardiaci aumentavano progressivamente fino al gruppo fatale TG4).
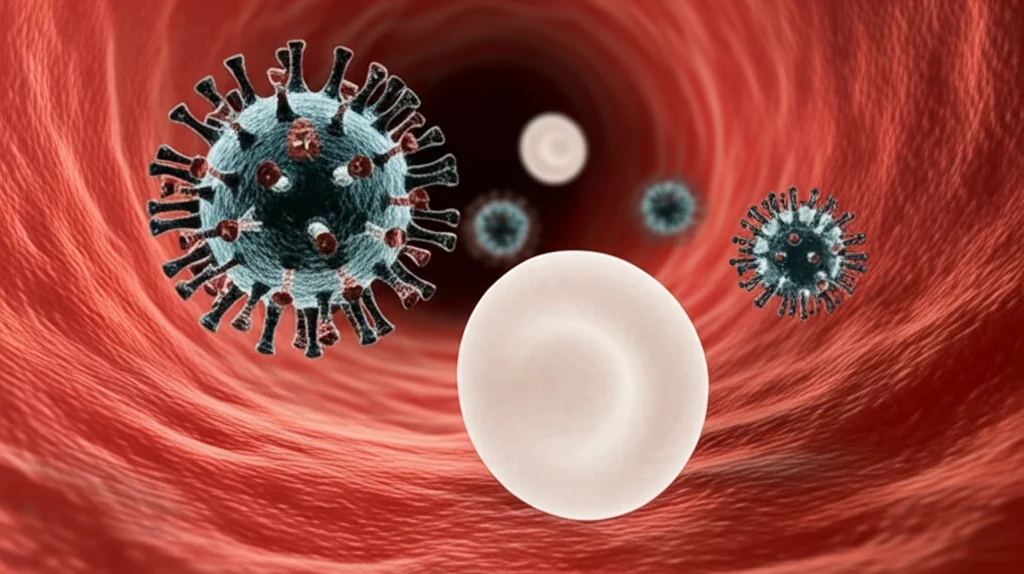
Cosa ci portiamo a casa?
Questo studio, pur con i suoi limiti (dati da un solo sistema sanitario, possibili imprecisioni nelle cartelle cliniche), ci offre uno spaccato dettagliato dei fattori che influenzano la gravità del COVID-19 in pazienti che arrivano in pronto soccorso o vengono ricoverati.
I messaggi chiave sono:
- Il COVID-19 grave è una malattia multi-sistemica, non solo respiratoria.
- Le complicanze neuropsichiatriche sono frequenti e persistenti nei casi gravi, anche con varianti più “miti”.
- L’insufficienza nutrizionale, segnalata da bassi livelli di albumina, è un fattore di rischio cruciale e probabilmente sottovalutato e sotto-trattato.
- Identificare queste “firme” cliniche (demografiche, di laboratorio, diagnostiche) potrebbe aiutare i medici a prevedere meglio la traiettoria del paziente e a personalizzare le cure.
C’è ancora tanto da capire, ma speriamo che queste scoperte stimolino una maggiore attenzione verso gli aspetti nutrizionali e neuropsichiatrici nella gestione del COVID-19, sia in ospedale che dopo la dimissione. Potrebbe fare davvero la differenza per molti pazienti.
Fonte: Springer







