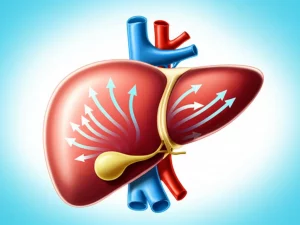Ginocchio Bionico: Amico o Nemico all’Inizio? La Verità sull’Adattamento (che Nessuno ti Dice)
Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi ha davvero incuriosito: come ci si adatta a quelle meraviglie della tecnologia che sono le protesi di ginocchio a microprocessore attive, o AMPK per gli amici. Sapete, quelle che non solo sostituiscono un arto, ma cercano di replicarne attivamente le funzioni. Sembra fantascienza, vero? Eppure, la realtà è un po’ più complessa di un semplice “attacca e vai”. Mi sono imbattuto in uno studio recente che ha cercato di far luce proprio su questo aspetto, e le scoperte sono… beh, diciamo che aprono un bel dibattito!
La sfida dell’amputazione transfemorale e l’evoluzione delle protesi
Prima di tuffarci nello studio, facciamo un passo indietro. Perdere una gamba sopra il ginocchio, un’amputazione transfemorale, è un evento che stravolge la vita. Immaginatevi: non solo perdete il ginocchio, ma anche la caviglia. Camminare, fare le scale, persino alzarsi da una sedia diventa una sfida enorme. La qualità della vita, l’autostima, tutto ne risente. Per fortuna, la tecnologia protesica ha fatto passi da gigante. All’inizio c’erano le protesi passive, meccaniche o con controllo fluidico, le più economiche ma anche le più limitate. Poi sono arrivate le PMPK (passive microprocessor-controlled knees), già un bel salto in avanti, con sensori che regolano la resistenza del ginocchio per movimenti più fluidi. Ma anche queste, per azioni come salire le scale o alzarsi, dipendono interamente dalla forza dell’utente.
E qui entrano in gioco le AMPK, le protagoniste del nostro discorso. Questi gioiellini tecnologici hanno un motore! Possono generare forza, assistere attivamente l’utente nel salire le scale, camminare in pendenza, riducendo la fatica e aumentando la velocità. Figo, no? Certo, questa tecnologia ha un costo, sia in termini economici che di peso della protesi. Ma i benefici in termini di simmetria della camminata, riduzione del rischio di cadute e minor stress sull’arto sano sono notevoli.
L’adattamento: una maratona, non uno sprint
Il punto cruciale, però, è l’adattamento. Anche con le protesi passive ci vogliono settimane, se non mesi, per imparare a usarle bene. Con le PMPK e le AMPK, la curva di apprendimento può essere ancora più ripida. Uno studio precedente ha mostrato che per abituarsi a una nuova protesi passiva di caviglia-piede ci vogliono circa 4 mesi. Ma per le AMPK? C’era un vuoto nella letteratura scientifica, soprattutto per periodi di adattamento superiori a una o due settimane.
Ed è qui che si inserisce lo studio che ha catturato la mia attenzione: “User accommodation to an active microprocessor-controlled knee in individuals with unilateral transfemoral amputation: a 5-week non-randomized trial”. L’obiettivo? Capire come le persone con amputazione transfemorale si adattano a un AMPK (nello specifico il Power Knee™ di Össur) nel corso di 5 settimane, confrontandolo con la loro protesi abituale.
Come si è svolto lo studio? Un’ora alla settimana per 5 settimane
Sette partecipanti, con un’età media di 53 anni, hanno accettato la sfida. Una volta alla settimana, per cinque settimane, si sono recati in laboratorio. Lì, eseguivano una serie di test sia con la loro protesi corrente (che poteva essere passiva o PMPK) sia con l’AMPK. I test erano pensati per simulare attività quotidiane:
- L-test: un test di agilità che include camminata, giri e superamento di piccoli ostacoli.
- Camminata in pendenza: 2 minuti su tapis roulant con inclinazione del 10%.
- Camminata in piano (2MWT): 2 minuti su tapis roulant.
- Camminata in piano con doppio compito (dual-2MWT): come sopra, ma mentre si eseguivano sottrazioni seriali (tipo “sottrai 7 da un numero a tre cifre, continuamente”). Questo per testare l’impegno cognitivo.
Durante i test, venivano misurati parametri oggettivi come il tempo impiegato, la distanza percorsa, la frequenza cardiaca, e l’accuratezza nelle sottrazioni. Ma si raccoglievano anche dati soggettivi: percezione dello sforzo, fatica, comfort e carico di lavoro percepito tramite scale validate.

L’ipotesi dei ricercatori era che, all’inizio, i partecipanti sarebbero andati meglio con la loro protesi abituale, ma che con il passare delle settimane le prestazioni con l’AMPK sarebbero migliorate, fino a raggiungere o superare quelle della vecchia protesi.
I risultati: luci e ombre sull’AMPK (almeno all’inizio)
E qui arrivano le sorprese. Contrariamente alle aspettative di un rapido miglioramento, i risultati hanno mostrato un quadro più complesso.
L-test: I partecipanti ci mettevano significativamente più tempo a completare l’L-test con l’AMPK rispetto alla loro protesi abituale (in media quasi 8 secondi in più!). E questa differenza non è diminuita nel corso delle 5 settimane. Dal punto di vista soggettivo, con l’AMPK riportavano maggiore fatica, minore comfort e una percezione dello sforzo più alta.
Camminata in pendenza: Nessuna differenza significativa nella velocità di camminata. Tuttavia, nella terza sessione, la frequenza cardiaca era più alta con l’AMPK.
Camminata in piano: Nessuna differenza significativa né nella velocità né nella frequenza cardiaca.
Camminata con doppio compito: Qui le cose si fanno interessanti. La velocità di camminata era significativamente più bassa con l’AMPK. Però, attenzione: il numero di risposte corrette alle sottrazioni seriali era maggiore con l’AMPK nelle sessioni 2 e 4! Sembra quasi un controsenso: cammino più piano, ma sono più concentrato sul compito cognitivo. I ricercatori ipotizzano un “trade-off cognitivo”: forse i partecipanti dedicavano più risorse mentali al compito secondario (le sottrazioni) a scapito di quello primario (la camminata).
In generale, per la camminata in pendenza, in piano e con doppio compito, non sono emerse differenze significative nel comfort, nella fatica o nella percezione dello sforzo tra le due protesi. Questo suggerisce che, anche con un tempo di adattamento limitato, l’AMPK si è comportata in modo paragonabile alla protesi attuale in questi specifici compiti.
Perché queste difficoltà iniziali con il “ginocchio bionico”?
Vi starete chiedendo: ma come, un ginocchio super tecnologico e all’inizio vado peggio? Gli autori dello studio suggeriscono alcune spiegazioni. Innanzitutto, il tempo di adattamento limitato. Cinque sessioni da un’ora ciascuna potrebbero semplicemente non essere sufficienti per imparare a “dialogare” con una tecnologia così avanzata e per sfruttarne appieno il potenziale. Pensateci: è come passare da una bicicletta a una moto sportiva; serve pratica!
Poi c’è il peso. Le AMPK, pur essendo progettate per compensare il loro peso extra grazie al motore, sono comunque più pesanti delle protesi tradizionali (nello studio, la differenza di peso variava da 690g a 1650g). Questo potrebbe aver contribuito alla maggiore fatica percepita, specialmente in test più dinamici come l’L-test.
È anche interessante notare la debole correlazione tra le misure oggettive (tempo, velocità) e quelle soggettive (comfort, fatica). Questo ci dice che come una persona si sente mentre usa una protesi non riflette necessariamente come sta performando, e viceversa. Entrambi gli aspetti sono fondamentali per valutare l’esperienza complessiva dell’utente.

Cosa ci portiamo a casa da questo studio?
La conclusione principale, a mio avviso, è che l’adattamento a un AMPK è un processo che richiede tempo, molto probabilmente più delle 5 ore totali di utilizzo osservate in questo studio. Non è una bacchetta magica. Le aspettative devono essere realistiche: all’inizio potrebbero esserci delle difficoltà, un aumento della fatica e una riduzione del comfort in certe attività.
Questo studio, seppur con un piccolo numero di partecipanti, è prezioso perché inizia a colmare una lacuna. Sottolinea la necessità di ricerche future con campioni più ampi, periodi di utilizzo continuativo della protesi (non solo un’ora a settimana in laboratorio) e un monitoraggio più lungo dell’adattamento. Sarebbe fantastico vedere studi che seguono gli utenti per mesi, magari includendo anche attività più complesse come salire le scale in contesti reali.
Insomma, la strada verso una simbiosi perfetta tra uomo e macchina, anche nel campo delle protesi, è ancora in divenire. Le AMPK hanno un potenziale enorme, ma dobbiamo capire meglio come supportare gli utenti nel loro percorso di apprendimento per massimizzare i benefici e migliorare la loro qualità di vita. E chissà, magari con il giusto training e tempo, quel “ginocchio bionico” passerà da “nemico iniziale” a “migliore amico” per la mobilità!
Fonte: Springer